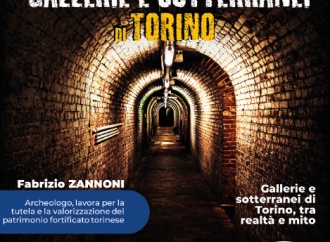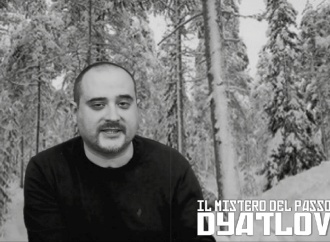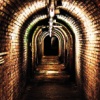Di seguito potete trovare l'elenco dei gruppi locali del CICAP. Per qualsiasi informazione potete contattare la Responsabile del coordinamento gruppi: Elisa Tealdi ([email protected] ).
Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2023
Vuoi rimanere informato sulle attività nella tua regione? Clicca qui per scoprire come fare!
Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2023
- Gruppo Abruzzo Molise - Coordinatore: Francesco Ruggirello
- Gruppo Calabria - Coordinatore: Giovanni Paola
- Gruppo Campania - Coordinatore: Giuseppe Di Nuzzo
- Gruppo Emilia Romagna - Coordinatore: Matteo Matulli
- Gruppo Friuli Venezia Giulia - Coordinatore: Enrico Smargiassi
- Gruppo Pordenone - Coordinatore: Diego Martin
- Gruppo Lazio - Coordinatore: Stefano Ruia
- Gruppo Marche - Coordinatore: Luca Pellegrini
- Gruppo Piemonte - Coordinatore: Daniele Biglino
- Gruppo Cuneo - Coordinatore: Stefano Macchetta
- Gruppo Puglia - Coordinatore: Armando De Vincentiis
- Gruppo Sardegna - Coordinatore: Stefano Demurtas
- Gruppo Sicilia - Coordinatrice: Fara Di Maio
- Gruppo Toscana - Coordinatore: Andrea Sabbatini
- Gruppo Umbria - Coordinatrice: Licia Micheli
- Gruppo Valle d'Aosta - Coordinatore: Paolo Ciambi
- Gruppo Veneto - Coordinatore: Davide Grossato
- Gruppo Ticino (CH) - Coordinatore: Ivo Silvestro
Vuoi rimanere informato sulle attività nella tua regione? Clicca qui per scoprire come fare!