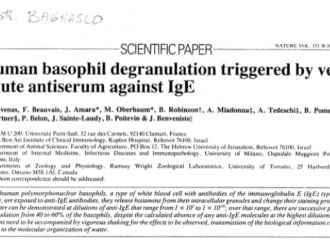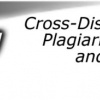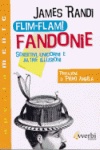Non esiste un criterio generale che descriva i casi di scienza patologica. Tuttavia si possono individuare alcuni punti comuni a molti episodi. Le false idee nascono spesso da una errata attribuzione di un meccanismo di causa ed effetto. Spesso cioè, effetti del tutto casuali vengono attribuiti a cause che in realtà non c'entrano nulla. Talvolta l'effetto che si crede di aver osservato è talmente debole da non essere significativo e ciò nonostante viene considerato reale. In altri casi poi il ricercatore effettua inconsapevolmente una selezione dei dati, prendendo in considerazione solamente quelli che corroborano le proprie convinzioni, trascurando invece quelli che le contraddicono.
Nei casi di scienza patologica gioca un ruolo essenziale la psicologia del singolo ricercatore. Può però anche accadere che diversi ricercatori si convincano, per vari motivi, della validità di quanto proposto da un collega e finiscano in tal modo per alimentare una sorta di autoinganno collettivo.

Un altro caso clamoroso di abbaglio collettivo fu quello della poliacqua. A cominciare dal 1962 nella comunità scientifica si cominciò a parlare di una ipotetica forma polimerica dell'acqua, la poliacqua appunto[4]. Principale sostenitore di tale idea fu Boris Derjagin, allora direttore dell'Istituto di Chimica-Fisica di Mosca. Molti altri ricercatori in tutto il mondo si convinsero dell'esistenza della poliacqua e passò quasi un decennio per rendersi conto che la fantomatica sostanza altro non era se non normalissima acqua contaminata da vari inquinanti dovuti ai metodi con i quali veniva ottenuta. Come ebbe a dire uno dei protagonisti: «la vicenda della poliacqua è stata una poliballa».
Numerosi sono i casi in cui i protagonisti, pur essendo in perfetta buona fede, sono stati vittime di abbagli e false credenze che sicuramente hanno avuto conseguenze disastrose. La storia della medicina offre, a questo proposito, alcuni esempi significativi. La teoria ippocratica-galenica, secondo la quale la salute derivava da un equilibrio (eucrasia) di quattro umori (sangue, flemma, bile gialla e bile nera), sopravvissuta fino al tardo Rinascimento, ha determinato pratiche mediche a dir poco agghiaccianti. Qualsiasi tipo di malattia veniva curato con le stesse tecniche terapeutiche: salassi, emetici, purganti, sudoriferi, che secondo le intenzioni dei medici avrebbero dovuto ristabilire l'equilibrio tra i quattro umori, perduto a causa della malattia. Dalla stessa teoria umorale, derivava anche la pratica di produrre suppurazione nelle ferite mediante l'applicazione di olio bollente. Tale pratica perdurò fino a metà del Cinquecento, quando il medico Ambroise Paré si accorse, casualmente, che i pazienti non trattati con olio bollente stavano molto meglio di quelli sottoposti alla terrificante terapia.
Altri abbagli clamorosi si ebbero tra il Settecento e l'Ottocento con il mesmerismo e la frenologia.
Franz A. Mesmer[5], un singolare medico-mago austriaco, sosteneva di riuscire a guarire i suoi pazienti strofinandoli con magneti. In un primo tempo i suoi magneti erano di ferro e di acciaio, ma successivamente egli affermò che funzionavano altrettanto bene anche i "magneti" di legno.
La frenologia, sviluppata soprattutto da Franz J. Gall, affermava che era possibile leggere i tratti della personalità di un individuo dai contorni anatomici del suo cranio. Una teoria analoga venne sviluppata nel campo dell'antropologia criminale da Cesare Lombroso, verso la fine dell'Ottocento.
In epoca più recente vi sono stati altri casi. Ad esempio quello del chimico fisico fiorentino Giorgio Piccardi (1895-1972) che credette di scoprire un'influenza del sole, in realtà inesistente, sul decorso di alcune reazioni chimiche[6].
Nel 1988 fece clamore il celebre caso della "memoria dell'acqua" che vide protagonista il biologo francese Jacques Benveniste (1935-2004) e che alimentò le speranze di tanti omeopati di vedere finalmente dimostrata una base scientifica per la loro disciplina[7]. Purtroppo per Benveniste e per gli omeopati, la memoria dell'acqua risultò essere una colossale bufala. Pare che Benveniste fosse in totale buona fede, cosa che non si può dire però di alcuni suoi collaboratori. Ricordiamo che a Benveniste venne assegnato per ben due volte il premio satirico IgNobel per le ricerche più bizzarre a strampalate.
Il pregiudizio può giocare brutti scherzi in campo scientifico secondo due diverse modalità. Da un lato esso può far credere, erroneamente, di trovarsi di fronte a una vera e propria grande scoperta che, in realtà, non esiste (come nel caso dei raggi N, della poliacqua o della memoria dell'acqua). Dall'altro può impedire di accorgersi di una vera scoperta innovativa, perché obbliga a rimanere ancorati a teorie vecchie, universalmente accettate dall'establishment scientifico del tempo. Esistono diversi esempi di questo secondo effetto del pregiudizio.
Nel 1733, padre Gerolamo Saccheri, della Compagnia di Gesù, pubblicò l'opera Euclides ab omni naevo vindicatus. In tale opera l'autore scoprì una serie di teoremi che costituiscono la base di quella branca della geometria non euclidea, chiamata iperbolica, che verrà formulata più di un secolo dopo da Lobacevskij e Bolyai. Saccheri, tuttavia, non si rese affatto conto della propria scoperta in quanto pensava che non potesse esistere nessun'altra geometria al di fuori di quella euclidea. Nello stesso settore anche il "princeps mathematicorum" Karl Friedrich Gauss fu vittima di pregiudizi ed eccesso di prudenza. Egli si rese perfettamente conto della possibilità dell'esistenza delle geometrie non euclidee, prima di Lobacevskij. Ma si guardò bene dal pubblicare alcunché sull'argomento, per timore, come lui stesso affermò, degli "strilli dei beoti", ovvero delle reazioni del mondo matematico contemporaneo.
Anche due mostri sacri della scienza del secolo scorso non sfuggirono ai loro pregiudizi. Albert Einstein e Ervin Schrödinger, che pure diedero fondamentali contributi alla nascita della meccanica quantistica, rifiutarono fino alla morte di accettare le implicazioni ultime di tale teoria, poiché troppo ancorati alla concezione deterministica della realtà, tipica della fisica classica.