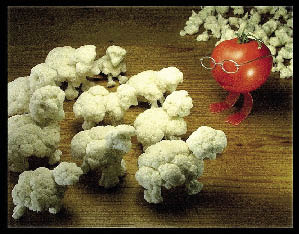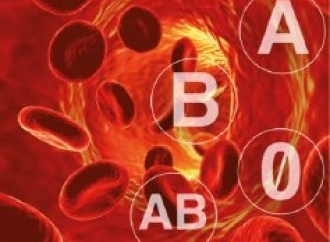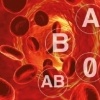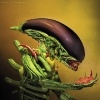Oltre il classico «insalataro»
Il reparto della frutta e della verdura è uno dei miei preferiti, anche per via degli odori e dei colori dei prodotti. E fra tutti lo scaffale dei pomodori è quello davanti al quale passo più tempo, guardando gli ortaggi (botanicamente sono dei frutti, lo sapevate?) dalle forme più diverse. Quando preparo la caprese aggiungo alla mozzarella di bufala dei “cuore di bue”, mentre per condire la pasta o insaporire il fegato saltato con il peperoncino uso i cosiddetti “Pachino”, che sembrano grosse ciliegie. Ormai il termine è diventato sinonimo di quel tipo di pomodoro. Vediamo perché.
Sino alla fine degli anni ottanta nelle case degli italiani si consumavano quasi esclusivamente i classici pomodori “insalatari”, di forma e grandezza variabili e di colore dal verde al rosso. Quelli piccoli a grappolo non si trovavano al supermercato, e neppure quelli chiamati “ciliegino”, che invece ora sono diventati popolarissimi e molto ricercati. Pomodori di quel tipo, a volte di colore giallo-rossastro, venivano coltivati prevalentemente negli orti familiari del Meridione e definiti “da serbo”, perché venivano appesi a grappoli al riparo dalle intemperie e conservati per il consumo invernale.
Oggi al supermercato troviamo una grande varietà di pomodori, tra i quali spiccano quelli provenienti da Pachino, una cittadina in provincia di Siracusa dove si produce un pomodoro che dal 2003 può addirittura fregiarsi del marchio IGP (indicazione geografica protetta). In quell’area, che comprende Pachino e alcuni paesi limitrofi, il clima, la temperatura, il suolo, la posizione e la salinità dell’acqua di irrigazione sono particolarmente adatti a produrre uno dei vanti dell’agroalimentare siciliano e italiano: il “pomodoro di Pachino[1]”. Con questo termine il consumatore identifica ormai il classico “ciliegino”. In realtà il marchio IGP definisce solo la zona di produzione: tra i vari tipi di pomodori di Pachino ci sono infatti anche il classico costoluto e quello a grappolo.
L’arrivo del ciliegino
La domanda di registrazione dell’IGP rivela che nella zona di Pachino la coltivazione dei pomodori comincia nel 1925, soppiantando gradatamente quella della vite lungo la fascia costiera. Le prime esperienze rivelano che gli ortaggi maturano con un anticipo di 15-20 giorni rispetto ad altre zone di produzione. Tuttavia il clima dell’area, soggetto a sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte, provoca talvolta la distruzione di intere colture. A partire dagli anni sessanta la diffusione delle serre consente di mettere a punto un sistema per anticipare la coltivazione e la raccolta del pomodoro[2].
In quegli anni si coltivano prevalentemente pomodori a frutto grosso. Ma non saranno le antiche varietà locali, come qualcuno pensa, a portare al successo il pomodoro di Pachino. Nel 1989 l’azienda sementiera israeliana Hazera Genetics introduce in Sicilia (attraverso la Comes Spa, divenuta poi Cois 94 Spa) due nuove varietà di pomodori: il ciliegino Naomi e il Rita a grappolo[3].
La prima reazione a queste nuove tipologie è di rifiuto:
«L’introduzione del ciliegino fra le tipologie coltivate in serra ha inizialmente trovato forti ostacoli da parte dei produttori. Questi non gradivano l’inserimento di “novità” in grado di alterare l’equilibrio derivante dalla diffusione di cultivar che non fossero quelle del tradizionale pomodoro italiano “insalataro“ destinato al consumo fresco.
Inoltre, le pur scarse esperienze realizzate in serra avevano dimostrato che il ciliegino non era paragonabile, per le rese, alle altre cultivar utilizzate e, soprattutto, non trovava gradimento presso i mercati, per cui il prodotto rimaneva invenduto[4]».
Franco Rubino Schilirò, direttore commerciale dell’azienda sementiera Cois 94, ricorda che «il pomodoro da insalata allora in Italia era solo verde e per due anni ci sono stati grandi problemi a far accettare le nuove tipologie sui mercati nazionali. Insistendo, il successo è stato strepitoso e la crescita commerciale esponenziale[5]». Nel giro di pochi anni questi prodotti hanno raggiunto un’enorme popolarità e sono entrati nelle case di tutti gli italiani. La tipologia ciliegino è diventata così sinonimo di pomodoro di Pachino. Il successo dei semi di Hazera è proseguito negli anni successivi con altre varietà, come il datterino Lucinda e il ciliegino Shiren. Ben presto anche altre aziende sementiere, quasi sempre straniere, hanno cominciato a sviluppare varietà analoghe, a grappolo o ciliegino, come il Cherry Wonder di Asgrow o il Conchita di De Ruiter Seeds.
Determinante per il successo di questi pomodori è stata l’introduzione, da parte delle aziende sementiere, di due geni chiamati rin e nor (ripening inibitor e no ripening), che permettono di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di due o tre settimane dopo la raccolta.
Per potersi conservare nel tempo i precedenti pomodori da insalata dovevano essere raccolti prima che cambiassero colore dal verde al rosato. I ciliegino invece si possono raccogliere quando sono rossi e completamente maturi. Inoltre, le aziende sementiere sono riuscite a trasferire nelle loro varietà i geni di resistenza a varie patologie e parassiti, perciò il ciliegino richiede meno trattamenti antiparassitari. I pomodori di Pachino si trovano quasi tutto l’anno. Si sente spesso dire che si dovrebbero preferire i vegetali di stagione. Questo però a volte si scontra con le esigenze degli agricoltori, per i quali produrre tra giugno e agosto, quando l’offerta è alta e i prezzi sono più bassi, non comporta nessuna convenienza economica. Per loro è meglio mettere in vendita i pomodori a fine anno, nel periodo più remunerativo.
Semi da ricomprare
I semi di questi pomodori sono ibridi F1, come tanti altri sviluppati dalla ricerca scientifica delle aziende sementiere negli ultimi decenni. Questo significa che ogni anno gli agricoltori devono ricomprare i semi ibridi registrati per non perdere le caratteristiche agronomiche desiderate. Anzi, ormai gli agricoltori comprano direttamente le piantine dal vivaio, visto il costo delle sementi. L’origine estera dei semi non è un’eccezione nel panorama agroalimentare italiano: sfogliando il catalogo delle varietà vegetali registrate nell’Unione europea si scopre che molti altri prodotti italiani derivano da semi registrati da aziende straniere[6]. In passato erano gli agricoltori stessi a creare nuove varietà, selezionando e incrociando i migliori esemplari trovati nei campi, magari derivanti da mutazioni casuali. Oggi per produrre una nuova varietà agricola servono molti anni, e a volte decenni, di investimenti e ricerca scientifica biotecnologica avanzata.
C’è chi si sente minacciato dai semi forestieri. Nel maggio del 2002 un deputato italiano, Pier Paolo Cento, ha addirittura presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere ai suoi colleghi della Camera
«quali provvedimenti intendano intraprendere per favorire la produzione italiana di questi semi, di origine controllata e a prezzi ridotti, per salvaguardare la manodopera e il lavoro di tanti coltivatori italiani di questo prodotto, nello specifico della Sicilia, che non si troverebbero più legati a un monopolio straniero e per giunta all’andamento di una guerra[7]».
Nell’agosto 2010 il ministro dell’Agricoltura Giancarlo Galan, parlando dell’importanza della ricerca in campo agricolo, ha affermato che il pomodoro di Pachino è stato creato in Israele e poi trapiantato in Sicilia[8]. Molti si sono stupiti: «È mai possibile che un prodotto tipico italiano abbia un’origine straniera?» Certamente, come abbiamo visto. Hazera è un’azienda sementiera che fa ricerca anche nel campo degli OGM[9], ma il ciliegino Naomi, il pomodoro a grappolo Rita e i semi più recenti sono stati ottenuti con altre tecniche biotecnologiche, come la mas[10] e le colture cellulari, e non hanno nulla a che fare con gli organismi transgenici. Molti però hanno pensato erroneamente che si volesse sostenere che i pomodori di Pachino fossero OGM, quindi sono seguite smentite a raffica[11]. Il presidente del consorzio di tutela ha dichiarato addirittura: «Smentisco in maniera categorica la notizia secondo la quale le varietà di pomodoro di Pachino IGP oggi coltivate siano quelle create negli anni settanta [...] da laboratori di genetica israeliani». Questa è una smentita che non smentisce nulla, perché in effetti oggi il Naomi non è più in commercio, sostituito da nuove varietà, discendenti da quel primo pomodorino di successo. Insomma, la confusione regna sovrana in questo campo. Il 6 settembre 2010, nei giorni immediatamente successivi alla polemica suscitata dalle dichiarazioni del ministro Galan, ho pubblicato un articolo per cercare di chiarire la questione e spiegare l’origine di quei semi[12]. Alcuni lo hanno ripreso con titoli come questo: «Il pomodoro di Pachino? È un OGM e viene da Israele[13]»!
Mi sono cascate le braccia. Allora mi sono chiesto come mai nascano tali equivoci. Il fatto è che, quando riceviamo un’informazione, la “incaselliamo” in una cornice più ampia già formata e sedimentata nel nostro cervello. Cioè, la interpretiamo alla luce di una serie di altre nozioni e convinzioni che, almeno inizialmente, non mettiamo in discussione. Nel caso dei pomodori di Pachino, io credo che l’equivoco nasca dal fatto che alcune persone abbiano cercato di “dare significato” alla notizia ricevuta e ad alcune “parole chiave”. Hanno sentito parlare di un’azienda chiamata Hazera Genetics, di geni “inseriti” o “trasferiti”, di ricerca scientifica, di scienziati e di laboratori. Questi termini vengono filtrati alla luce della convinzione, tuttora molto diffusa, che gli agricoltori seminino nel campo ciò che “la natura ci ha dato”, tutt’al più selezionando le piante migliori e riseminandole l’anno successivo. Pochi immaginano che entrino in gioco scienziati, geni, genetica e DNA. Diversi studi hanno dimostrato che la maggioranza degli italiani (e degli europei) pensa che solo gli OGM contengano i geni[14].
Contro questi preconcetti, o se preferite “idee precostituite”, vanno a cozzare le parole chiave che citavo prima, creando un cortocircuito. La maggior parte delle persone ignora che ormai le nuove varietà vegetali vengono prodotte in laboratorio dagli scienziati, anche con l’ausilio delle biotecnologie avanzate, allo scopo di trasferire materiale genetico. Il cervello non riesce a conciliare le due informazioni contrastanti e associa questi pomodori agli OGM, che invece, dal punto di vista legale, identificano prodotti ottenuti utilizzando la tecnica del DNA ricombinante[15].
La cosa più buffa è che a posteriori si sia costruita, o per meglio dire inventata, una “tradizione” per attribuire a quei pomodorini un’origine siciliana anziché israeliana.
Un vero e proprio caso di “invenzione della tradizione[16]”.