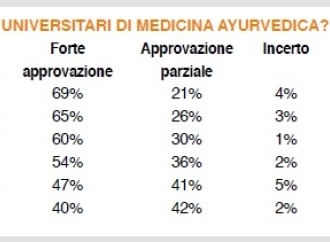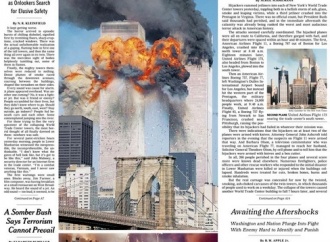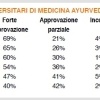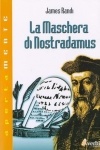Se (come in effetti accade in certi ambienti) fosse stato abbastanza convincente, il suo progetto di assumere un ruolo di primo piano nell'ambito dell'esoterismo europeo avrebbe avuto pieno successo.
Nonostante il documento di registrazione del Priorato di Sion recasse la data del 1956, Plantard intendeva "retrodatarne" la fondazione all'anno 1099, epoca in cui il Priorato era (nelle sue fantasie letterarie) un tutt'uno con i Cavalieri Templari – da cui si sarebbe separato solo nel 1188 per uno scisma avvenuto a Gisors, nella Francia settentrionale. Era dunque necessario ricostruire una sequenza storicamente credibile di Gran Maestri che, dal 1188 fino ad oggi, ne avessero potuto reggere le fila. La lista (vedi box) venne inclusa nei Dossiers Secrets e, da allora, citata innumerevoli volte, in particolare in due bestseller: Il Santo Graal (1982) di Michael Baigent, Richard Leigh ed Henry Lincoln, e nel già citato Codice da Vinci (2003).
Il lavoro di messa a punto da parte di Plantard di quella lunga lista di nomi doveva essere stato tutt'altro che banale e aveva richiesto uno studio accurato delle biografie dei personaggi coinvolti. Il rischio di commettere errori c'era... e in effetti qualche incongruenza venne a galla.
Sin dal 1982 i tre autori de Il Santo Graal si erano accorti che la lista indicava una data "impossibile": Ferrante Gonzaga, padre del più noto San Luigi Gonzaga, non poteva aver retto il Priorato di Sion fino al 1575, dal momento che era morto a Bruxelles il 15 novembre 1557. Il dubbio era già stato espresso in questi termini nell'edizione inglese del libro (1982): «Ferrante Gonzaga ci metteva di fronte all'unica notizia palesemente errata che avemmo modo di incontrare in tutti i "documenti del Priorato". Secondo l'elenco dei Gran maestri di Sion incluso nei Dossiers Secrets, Ferrante presiedette l'Ordine fino alla sua morte, nel 1575. Ma secondo fonti indipendenti sarebbe morto nei pressi di Bruxelles nel 1557». L'ipotesi che avanzarono i tre studiosi era che nel 1557 non fosse morto ma si fosse dato alla clandestinità, o che forse la data di morte fosse sbagliata, coincidendo con quella del figlio Cesare: forse gli storici si erano sbagliati e avevano attribuito al padre la data di morte del figlio. Ma poiché ai tre sembrava inconcepibile che il redattore dei Dossiers si fosse sbagliato, concludevano in questo modo: «Sembrava quasi che l'errore, confutando in modo clamoroso le notizie storiche accettate, fosse stato inserito per indicare qualcosa».
Per correggere la svista, Philippe de Chérisey – compagno fidato di Pierre Plantard – accorse in aiuto dell'amico, spiegando ai tre autori che Ferrante sarebbe stato sostituito, dopo la sua morte, dal cardinale Charles de Lorraine (1524-1574); il nome di quest'ultimo sarebbe poi sparito dalle liste del Priorato perché coinvolto nel massacro di San Bartolomeo a Parigi nel 1572 ai danni dei Protestanti. Nessuna prova venne data di questa versione dei fatti e solo dopo alcune ricerche si scoprì che la notizia non aveva alcun fondamento storico, ma piuttosto si basava sul romanzo scritto da un'astrologa americana, Liz Greene, che nel 1980 aveva pubblicato Il sognatore del Vino inventando di sana pianta tale sostituzione.
Il fatto è di un certo interesse: poiché il libro di Baigent, Leigh e Lincoln sarebbe uscito solo nel 1982, come aveva fatto la donna ad anticipare e addirittura "correggere" un'evidente incongruenza della lista di Plantard due anni prima della sua pubblicazione su Il Santo Graal?
È presto spiegato: Liz Greene è sorella di Richard Leigh e all'epoca era fidanzata con Michael Baigent!
Forse i due si erano accorti della debolezza storica della lista e avevano suggerito all'astrologa di "correggere" l'informazione in un romanzo che, come avverrà anche con il Codice da Vinci con una preoccupante leggerezza, verrà da molti considerato "verità storica".
Il sognatore del Vino verrà poi segnalato nell'appendice inglese dell'edizione 1996 de Il Santo Graal con un'allusiva riflessione: «Forse Liz Greene aveva intuito correttamente? O forse era stato il marchese de Chérisey a basarsi sul suo romanzo e, a posteriori, a trasformare una licenza poetica in un fatto storico accertato? All'epoca non potevamo saperlo; e il marchese de Chérisey morì prima che avessimo l'opportunità di interrogarlo in merito».
Lo scenario è chiaro e imbarazzante: Pierre Plantard commette un errore nel creare la sua lista di presunti Gran Maestri del Priorato di Sion. Durante le loro ricerche i tre autori se ne accorgono e, per mettere una toppa, chiedono alla sorella e fidanzata Liz di "correggere" la lista in un romanzo pubblicato nel 1980. Nel loro libro Il Santo Graal i tre potranno quindi citare un romanzo (senza naturalmente dare alcuna informazione sulla loro parentela con l'autrice) che corregge la lista, indicandolo come fonte indipendente che confermerebbe il rigore della lista stessa.
A spiegare ulteriormente le incongruenze ci pensò Plantard in persona, che – confermando lo scenario della Greene – precisava ulteriormente: Ferrante sarebbe stato sollevato dalla reggenza del Priorato un anno prima di morire, nel 1556. Tale "sospensione" sarebbe stata decisa durante una riunione del Priorato tenuta a Torino; nell'ambito dello stesso incontro si sarebbe consumato uno scisma e, durante i successivi dieci anni, avrebbe assunto il ruolo del Gran Maestro il profeta francese Michel de Nostredame (1503-1566), altrimenti noto come Nostradamus. Alla morte del profeta, avvenuta nel 1566, seguì un periodo di confusione, durante il quale si costituì un triumvirato composto da Léonor d'Orléans duca di Longueville (1540- 1573), dall'alchimista Nicolas Barnaud (1538-1604), anche noto come Nicolas de Crest e Nicolas Froumenteau, e dal già citato Charles de Lorraine.
Ancora una volta Plantard non offriva nessuna evidenza storica di questo incontro né del fatto che Nostradamus o gli altri personaggi avessero fatto parte del Priorato di Sion. E sebbene non esistano conferme indipendenti della riunione torinese del Priorato nel 1556, la presenza di Nostradamus a Torino nella stessa data è stata più volte discussa in libri e articoli di giornali che non fanno alcun riferimento alle tesi di Plantard. Ciò è di un certo interesse, perché testimonia l'esistenza di due fonti indipendenti che concordano su un personaggio, una data e un luogo: Nostradamus a Torino nel 1556.
Una ricerca delle più antiche fonti documentarie sull'argomento ci ha portati alla scoperta di un ottimo articolo di Corrado Pagliani, comparso nel numero 1 (1934) della rivista Torino[1]. In questo ben documentato studio, l'autore ricostruisce il possibile soggiorno torinese di Nostradamus partendo da una lapide originariamente collocata nell'androne di una cascina situata all'epoca (metà XVI sec.) alla periferia di Torino. Tale cascina, nota come cascina Morozzo[2], resisterà sino agli anni Sessanta del Novecento, quando sarà abbattuta per far posto a più moderne costruzioni. L'articolo in questione è un valido punto di riferimento, tanto da essere ripreso e riproposto numerose volte tra l'altro da Spagarino [3], Tirsi Caffaratto[4] e Bellagarda[5], oltre a esser citato anche da altri autori, dal tono più esoterico, come Giuditta Dembech[6]. Nel suo articolo, Pagliani riporta la riproduzione di un dagherrotipo che presumeva essere l'esatta fotografia dell'originale,cosa che si rivelerà in seguito errata. Il dagherrotipo, originariamente comparso sulla rivista Le Courrier de Turin del 26 dicembre 1807 (questo particolare risulterà, come vedremo, molto importante) riportava il testo che sarebbe stato dettato dallo stesso Nostradamus e che recita così:
lacui traduzione dovrebbe corrispondere a:
In realtà la prima testimonianza scritta circa un possibile soggiorno torinese di Nostradamus è ancora più antica, risalendo addirittura al 1786, e venne pubblicata nel Noveau Dictionnaire Historique del 1928[7]. La seconda testimonianza in ordine di tempo relativa alla lapide risale al già citato articolo del Courrier del 1807[8] in cui un certo H. Carena riporta anche le misure della stessa: 20 pollici (51 centimetri) di larghezza per 15 pollici (38 centimetri) di altezza. Da notare che Viriglio[9], nel suo famoso libro Voci e cose del vecchio Piemonte, in una nota a pagina 33 prenderà un abbaglio, attribuendo la descrizione della lapide a Giuseppe Grassi anziché a Carena. Una terza citazione si può ritrovare in un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa del 3 giugno 1932[10] in cui un certo C.O., in occasione degli imminenti lavori di ristrutturazione dell'intera area su cui sorgeva la cascina Morozzo, si sofferma sulla leggendaria figura di Nostradamus e sul suo possibile soggiorno torinese. Ma ritorniamo all'articolo di Pagliani del 1934; in esso l'autore riporta la notizia che Carena (in realtà il nome riferito da Pagliani, per una sua probabile svista, è Carrera anziché Carena) dopo il 1807 inviò a Le Courrier de Turin (27 gennaio 1808) una seconda lettera in cui riporta il parere di un anonimo lettore, tale H.B., che in seguito alla lettura della prima lettera uscita sullo stesso giornale nel dicembre 1807, precisa:
Pagliani precisa anche che una sua personale ricerca presso gli archivi del Comune circa l'esistenza di una principessa Vittoria di Savoia risulterà vana, non trovando traccia di principesse con tale nome, contemporanee o anteriori alla data dell'iscrizione. Comunque sia andata, l'autore precisa inoltre che le dimensioni della lapide (50 x 35 cm), rilevate da lui stesso nel 1934, risultano di poco inferiori a quelle riportate da Carena nell'articolo su Le Courrier de Turin del 1807 e che pertanto era possibile pensare che nel frattempo la lapide fosse stata rimossa, riquadrata e collocata in un luogo diverso dal primitivo. Per quanto riguarda invece il testo, occorre fare un'altra interessante precisazione: il Pagliani si limita a riprodurre quanto riportato sul Courrier, senza accorgersi che in realtà alla terza riga non stava scritto «ON IL HA LE PARADIS» bensì «ON IL I I A LE PARADIS»; non solo, ma quando avrà in mano la lapide originale da misurare non si accorgerà neppure che l'H di "MHONORE" della quinta riga in realtà era sovrastata da un accento circonflesso (MHONORE). Queste due piccole differenze, apparentemente senza molta importanza, in realtà ne hanno moltissima in quanto uno dei più noti interpreti di Nostradamus, ritenendo che il testo della lapide (quello con "IL HA" e senza accento circonflesso) nascondesse un messaggio criptato da decifrare, con relativa "chiave" per interpretare le famose quartine, riportando su carta millimetrata il testo stesso e calcolando opportunamente il numero delle lettere, le cadenze e le spaziature ha identificato (a suo dire) tale chiave. Peccato che il tutto fosse basato su di un testo, quello appunto riportato da Pagliani, che poi si rivelerà errato. Lasciamo alla fantasia del lettore immaginare l'attendibilità delle conseguenti interpretazioni. E se la fantasia non fosse sufficiente riportiamo testualmente quanto scritto nel libro della Dembech:
Su quale fonte si basò dunque Plantard quando affermò la presenza torinese di Nostradamus nel 1556? Potrebbe trattarsi di uno dei documenti sopra citati o di una fonte a tutt'oggi sconosciuta.
In mancanza di altre testimonianze comprovate, forse il punto interrogativo contenuto nel titolo di quest'articolo non è del tutto azzardato.
Mariano Tomatis Scrittore e ricercatore
Giuseppe Ardito Biologo, ha insegnato antropologia alle università di Torino e di Firenze