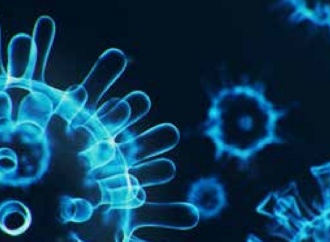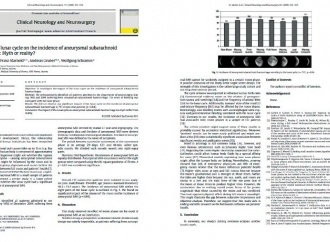Nel 2018 numerosi enti finanziatori della ricerca si sono riuniti in un consorzio, la cOAlition S, per supportare il modello dell’Open Access nelle pubblicazioni scientifiche[1]. Il consorzio raggruppa enti istituzionali come l’European Research Council o la World Health Organization, le due più grandi fondazioni private che finanziano la ricerca (la Bill & Melinda Gates Foundation e il Wellcome Trust) e numerosi altri enti; l’Italia è rappresentata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Lo scopo è descritto dal “Plan S”, che prevede che tutti i risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici siano pubblicati su riviste Open Access a partire dal 2021.
Insieme alla diffusione del modello Open Access, in qualche modo “ufficializzato” dal Plan S, negli anni è esploso anche il fenomeno dei predatory journal, e la comunità scientifica ha continuato a interrogarsi e a riflettere su possibili rimedi.
Non è probabilmente così vero che, come avevamo scritto, chi è del mestiere sappia benissimo riconoscere una rivista farlocca, dato che il mercato è enorme. La “blacklist” gestita da Cabells (una società privata di servizi per l’editoria accademica, ne abbiamo parlato nel n. 30) include più o meno lo stesso numero di riviste Open Access “verificate” e “predatory” (11507 contro 10671, secondo i numeri riportati su un recente pezzo di commento pubblicato da Nature di cui parleremo più avanti)[2].
Evidentemente una frazione non trascurabile degli 11 milioni di ricercatori a tempo pieno al mondo (dati UNESCO del 2015, sono lo 0.15% della popolazione mondiale) non è in grado di riconoscere la trappola oppure, come hanno osservato numerosi commentatori, la pressione a pubblicare spinge molti a prendere delle scorciatoie: un paper su una rivista che conta poco può essere meglio di niente.
Non solo: uno studio del 2019[3] ha mostrato come numerosi ricercatori si prestino a fare da reviewer per queste riviste, fornendo loro una foglia di fico. La review (qualche volta) c’è stata, tipicamente da parte di un ricercatore giovane e quindi inesperto, e in ogni caso sarà plausibilmente ignorata, alla fine basta che l’autore paghi. È anche interessante notare come lo studio trovi che la grande maggioranza dei reviewer che si prestano a questo vengano da paesi a basso reddito, in particolare Medio Oriente e Africa: esattamente da dove provengono gli autori che cascano nell’imbroglio[4].
L’allarme sul fenomeno dei predatory journal era partito da un articolo su Science nel 2013[5], in cui si raccontava un esperimento consistito nell’inviare un paper pieno di errori evidenti e di scarsa qualità complessiva, che era stato accettato senza discussione da moltissime di queste riviste.
Un altro divertente e istruttivo esperimento è stato fatto da un gruppo di ricercatori polacchi[6]. Hanno creato un personaggio di fantasia, Anna O. Szust (“Oszust” significa “impostore” in polacco) con tanto di account Twitter e profilo personale sul sito dell’Università di Poznan.
Hanno poi inventato un curriculum per Anna l’imbrogliona, infarcito di titoli fasulli facilmente verificabili e comunque miseramente inadeguato a un ruolo di responsabilità, mancando di qualunque esperienza nell’editoria scientifica, come autore o come reviewer. Anna si è quindi proposta come editor a 360 riviste, tra cui 120 prese da una blacklist. Ora, come ha risposto una rivista legittima, non si diventa editor di una rivista scientifica mandando il CV; per il posto generalmente si invitano figure di alto profilo e grande esperienza nel campo. E invece il 33% delle riviste classificate come rapaci ha in qualche modo accettato la proposta, spesso chiedendo una qualche forma di pagamento, o proponendo altri scambi che permettessero alla rivista di guadagnarci in qualche modo. Il nome Anna O. Szust è rimasto nel comitato editoriale pubblicato sul sito di diverse riviste anche dopo che la candidatura era stata ritirata...
E quindi? Un po’ come con lo spam e i virus informatici, bisognerà probabilmente convivere con un fenomeno difficile da combattere alla fonte, imparando a difendersi.
Una soluzione è quella delle blacklist, che pone però un problema non indifferente. Quali caratteristiche definiscono una “rivista rapace”?
Per provare a rispondere, un gruppo di ricercatori ed esperti in editoria scientifica ha formato un comitato che ha provato a formulare una definizione precisa di “predatory journal”, individuando quattro criteri che permettano di identificare le riviste rapaci, raccontando i risultati in un pezzo di commento apparso su Nature nel dicembre del 2019[7].
Il punto di partenza è che, in mancanza di una definizione condivisa, è difficile fare quello che il comitato si ripromette, come la creazione di un “osservatorio” internazionale sul fenomeno. Infatti, le varie blacklist esistenti non sono coerenti tra loro, e riviste elencate come rapaci in una lista possono essere giudicate legittime da un’altra. Per esempio, una peer review di cattiva qualità, un sito web mal fatto o una policy di archiviazione poco chiara possono semplicemente indicare una rivista in difficoltà economiche, senza che questa sia necessariamente farlocca:
«Le riviste e gli editori rapaci sono entità che privilegiano i propri interessi a scapito della cultura scientifica e sono caratterizzate da informazioni di sé false o ingannevoli, deviazioni dalle buone prassi editoriali e di pubblicazione, mancanza di trasparenza e/o uso di pratiche pubblicitarie aggressive e indiscriminate» (traduzione mia).
È interessante notare come la definizione, che ha richiesto un complicato processo di formazione del consenso tra gli esperti, escluda esplicitamente sia la nequizia, difficile da valutare oggettivamente, sia la qualità della peer review. Questo perché, nell’opinione del comitato, la qualità della peer review è difficile da valutare anche per le riviste legittime, principalmente per mancanza di trasparenza.
L’altra soluzione ovvia è sensibilizzare i ricercatori al problema, in modo da ridurre la probabilità che caschino nel tranello. Per esempio, un gruppo di enti e società dal mondo dell’editoria e della comunicazione scientifica ha promosso “Think. Check. Submit.” (“Pensa. Verifica. Invia.”)[8], una campagna di sensibilizzazione al problema che propone una checklist per stimare la reputabilità di una rivista prima di sottomettere i propri lavori, con domande come “La rivista indica chiaramente quali sono le procedure di revisione tra pari adottate?”, oppure “Hai mai sentito nominare i membri del comitato editoriale?”.
Il parere di moltissimi commentatori, però, è che sia necessario qualcosa di più profondo. La valutazione di un ricercatore si fa sulla sua produzione scientifica, quindi sul numero e sulla qualità delle sue pubblicazioni; è difficile, ma bisogna che l’accento si sposti sempre più dal numero alla qualità.