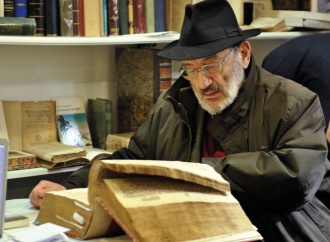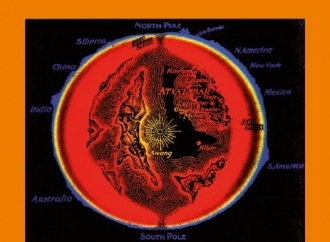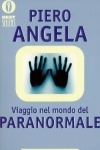Per esempio, è dagli anni '70, quando furono rintracciate per la prima volta da sonar ed ecoscandagli nell’area della Nuova Scozia (Canada), che delle cavità regolari denominate “pockmarks” per analogia con le cicatrici lasciate dall’acne, tengono viva l’attenzione dei ricercatori. Negli anni ’80, strutture analoghe furono poi individuate nel Mare del Nord e via via un po’ in ogni parte del mondo, finché oggi le si ritiene le più comuni strutture delle profondità marine. Risale però ad appena qualche mese fa una spiegazione della loro natura tanto convincente da guadagnarsi le pagine di Communications Earth & Environment[1].
I primi studi avevano attribuito la forma a cratere dei pockmarks all’erosione da acqua o gas in risalita, probabilmente metano. Quest’ultimo avrebbe sospeso i sedimenti del fondale, che, spazzati via dalla corrente, avrebbero lasciato delle depressioni coniche di diametro compreso tra un metro e diverse centinaia di metri. In effetti, le perturbazioni riportate dagli ecoscandagli avrebbero potuto indicare gas sopra o sotto il fondale del Mare del Nord, ma qualcosa non tornava. Se il 9% di un’area di circa 2000 chilometri quadrati risultava punteggiato da queste fosse, le emissioni di metano avrebbero dovuto essere di gran lunga superiori alla concentrazione effettiva. Inoltre, osservazioni ripetute a distanza di pochi mesi avevano mostrato una redistribuzione delle cavità, un dinamismo che smentiva anche il tentativo di spiegarle come agglomerati di sedimenti dell’Olocene. Allora a cosa si dovevano quelle strutture? Per avere un quadro più coerente mancava ancora un soggetto sulla scena: un cacciatore.
Ecoscandagli con risoluzione al centimetro, misurazioni geochimiche e geofisiche in situ, combinate a studi di etologia e zoologia, hanno portato allo scoperto Phocoena phoecena, cioè la focena comune. Stando agli ecolocalizzatori, la focena caccia fino a 30 metri sotto la superficie, collocandosi perpendicolarmente al fondale per scavare con il rostro buche profonde fino a 20 centimetri. Nel mare di Bering, strutture simili sono state spiegate con la presenza di un altro mammifero acquatico, la balena grigia (Eschrichtius robustus), che rovista i sedimenti alla ricerca di gamberetti bentici. L’enorme numero di questi organismi sarebbe quindi in grado di plasmare la morfologia del fondale. Tuttavia, la dimensione delle buche rende difficile spiegarne la natura esclusivamente con la predazione. Ed ecco che entrano in gioco anche le correnti tidali, con velocità fino a un metro al secondo, che livellano, erodono e allargano le cavità esistenti, e ne coprono altre, creando così il pattern dinamico che aveva disorientato i primi osservatori.