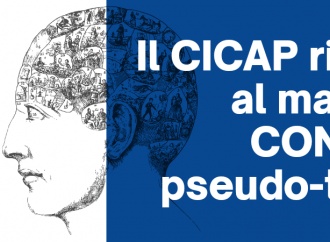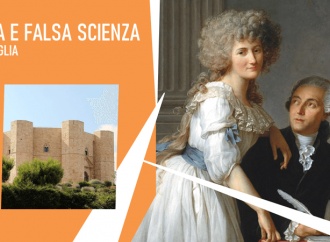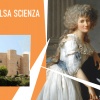Cenni biografici
Giorgio Piccardi[2] nacque a Firenze il 13 ottobre 1895. Nel 1913 si iscrisse al Reale Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento dell'ateneo fiorentino dove iniziò lo studio della chimica sotto la guida di Hugo Schiff (1834-1915), ben noto per la scoperta delle cosiddette "basi di Schiff". I suoi studi vennero interrotti dalla guerra, durante la quale, come ufficiale degli alpini, si guadagnò una medaglia d'argento al valor militare e il grado di capitano. Nel 1919 Piccardi completò gli studi propedeutici di ingegneria chimica al Politecnico di Torino. Tornato a Firenze proseguì gli studi sotto la guida del Prof. Luigi Rolla (1882-1960). Dopo la laurea conseguita nel 1922, divenne assistente dello stesso Rolla. Nel 1938 vinse la cattedra di chimica-fisica presso l'Università di Genova, ove fondò l'istituto di chimica-fisica e un laboratorio di spettroscopia. In questo periodo indirizzò le sue ricerche verso lo studio degli spettri atomici e molecolari delle terre rare e dei loro composti. Introdusse inoltre, per la prima volta in Italia, lo studio della chimica-fisica delle superfici. Lo scoppio della Seconda Guerra mondiale lo obbligò a tornare in Toscana, ove, separato da Genova dalla "linea gotica", iniziò a collaborare con l'ateneo fiorentino. Nel 1945 egli ottenne la cattedra di chimica-fisica presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Firenze, fondando un istituto di chimica-fisica del quale fu direttore fino al 1965. Fino al 1951 l'attività scientifica di Piccardi si svolse brillantemente in diversi settori della chimica-fisica: ricerche su processi elettronici e potenziali di ionizzazione, studi sul sistema periodico, ricerche sulle terre rare e in particolare sull'elemento 61, studi di spettroscopia atomica e molecolare e sue applicazioni in campo industriale, archeologico e astrofisico, studio dei fenomeni di superficie e relative applicazioni in campo biologico.
Dopo il 1951 la sua attività si rivolse invece allo studio di un campo decisamente eterodosso: quello dei cosiddetti "fenomeni fluttuanti". La denominazione di tali fenomeni si deve allo stesso Piccardi che con essa intendeva indicare tutti quei fenomeni chimico-fisici che, secondo le teorie da lui elaborate, sarebbero stati irriproducibili a causa dell'influsso di fattori ambientali e addirittura extraterrestri. In particolare Piccardi credette di individuare una forte dipendenza di certi fenomeni dall'attività magnetica del Sole. Per questo motivo egli iniziò a collaborare con illustri astrofisici quali Gugliemo Righini (1908-1978). A Firenze Piccardi fondò il Centro Universitario dei Fenomeni Fluttuanti (CUFF) di cui fu direttore fino alla morte. Nel 1967 il CUFF divenne un'unità della World University e assunse il ruolo di centro guida a livello internazionale per lo studio dei fenomeni fluttuanti. Piccardi ricoprì inoltre la carica di presidente del CIFA (Comitato Internazionale per lo Studio dei Fenomeni dell'Ambiente) con sede a Bruxelles. Durante la sua attività scientifica, Piccardi fu autore di oltre 200 pubblicazioni apparse in Italia e all'estero e fu insignito di diverse onorificenze. Morì a Riccione il 22 dicembre 1972. Un amico ebbe a dire: «Giorgio Piccardi, maestro del Sole, scomparve nel giorno del solstizio d'inverno».
I test chimici
Fin dagli anni Trenta Piccardi si interessò di alcune insolite tecniche industriali che consentivano di evitare la formazione di incrostazioni calcaree nelle tubature e nelle caldaie. Alcune tecniche consistevano nell'applicazione di campi magnetici[3]. Altre tecniche utilizzavano invece dei bulbi di vetro contenenti una goccia di mercurio in atmosfera di neon. Tali bulbi, tenuti in agitazione dallo stesso flusso dell'acqua all'interno della tubatura, mostravano al loro interno una luminescenza rossa dovuta a deboli scariche elettriche causate dallo strofinio della goccia di mercurio contro le pareti interne del bulbo di vetro. In loro presenza il calcare precipitava sotto forma di polvere bianca, facile da rimuovere, anziché creare fastidiose incrostazioni. Piccardi si convinse che l'effetto fosse dovuto a una qualche attivazione dell'acqua causata dai campi magnetici o dalle deboli scariche elettriche generate all'interno dei bulbi contenenti il neon. Iniziò quindi a compiere esperimenti studiando la precipitazione di varie sostanze in presenza di acqua "normale" e "attivata" con diverse tecniche. Egli distinse due tipi di precipitazione: il tipo "T", in cui il precipitato si formava rapidamente sotto forma pulverulenta; e il tipo "R", in cui il precipitato si formava con un certo ritardo e si presentava sotto forma di fiocchi che sedimentavano lentamente.
Compiendo questi esperimenti, Piccardi osservò una grande variabilità e apparente non riproducibilità dei fenomeni. Per questo motivo, a partire dal 1951, iniziò uno studio sistematico di questi fenomeni, utilizzando criteri statistici, per cercare di comprendere cosa potesse influenzare l'andamento delle precipitazioni. Egli mise a punto quelli che lui stesso definì "test chimici". I test consistevano nel far precipitare l'ossicloruro di bismuto (BiOCl) aggiungendo semplicemente dell'acqua a una soluzione concentrata di cloruro di bismuto (BiCl3). In data 1 marzo 1952, lo stesso Piccardi rammentava di aver già eseguito 15.572 test chimici. Negli anni seguenti, insieme ai suoi collaboratori, eseguì un numero impressionante di test chimici. Addirittura cercò di automatizzare la procedura costruendo appositi strumenti da lui battezzati "miscelatori sincroni". Convintosi che la precipitazione dell'ossicloruro di bismuto potesse essere influenzata da fattori esterni di presunta origine elettromagnetica, provò a schermare le soluzioni con delle gabbie di Faraday. Arrivò a costruire stanze completamente schermate con lastre metalliche. Alcuni suoi collaboratori eseguivano test analoghi in diversi paesi cercando di mettere in evidenza una eventuale dipendenza dalla latitudine e dalla longitudine del luogo. Addirittura uno dei suoi più stretti collaboratori, il chimico e giornalista scientifico Giancarlo Masini, venne inviato a compiere i test chimici in prossimità del Polo Nord.
Altri test chimici vennero realizzati studiando la polimerizzazione dell'acrilonitrile e altre reazioni chimiche.
Dall'enorme mole di dati raccolti Piccardi credette di poter individuare vari tipi di fluttuazioni dell'andamento dei suoi test chimici, che egli interpretò in base all'influenza di diversi influssi esterni. Una fluttuazione giornaliera poteva essere attribuita a vari fattori di tipo climatico e a campi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Una fluttuazione mensile poteva dipendere, secondo Piccardi, dalla rotazione del Sole su se stesso. Le variazioni con periodicità annuale erano interpretati come l'evidenza più concreta di una influenza da parte del Sole. Nel mese di marzo, infatti, la velocità con cui la Terra si muove intorno al Sole è massima e in questo periodo Piccardi credeva di aver osservato un minimo nella velocità di flocculazione dei suoi precipitati. Viceversa nel mese di settembre la velocità della Terra è minima e anche questo sarebbe stato messo in evidenza dai test chimici. Piccardi credette inoltre di aver individuato una periodicità undecennale che corrispondeva esattamente all'andamento ciclico dell'attività solare (evidenziata dalle caratteristiche macchie) che possiede un periodo proprio di 11 anni. Piccardi ipotizzò addirittura una periodicità secolare in quanto i suoi test chimici avevano presentato un andamento particolare nell'anno 1954, anno in cui l'attività solare era stata anomala (alcuni suoi collaboratori ipotizzarono anche una fluttuazione dipendente dalle fasi lunari). L'insieme di queste evidenze che credeva di aver individuato, condusse Piccardi a formulare la sua "ipotesi solare", ben espressa nel suo seguente brano: «Se invece di considerare l'orbita ellittica della Terra intorno al Sole, noi consideriamo l'orbita elicoidale della Terra rispetto alla galassia (cioè il movimento ellittico di rivoluzione della Terra, più il movimento rettilineo di traslazione del Sole verso la costellazione di Ercole), si trovano fatti assai notevoli. In primavera la Terra avanza nel suo piano equatoriale. La sua velocità è massima: circa 45 km/s. In autunno la Terra avanza quasi lungo il proprio asse col polo Nord in avanti. La sua velocità è minima: 24 km/s. È logico pensare che non sia indifferente, per un corpo magnetico, avvolto da una atmosfera di cariche elettriche e ruotante, come la Terra, lo spostarsi in una direzione o in un'altra e con velocità tanto diversa, in uno spazio che non è vuoto né privo di forze. Si potrebbe allora considerare la grande variazione del test D[4] come conseguenza del moto elicoidale della Terra in un campo galattico. Il senso delle stagioni sarebbe allora molto più profondo dal punto di vista fisico, di quel che non si sia pensato fino ad ora»[5].
Piccardi costruì anche un modello meccanico per mostrare il moto elicoidale della Terra rispetto alla galassia: tale modello è tuttora conservato al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. A causa della sua "ipotesi solare" Piccardi si guadagnò l'appellativo di "chimico del Sole". Lo scienziato fiorentino spinse alle estreme conseguenze le sue ipotesi ammettendo una possibile influenza dei pianeti sulla Terra e sull'uomo: «Forse è anche per mezzo dell'acqua e dei sistemi acquosi che le forze esterne sono capaci di interagire sui sistemi viventi... Per essere soggetto agli effetti cosmici, l'uomo non ha bisogno di viaggiare nello spazio; egli non deve neppure lasciare la propria casa. L'uomo è sempre circondato dall'Universo perché l'Universo è ovunque.[6]
Poiché è stato dimostrato che i pianeti possono influenzare il Sole, si deve ammettere la possibilità che essi possono influenzare la Terra, che è più vicina ad essi che il Sole»[7]. Per queste sue affermazioni, l'opera di Piccardi fu ampiamente citata dagli astrologi e da altri pseudoscienziati[8] nel tentativo di fornire un fondamento scientifico alle loro discipline. Per tale motivo Piccardi venne a trovarsi in una curiosa situazione: da un lato doveva prendere le distanze e difendersi da chi voleva utilizzare le sue teorie a sostegno di discipline pseudoscientifiche; dall'altro doveva battersi per vincere lo scetticismo che il resto della comunità scientifica manifestava nei confronti delle sue ricerche. Lo scetticismo era manifestato particolarmente dagli ambienti chimici e fisici; per questo motivo la maggior parte delle pubblicazioni di Piccardi sui fenomeni fluttuanti non uscirono, come sarebbe stato naturale, su riviste di chimica o di fisica, bensì su periodici di altre discipline: geofisica, meteorologia, bioclimatologia, medicina, eccetera.
Inconsistenza scientifica delle tesi di Piccardi
Per valutare da un punto di vista scientifico l'opera di Piccardi, può essere utile analizzare alcuni brani da cui si possono dedurre i fondamenti epistemologici che animarono il suo lavoro. Come ricorda il suo allievo Paolo Manzelli, Piccardi ad esempio sosteneva: «Tutti sanno che un seme va piantato nel terreno in certe stagioni e con la luna calante se si vogliono far crescere alcune specie di piante, perché esse non germogliano in un tempo qualsiasi scelto a piacere!»[9]. Attribuire fondamento a credenze popolari mai dimostrate denota infatti una certa carenza di rigore scientifico e una notevole mancanza di senso critico. In un altro brano, ricordato dallo stesso Manzelli, Piccardi afferma: «L'acqua di fonte attivata T risulta talvolta riconoscibile al tatto, essa dà infatti una sensazione di untuosità, almeno per certe persone, tanto che qualcuno l'ha soprannominata "acqua liscia". [.] L'organismo vivente si comporta sotto certi riguardi come uno strumento universale di misura, capace di registrare le cose più disparate con sensibilità molte volte prodigiosa. In ciò differisce dagli strumenti fisici i quali registrano una cosa sola e con sensibilità molto limitata»[10].
Affidarsi alla valutazione soggettiva dei propri organi di senso, preferendola addirittura alle misure quantitative e obiettive fornite da uno strumento, denota un modo di procedere quanto meno singolare. La scienza ha potuto svilupparsi proprio grazie al superamento della soggettività e affidandosi a metodi di indagine quantitativa. Rifiutare questi criteri essenziali del metodo scientifico non rappresenta certo un'innovazione (come gli allievi di Piccardi vogliono far credere) bensì una pericolosa forma di regresso culturale.
Al di là di queste osservazioni, comunque, l'opera di Piccardi è stata analizzata con rigore da altri autori (anche se la maggior parte della comunità scientifica si è limitata sostanzialmente a ignorarla). Ad esempio l'ungherese Mihály T. Beck ha esaminato criticamente i lavori di Piccardi sulla precipitazione dell'ossicloruro di bismuto[11]. La critica fondamentale che Beck rivolge a Piccardi consiste nell'attribuirgli un'eccessiva fiducia nella valutazione qualitativa dei fenomeni. Nonostante Piccardi abbia sottoposto ad analisi statistiche quantitative i risultati dei suoi test chimici, ciascun dato era ottenuto in modo completamente qualitativo. La velocità di precipitazione dell'ossicloruro di bismuto non è mai stata misurata quantitativamente, ma soltanto stimata qualitativamente. In tutta l'opera di Piccardi, e in particolare nella descrizione che egli stesso fornisce dei suoi esperimenti, emerge poi una preoccupante tendenza a una grossolana approssimazione: uso di acqua potabile anziché di acqua distillata, concentrazioni approssimate, uso di strumenti di misura poco precisi, eccetera. È chiaro che, operando in questo modo, in assenza di qualsiasi standardizzazione dei campioni e delle condizioni di reazione, non c'è da meravigliarsi che i fenomeni appaiano come non riproducibili. Attribuire poi la non riproducibilità a cause extraterrestri appare un salto concettuale estremamente azzardato. Nessuno ha mai avuto motivo per mettere in dubbio la buona fede di Piccardi: egli credeva veramente nei risultati delle sue ricerche e sicuramente pagò di persona le conseguenze della sua fede in teorie eterodosse. Egli fu uno scienziato autentico, che amava il proprio lavoro e la ricerca disinteressata della verità, ma probabilmente fu vittima di un autoinganno che lo spinse a credere in fenomeni inesistenti.
Recenti proseliti
Le ricerche di Piccardi hanno sicuramente un valore dal punto di vista della storia e della sociologia della scienza, ma dal punto di vista strettamente scientifico appaiono oramai prive di interesse. Sorprende quindi constatare che ancora oggi qualcuno si rifaccia alle sue teorie per sostenere discipline eterodosse la cui fondatezza non è mai stata riconosciuta dalla comunità scientifica. Recentemente, infatti, il lavoro di Piccardi è stato tirato in ballo a sostegno di due pratiche mediche alternative: la pranoterapia e l'omeopatia.
I test chimici sono stati utilizzati da A. Ansaloni e P. Vecchi[12] per saggiare le "proprietà radianti" dei pranoterapeuti. Attraverso l'imposizione della mani a distanza, il pranoterapeuta attiverebbe l'acqua distillata che, a causa di questo trattamento, viene chiamata "bioattivata". La precipitazione dell'ossicloruro di bismuto (o di altri colloidi), secondo i due autori, avverrebbe in modo diverso a seconda che le soluzioni iniziali siano preparate con acqua normale o "bioattivata". Essi concludono pertanto che i pranoterapeuti possono agire su un sistema modificandone le caratteristiche chimico-fisiche, senza un contatto diretto. Alla luce delle critiche rivolte ai lavori di Piccardi, le conclusioni raggiunte da Ansaloni e Vecchi appaiono quanto meno azzardate, anche per varie debolezze del metodo di analisi dei campioni precipitati. Inoltre, le presunte capacità dei pranoterapeuti non sono mai state dimostrate in alcun altro modo rigoroso.
Analogamente i due omeopati P. Bellavite e A. Signorini, nel loro libro Fondamenti teorici e sperimentali della medicina omeopatica[13], citano i lavori di Piccardi relativi alla presunta attivazione dell'acqua per giustificare l'azione terapeutica dei rimedi omeopatici che, a causa delle elevate diluizioni cui vengono sottoposti, non contengono più neppure una molecola di quello che dovrebbe essere il principio attivo iniziale. Nel loro libro si legge:
Conclusioni
A conclusione di questo articolo, possiamo trarre due considerazioni. Il caso Piccardi, come altri casi di scienza patologica, è interessante dal punto di vista epistemologico per mostrare come sia facile cadere vittima delle proprie convinzioni e del desiderio di essere di fronte a una rivoluzionaria scoperta. Secondariamente, il fatto che ancora oggi alcuni autori si rifacciano alle sue teorie per sostenere tesi eterodosse mostra, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, la necessità che la comunità scientifica eserciti fino in fondo la propria azione critica. Molti accusano la scienza di eccessivo conservatorismo e di scarsa apertura verso le idee nuove. Talvolta tale accusa può anche essere giustificata, ma sicuramente l'atteggiamento scettico della scienza è uno strumento indispensabile per impedire il diffondersi di idee prive di fondamento. Come sempre, infatti, è d'obbligo attenersi al principio secondo il quale "affermazioni straordinarie richiedono prove altrettanto straordinarie".
Silvano Fuso
Chimico-fisico, Segretario
CICAP-Liguria e Coordinatore
Gruppo Scuola CICAP
[email protected]
L'autore desidera ringraziare il dott. Luigi Garlaschelli dell'Università di Pavia, per gli utili contributi forniti durante la stesura del presente articolo.