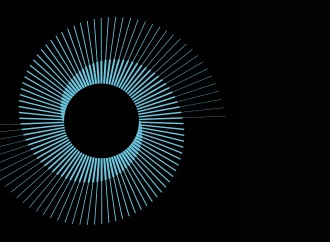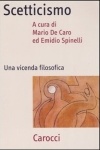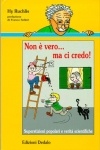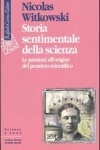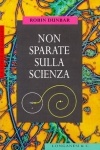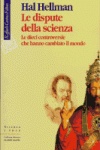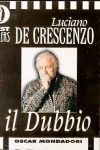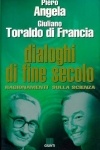Ci sono diverse cose che la scienza non può fare, nonostante ciò che ne pensano alcuni suoi sostenitori troppo zelanti. Prendiamo in esame le più interessanti dal nostro punto di vista.
La scienza non dà giudizi morali. Le questioni morali sono essenziali, ma le risposte non possono arrivare dalla ricerca scientifica. Facciamo un esempio: quali diritti universali dovrebbero avere gli esseri umani? Anche gli altri animali dovrebbero avere gli stessi diritti?
La scienza può aiutarci a capire quali delle nostre capacità cognitive sono condivise dagli animali non umani e questa conoscenza può informare le nostre decisioni. Ma in ultima analisi le nostre decisioni dipendono da giudizi morali. La scienza è descrittiva, non prescrittiva: ci aiuta a capire come è il mondo, ma non ci dice se questo stato di cose è giusto o sbagliato, buono o cattivo e non ci dice se dobbiamo impegnarci per cambiarlo e in che direzione. Quando i singoli scienziati fanno dichiarazioni prescrittive si esprimono a titolo personale, e ne hanno diritto, ma non parlano a nome della scienza.
Questa distinzione è rilevante per l’azione del CICAP. Si può affermare che dal punto di vista scientifico è utile compiere la sperimentazione animale, ma non che è giusto, perché questa seconda valutazione ricade al di fuori del campo di indagine della scienza. Per essere più precisi, ognuno di noi può certamente ritenere giusto ricorrere alla sperimentazione animale, opportunamente regolamentata (io personalmente lo penso), ma non possiamo presentare questa convinzione come un fatto dimostrato scientificamente. Se sosteniamo questa posizione, dobbiamo accettare che altre persone abbiano una posizione diversa, ma legittima quanto la nostra. Dobbiamo cioè accettare che la discussione si svolga sul campo umanistico del confronto tra valori e visioni del mondo differenti e non sul campo scientifico della valutazione delle prove empiriche.
Allo stesso modo, la scienza non dà giudizi estetici. La fisica ci spiega come avviene la trasmissione del suono, la psicologia della percezione e la fisiologia studiano la percezione dei colori e le neuroscienze esplorano le basi neurali dell’apprezzamento estetico, ma la scienza non ci può dire se le opere di Giuseppe Verdi sono dei capolavori, o se i dipinti di Caravaggio sono preferibili a quelli di Tiziano. Anche in questo caso, è certamente possibile discutere e cercare un accordo sui giudizi estetici, ma la discussione avviene al di fuori del terreno scientifico e nessuno può sostenere di avere la scienza dalla propria parte.
Inoltre, la scienza non ci dice come usare le conoscenze che produce. La scienza, per esempio, può dirci come ricombinare il DNA in nuovi modi, ma non specifica se dovremmo usare tale conoscenza per correggere una malattia genetica, sviluppare una pianta più resistente ai parassiti o costruire un nuovo batterio.
Per ogni nuova scoperta scientifica, si possono immaginare modi sia benefici sia dannosi in cui la conoscenza si potrebbe sfruttare. Per esempio, gli sviluppi della robotica e dell’intelligenza artificiale permettono di realizzare sistemi autonomi di armi letali sempre più sofisticati. Ma queste invenzioni innescano preoccupazioni sulla realizzazione di macchine omicide senza un controllo umano diretto. Il loro sviluppo dovrebbe essere quanto meno regolamentato, ma per ragioni etiche e non scientifiche.
Ancora una volta, la scienza ci aiuta a descrivere com’è il mondo ma non può decidere al posto nostro come adoperare quella conoscenza. Un esempio pertinente all’attività del CICAP riguarda gli OGM: noi possiamo affermare che gli OGM non sono dannosi per la salute umana, ma questo di per sé non risponde alla questione di come regolamentare la ricerca sugli OGM, che è politica e non scientifica, anche se essa dovrebbe tenere conto dei dati scientifici.
Infine, la ricerca scientifica non dà risposte sull’esistenza di Dio o dell’anima e su tutto ciò che riguarda il soprannaturale. Le domande che riguardano il soprannaturale sono, per definizione, al di fuori dell’ambito che può essere studiato dalla scienza. Possiamo chiamare questa visione “naturalismo metodologico”: è un atteggiamento che accomuna tutti gli scienziati, indipendentemente dalle loro convinzioni metafisiche. Questa visione viene invece rifiutata dalle pseudoscienze come l’intelligent design, che postula una spiegazione soprannaturale per l’evoluzione.
Abbracciare il naturalismo metodologico non implica necessariamente concludere che tutto ciò che esiste è naturale, e quindi che nulla di soprannaturale esiste, una convinzione che possiamo chiamare “naturalismo metafisico” e che è adottata da una parte degli scienziati ma non dal CICAP. Pensare che il soprannaturale non esista è una convinzione metafisica assolutamente compatibile con l’uso del metodo scientifico, ma non è necessaria per essere buoni scienziati o per promuovere la mentalità scientifica.
La tendenza ad attribuire alla scienza la capacità di dirimere questioni che sono al di fuori del suo campo di indagine è una conseguenza diretta del suo prestigio ed è caratteristica della società contemporanea. In un mondo in cui la scienza, al netto delle critiche, è considerata la forma di sapere più autorevole, fonte di conoscenze oggettive, di sviluppo economico e di supremazia strategica, è retoricamente più efficace sostenere che una scelta sia scientifica piuttosto che sia giusta.
Ogni schieramento tende a usare la scienza come risorsa retorica per legittimare le proprie istanze e a squalificare quelle degli avversari presentandole come antiscientifiche.
Per esempio, gli animalisti che combattono la sperimentazione animale sostengono che è scientificamente inutile, chi si oppone agli OGM si appoggia agli studi che ne dimostrerebbero la pericolosità e così via. Possiamo chiamare “scientismo inconsapevole” questa tendenza a spostare nel campo scientifico controversie che dovrebbero più propriamente svolgersi sul piano morale o politico.
È molto diffusa la pratica di costruire attraverso il cherry picking un complesso di prove scientifiche apparentemente inequivocabili a sostegno della propria posizione in modo da presentare la propria visione di parte come l’unica compatibile con le conoscenze scientifiche. Chi difende la scienza dovrebbe contrastare questo modo di argomentare, che non rende un buon servizio né alla scienza né alla società, perché ostacola il già difficile processo di ricerca di una realtà condivisa tra parti avverse.
Le associazioni come il CICAP dovrebbero invece ricordare la necessità di tenere separate le prove scientifiche dalle nostre scelte morali e politiche e promuovere il tentativo di trovare un accordo sui fatti indipendentemente dalle opinioni di parte, in modo che la discussione si possa poi svolgere, a partire dai fatti scientifici condivisi, sulle differenti visioni legittimamente presenti.
Bibliografia
- Bucchi M., 2010. Scientisti e antiscientisti, il Mulino