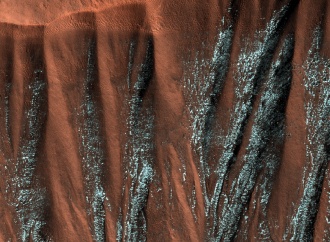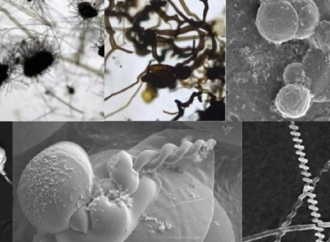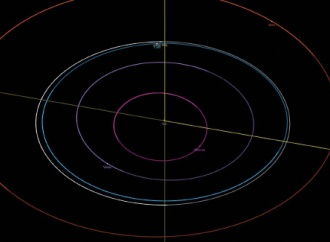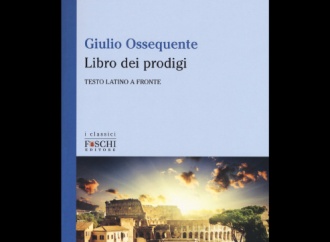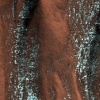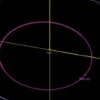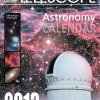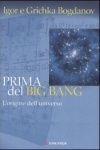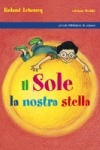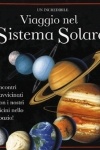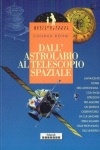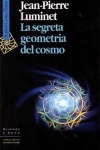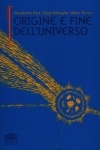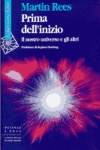Il Sole “sbagliato” di sir William Herschel
Tedesco di nascita ma inglese di adozione, Herschel è stato musicista di professione e astronomo per passione, ma il suo lascito scientifico è stato certamente il più importante. Spaziò in settori ancora poco esplorati dell’astronomia stellare e galattica, diventando famoso soprattutto per la scoperta nel 1781 del pianeta Urano, che per la prima volta dall’antichità estendeva oltre Saturno i confini del sistema solare. Herschel rivelò inoltre il moto del Sole nella galassia verso la costellazione di Ercole e, registrando le variazioni del numero di macchie e della luminosità solare, gettò le basi per lo studio della radiazione infrarossa e delle relazioni Sole-Terra (l’attuale space weather). Fu anche il primo presidente della Royal Astronomical Society.
Herschel si dedicò allo studio sistematico del Sole dal 1780, con accurate osservazioni che riportò in due lunghi articoli su Philosophical Transactions nel 1795 e nel 1801, nei quali espose anche la sua idea dell’esistenza sul Sole di esseri viventi. A quel tempo ciò che si sapeva del Sole era praticamente ancora il poco che si conosceva all’inizio del 1600, dopo l’introduzione del telescopio: la mutevole presenza di macchie e facole, valori approssimati della distanza dalla Terra e del diametro e tempo di rotazione del disco.
Riguardo alla natura e struttura del Sole, era opinione generale degli astronomi che la sua atmosfera, pur surriscaldata e luminosa, fosse soggetta a una meteorologia simile a quella dell’atmosfera terrestre e che quindi nascondesse un nucleo solido: un modello “planetario” molto diverso dal modello “sfera di fuoco” ereditato dall’antichità. Questa struttura era suggerita anche dall’idea errata che solo un corpo grande e solido, seppur di bassa densità come il Sole, fosse in grado di esercitare una forza gravitazionale fino ai pianeti lontani.
La teoria dominante sulle macchie solari era quella di Alexander Wilson (1714-1786), che riteneva fossero depressioni formatesi casualmente e temporaneamente nella turbolenta atmosfera solare. La teoria sembrava provata dalle osservazioni prospettiche delle macchie più grandi, che apparivano pressoché circolari al centro del disco ma lenticolari quando, vincolate alla rotazione del corpo solare, si mostravano ai bordi del disco. È una teoria sbagliata: oggi sappiamo che le macchie sono fenomeni di superficie generati da locali intensificazioni del campo magnetico con conseguente riduzione della temperatura (4500 K contro 6000 K) e della luce emessa.
Herschel condivide sia il modello planetario del Sole sia la teoria di Wilson sulle macchie, ritenendole in certi casi cavità tanto profonde e ampie da lasciar intravedere al fondo piccole porzioni del nucleo solido del Sole. Quindi, coerentemente, suggerisce, senza successo, di adottare nella letteratura scientifica il termine opening anziché spot (oggi sunspot), che a suo avviso rispecchia la realtà fisica del fenomeno. Un panorama simile, secondo Herschel, si presenterebbe a un osservatore posto sulla Luna, che potrebbe vedere piccole porzioni della superficie scura della Terra attraverso squarci temporanei nella nostra atmosfera.
Herschel ritiene quindi di poter guardare “dentro” le macchie più grandi, per capire la struttura e la dinamica dell’atmosfera solare, un’estesa massa fluida e densa (circa 27 volte più di quella terrestre). Un’operazione illusoria perché, come sappiamo oggi, le macchie non hanno profondità e la visione non può spingersi sotto la fotosfera opaca.
Ma c’è una domanda insidiosa alla quale bisogna rispondere: come mai l’infuocata atmosfera solare non provoca il surriscaldamento, se non l’ignizione, di tutto il globo, come nell’antico modello sfera di fuoco? Secondo Herschel, nell’atmosfera solare galleggiano due strati fluidi concentrici distinti: quello esterno, caldo e luminoso per ancora indefinite decomposizioni chimiche di nubi fosforiche, irradia luce e calore in tutte le direzioni, mentre quello interno, opaco e simile alla copertura nuvolosa della Terra, riflette la radiazione proveniente dallo strato superiore, mantenendo così il nucleo solido sottostante al riparo da luce e calore eccessivi. Il modello planetario del Sole, che oggi sappiamo sbagliato, sarà condiviso dalla maggior parte degli astronomi almeno sino alla metà dell’Ottocento, in molti casi per soggezione all’autorità scientifica di Herschel.
Pluralità dei mondi, tra scienza e religione
Sulla base del modello di Sole così definito, Herschel avanza l’idea più ardita: la presenza quasi certa di esseri viventi sulla superficie solida e fredda del nucleo solare.

Va anzitutto osservato che nel 1700 l’idea della “pluralità dei mondi”, cioè la presenza di similuomini sulla Luna, i pianeti e i supposti pianeti delle stelle, era assai diffusa: se ne parlava comunemente nei circoli culturali, nei libri di scienza e teologia, nei giornali, in racconti di fantasia. Era un’idea che aveva un fondo sia scientifico sia religioso. Per la scienza valeva il “principio di analogia” (o “di mediocrità”): se altri corpi celesti sono strutturalmente simili alla Terra è logico ritenere che, come il nostro pianeta, possano essere abitati. Per la religione valeva il “principio di pienezza”: nella sua potenza e benevolenza, Dio non poteva aver creato un mondo così grande e bello e lasciarlo poi disabitato. Un principio, peraltro, non unanimemente condiviso, perché secondo molti teologi le sacre scritture indicavano chiaramente che siamo noi terrestri i soli abitanti dell’universo.
Comunque, ammettere l’abitabilità del Sole era un salto concettuale di non poco conto anche per un pluralista convinto, ma Herschel ha pochi dubbi in proposito: «La sua somiglianza con gli altri globi del sistema solare per quanto riguarda la sua solidità, la sua atmosfera e la sua diversificata superficie, la rotazione attorno al suo asse e la caduta dei corpi pesanti ci fanno supporre che molto probabilmente sia anch’esso abitato come gli altri pianeti, da esseri i cui organi sono adatti alle peculiari condizioni di quel vasto globo».
È bene sottolineare che Herschel sostiene la presenza di esseri viventi sul nucleo del Sole non come congettura scientifica o espressione di un sentimento religioso, ma come risultato di sperimentazioni e deduzioni: «Mi sento autorizzato, in base a principi astronomici, a proporre il Sole come un mondo abitato, convinto che le osservazioni fatte giustifichino questa conclusione. Ne ho dedotto che sono sufficienti a rispondere a qualsiasi obiezione possa essere fatta».
La sfida lanciata ai colleghi di dimostrare che aveva torto è già persa nel 1807. In Natural Philosophy and the Mechanical Arts, il suo brillante giovane contemporaneo Thomas Young (1773-1829) sostiene validamente sia l’impossibilità termofisica di mantenere freddo un globo solido circondato da un’atmosfera infuocata e turbolenta che diffonde luce e calore a molti milioni di chilometri di distanza, sia le eccezionali caratteristiche fisiologiche che dovrebbero possedere gli abitanti del Sole per sopportare una forza gravitazionale superiore di circa 30 volte a quella terrestre.
Nel corso dell’Ottocento, l’idea dell’abitabilità del Sole perderà consensi con il progredire delle nuove conoscenze astronomiche, che evidenzieranno caratteristiche fisico-chimiche del Sole diverse da quelle dei pianeti e simili a quelle delle stelle. Sopravviverà invece per molti decenni, ben radicata e diffusa non solo tra gli scienziati, l’idea che extraterrestri potessero abitare la Luna e i pianeti. Secondo lo storico Michael Crowe, prima e dopo Herschel si possono contare almeno una cinquantina di “solariani”, eminenti uomini di scienza e cultura che, nel contesto della pluralità dei mondi, includono come caso estremo il Sole. Tra loro, però, Herschel rimane la figura più esposta e autorevole, perché le sue osservazioni e argomentazioni, seppur sbagliate, erano frutto di un protocollo di ricerca scientifico. Chi era venuto prima aveva potuto esprimersi solo con argomenti filosofici, religiosi o astrologici. Chi verrà dopo si limiterà in genere a qualche considerazione teologica o filosofica, affidandosi per la parte scientifica a una acritica accettazione di quanto affermato dal celebrato astronomo inglese. Per questo motivo Herschel rimane la figura chiave e distintiva tra i solariani venuti prima e dopo di lui. Nel seguito ne incontreremo alcuni con un profilo scientifico.
Solariani prima di Herschel
Pur nell’accettazione della pluralità dei mondi, nell’antichità il Sole è sempre stato escluso tra le possibili dimore extraterrestri per l’intuitiva inabitabilità della sfera di fuoco. Il primo a rompere il tabù è il cardinale Nicola Cusano (1400-1464) che, in antitesi alla dominante dottrina scolastica, sostiene l’esistenza di extraterrestri in un universo senza centro né confini. In De docta ignorantia ipotizza una “catena degli esseri” che, pur biologicamente isomorfi ai terrestri, hanno indoli conformi alle condizioni ambientali e astrologiche del corpo celeste che li ospita, tra cui il Sole: «Gli abitanti del Sole li immaginiamo più solari, luminosi e illuminati, più spirituali di quelli della Luna, che saranno invece più lunatici, mentre quelli della Terra sono più materiali e grossolani».
Concetti simili saranno esposti dal medico-filosofo François Bernier (1620-1688). Nel suo Abrégé de la philosophie de Gassendi del 1678 congettura che gli abitanti dei pianeti abbiano dimensioni proporzionali alla grandezza del pianeta che li ospita, ma con un grado di perfezione che diminuisce allontanandosi dal Sole (da Mercurio a Saturno). Gli abitanti del Sole devono essere quindi grandi e nobili, dal momento che il Sole supera in grandezza e nobiltà tutti gli altri corpi celesti. E naturalmente sono stati creati adatti a sopportare le locali condizioni estreme di luce e calore.
La presenza quasi certa di abitanti sul Sole, oltre che su pianeti e comete, è sostenuta anche da William Whiston (1667-1752), successore di Newton alla cattedra lucasiana di matematica a Cambridge, nel suo Astronomical principles of religion del 1717. Essi potrebbero vivere grazie a profonde cavità praticate dalla Provvidenza per proteggerli dal calore esterno. Incrociando dati scientifici e teologici, Roger Boscovich (1711-1787), tra i fondatori dell’Osservatorio astronomico di Brera a Milano, nella sua Philosophiae naturalis theoria (1763) ritiene possibile l’esistenza in ipso Sole et fixis di forme di vita che, adatte al particolare ambiente locale, vivono senza danni per la loro struttura organica. Un altro parere favorevole all’abitabilità del Sole viene da Johann Elert Bode (1747-1826), direttore dell’Osservatorio di Berlino, ricordato nei manuali per la “legge di Titius-Bode”, che rapporta le distanze dei pianeti dal Sole e che all’epoca lasciava un “vuoto” riempito poi dalla fascia degli asteroidi. In un articolo sulla Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde del 1776, dopo aver sostenuto che il nucleo del Sole, come la Terra, presenta monti e valli ed è avvolto da una spessa atmosfera, si chiede: se persino un granello di sabbia può ospitare un insetto, come è possibile che la grande sfera del Sole sia sprovvista di esseri intelligenti e riconoscenti al loro creatore? Questi abitanti sono illuminati da una luce intensa, senza però subire offese grazie al sapiente progetto divino che li mantiene in una sorta di paradiso.
Che il Sole potesse essere il posto più sacro dell’universo, il luogo ove Dieu a placé son tabernacle, era stato sostenuto anche dallo studioso eclettico Pierre Borel (1620-1671) nel libro Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes del 1657. Parole quasi identiche ripetute due secoli dopo, ma stavolta in latino, per sottolinearne l’esclusivo valore simbolico-religioso, da padre Angelo Secchi (1818-1878), un pluralista “possibilista”, nell’introduzione di Le Soleil del 1870: in Sole posuit tabernaculum suum Altissimus. Al contrario, appellandosi alle sacre scritture, il teologo inglese Tobia Swinden ritiene che il Sole sia la sede “fisica” dell’inferno, luogo di eterna tortura dei dannati. Nel libro An enquiry into the nature and place of hell del 1714 (all’Indice dal 1745 al 1930), sostiene che il fuoco solare è il fuoco dell’inferno, da intendere quindi non in senso metaforico ma reale. Swinden è forse il solo autore ad aver sostenuto che l’inferno non si trova sottoterra, tradizionale regno dei morti, ma nei cieli. Per il Diavolo sarebbe una magnifica dimora, da cui godersi la visione del mondo, ironizzerà il poeta romantico inglese Percy B. Shelley (1792-1822) nel racconto On the Devil, and Devils del 1817.
È interessante ricordare due sostenitori dell’esistenza di extraterrestri nel sistema solare, che però la escludono sul Sole: Bernard de Fontenelle (1657-1757) e Immanuel Kant (1724-1804). Riconoscendo la sua ignoranza sulla natura del Sole, nel suo Entretiens sur la pluralité des mondes del 1686, Fontenelle così dice alla Marchesa sua attenta discepola: «Alla fine, qualunque cosa sia il Sole, non sembra per nulla adatto a essere abitato. È un peccato, perché l’abitazione sarebbe bella e situata al centro del mondo». Il filosofo tedesco, nell’opera giovanile Die Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels del 1755, esclude il Sole dalle dimore per extraterrestri, la cui scala di virtù e sapere aumenta dalla Luna a Saturno (in senso opposto all’opinione di Cusano, Bernier e Fontenelle). Nella sua cosmologia, in analogia non solo formale alle stelle, il Sole è «un vero e proprio corpo infiammato» che «ha il grande vantaggio di essere attivo per sé stesso».
Solariani in Tribunale
Due sostenitori del Sole abitato ebbero curiosamente a che fare con la giustizia.
Il primo caso, riportato in The Gentleman’s Magazine del luglio 1787, riguarda il medico John Elliot (1747-1787), autore di diversi trattati riguardanti i colori e l’oculistica, portato davanti al giudice per avere minacciato con una pistola dei passanti a Londra. Il suo avvocato, cercando di alleggerire la probabile condanna del suo cliente, ne sostenne l’insanità mentale, adducendo tra le prove una lettera in cui Elliot sosteneva che il Sole era abitato. Il giudice però non ne tenne conto in quanto la stessa opinione era stata espressa anche da alcuni scienziati. Elliot si lasciò morire di fame in carcere pochi mesi dopo.
Il secondo caso riguarda l’allora settantenne ingegnere e astrofilo tedesco Godfried Bueren, che nel 1950 lanciò una doppia sfida alla Astronomische Gesellschaft (AG), la società astronomica tedesca: era disposto a pagare 25.000 marchi a chi riuscisse a dimostrare che il Sole non era abitabile e altri 25.000 a chi fosse in grado di provare gli elevati valori di temperatura e pressione attribuiti al Sole e a Sirio. La AG contestò a Bueren solo il primo punto, ma per decidere chi avesse ragione, nel 1951, di comune accordo, fu nominata una commissione di tre esperti super partes: il fisico quantistico Premio Nobel Werner Heisenberg, l’astrofisico Clemens Schäfer e il giurista internazionale Fischer.
Il verdetto fu ovviamente a sfavore di Bueren che, in seconda istanza, nel 1953 fu condannato a pagare quanto previsto. Tuttavia, sostenendo di avere avuto solo risposte generiche già note nell’ambiente scientifico, Bueren presentò un ulteriore ricorso, ma prima che la terza istanza si concludesse con un’altra sentenza per lui negativa, morì in un incidente stradale. Furono quindi gli eredi a versare nel 1956 i 25.000 marchi alla AG, che destinò la somma a un Fondo Bueren destinato a ricerche di giovani astronomi. In tal modo, il nome di Bueren è oggi ricordato, anziché come testardo sostenitore di un’idea stravagante, come benefattore della ricerca astronomica.
Solariani dopo Herschel
Nel corso dell’800, le nuove tecnologie della fotografia e della spettroscopia evidenziano le diversità tra i pianeti e il Sole: la sua abitabilità passa dalla quasi certezza alla probabilità e, infine, alla negazione.

Un altro scozzese, il fisico e teologo David Brewster (1781-1868) in More worlds than one del 1854, condivide il modello solare di Herschel e l’abitabilità del suo nucleo freddo. D’altra parte, è impensabile che Dio abbia lasciato disabitato proprio il corpo celeste più grande e magnifico. Insomma, un posto speciale pieno di luce, occupato da esseri speciali per intelligenza. D’altronde, secondo Brewster dove c’è materia c’è vita.
Verso la metà dell’Ottocento crescono i dubbi sulla presenza di esseri viventi sul Sole, ritenuta solo probabile o possibile. Così, François Arago (1786-1853), direttore dell’Osservatorio di Parigi, nella Astronomie Populaire del 1857, pur ancora convinto che il nucleo del Sole sia un solido circondato da un’atmosfera luminosa, scrive: «Se mi chiedessero semplicemente: il Sole è abitato? Risponderei che non lo so. Ma se mi chiedessero se il Sole può essere abitato da esseri organizzati in maniera analoga a quelli che abitano il nostro globo non esiterei a dare una risposta affermativa».
Anche l’astronomo e divulgatore francese Camille Flammarion (1842-1925), aperto sostenitore della vita superiore sui pianeti, ha qualche riserva riguardo all’abitabilità del Sole. In La pluralité des mondes habités del 1862 ritiene che, pur tenendo in conto le condizioni ambientali del Sole rivelate dall’astrofisica, non si possa escludere la presenza locale di esseri superiori, che però devono essere molto diversi da noi terrestri. Possibilista è anche Fernand Coyteux (1800-?), altro sostenitore della pluralità dei mondi, che conclude il suo libro Qu’est-ce que le Soleil? Peut-il être habité? del 1866 convinto che non vi siano reali motivi contro l’abitabilità del Sole e per logica estensione delle stelle. Anche Léger-Marie Pioger (1821-1899) in Les splendeurs de l’astronomie – Le Soleil (1883) sostiene che niente si oppone all’abitabilità del Sole anche se le composizioni dell’atmosfera terrestre e solare sono totalmente diverse.
Già nel 1859 però si registra una decisa opinione scettica: è l’astronomo Jean-Baptiste Liagre (1815-1891) ad affermare sul Bulletin de l’Académie de Belgique che il Sole è qualcosa di molto diverso dai pianeti, presumibilmente un fuoco ardente, e quindi va combattuta l’idea della sua abitabilità. L’astronomo inglese Richard Proctor (1837-1888) in Other worlds than ours del 1870 difende l’idea della pluralità dei mondi, ma la ritiene «bizarre and fanciful» riguardo al Sole. Nel 1873 il divulgatore Amédée Guillemin (1826-1893) conclude il libro Le Soleil ritenendo impossibile che il Sole possa ospitare forme di vita organizzate.
L’ultimo a sostenere l’esistenza di esseri viventi sul Sole è stato Brigham Young (1801-1877), teologo e presidente della chiesa mormone, che è orientata alla pluralità dei mondi. È l’esaurimento di un’idea: alla fine dell’Ottocento il tema dell’abitabilità del Sole gradualmente scompare dai testi astronomici e da quelli del pluralismo alieno, anche solo per negarla, perché oramai priva di curiosità storica oltre che di valore scientifico. Per l’astrofisica è l’inizio di un percorso che si concluderà alla fine degli anni '30 del Novecento con l’attuale modello stellare del Sole: una stratificata massa di gas surriscaldata e ipercompressa in equilibrio termico e gravitazionale, che produce energia tramite fusione di idrogeno in elio.
Un nuovo-vecchio modello di Sole
Nei libri di storia dell’astronomia si ricordano i grandi risultati ottenuti da Herschel, ma sovente si passa sotto silenzio la sua convinzione sull’abitabilità del Sole, quasi fosse un ridicolo svarione della sua straordinaria carriera scientifica. A parte il fatto che Herschel condivise questa idea con altri scienziati, dobbiamo pensare a quel poco che si sapeva allora del Sole, al certosino lavoro di osservazione che sembrava dargli certezze scientifiche e al contesto culturale del suo tempo fortemente orientato, anche per motivi religiosi, alla pluralità dei mondi. Basata su un modello solare sbagliato, era un’idea sbagliata che, come altre bocciate successivamente, è stata però utile al progresso della conoscenza scientifica. Appare invece sorprendente come, passando dal modello planetario al modello stellare, il Sole sia tornato, almeno concettualmente, ad assomigliare così tanto alla vecchia e inospitale sfera di fuoco.
Bibliografia
- Crowe, M.J., 2011. “The surprising history of claims for life on the Sun”, in Journal of Astronomical History and Heritage, vol. 14, n. 3
- Herschel, W., 1795. “On the nature and construction of the Sun and fixed stars”, in Philosophical Transactions, vol. 85
- Herschel, W., 1801. “Observations tending to investigate the nature of the Sun, in order to find the causes or symptoms of its variable emission of light and heat; with remarks on the use that may possibly be drawn from solar observations”, in Philosophical Transactions, vol. 91
- Kavaler, S., Veverka J., 1981. “The habitable Sun: one of William Herschel’s stranger ideas”, in Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, vol. 75, n. 1
- Öpik, E., 1965. “Is the Sun habitable?”, in Irish Astronomical Journal, vol. 7, n. 1
- Young, T., 1807. A course of lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts, vol. 1