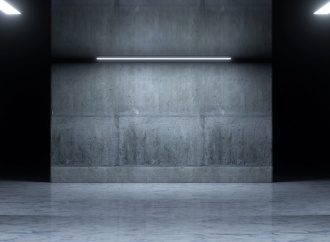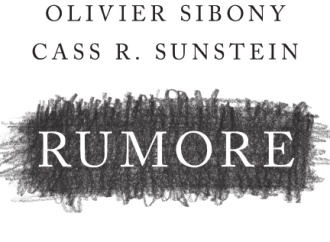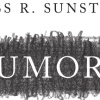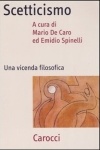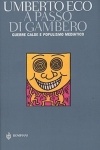SOCRATE: Consideriamo la questione in questo modo. Se il saggio o qualsiasi altro uomo vuole distinguere il vero medico da chi non lo è, come procederà? [...] Colui che vuole indagare sulla natura della medicina non deve forse metterla alla prova nella salute e nella malattia, che sono la sfera della medicina, e non in ciò che le è estraneo e non rientra nella sua sfera?
L’ALTRO: È vero.
SOCRATE: E colui che vuole mettere alla prova il medico in quanto medico, non lo metterà dunque alla prova in ciò che riguarda queste cose?
L’ALTRO: Sì.
SOCRATE: Considererà se ciò che dice è vero e se ciò che fa è giusto in relazione alla salute e alla malattia?
L’ALTRO: Sì.
SOCRATE: Ma è possibile indagare sull’una o l’altra cosa se non si ha una conoscenza della medicina?
L’ALTRO: No.
SOCRATE: Nessuno, a quanto pare, può avere questa conoscenza, tranne il medico, e quindi non il saggio. Dovrebbe essere un medico oltre che un saggio.
L’ALTRO: Verissimo
Questo, in estrema sintesi, è il problema della competenza: sembra che l’unico metodo per valutare se un esperto è effettivamente un esperto sia esserlo a propria volta. Il lato positivo è che questo è ciò che giustifica l’uso della peer review nella scienza: se, per esempio, voglio scrivere un articolo sulla meccanica quantistica o sulla teoria dell’evoluzione, devo sottoporlo alla revisione (di solito anonima) di diversi scienziati la cui specializzazione è la meccanica quantistica o la teoria dell’evoluzione. L’idea non è che gli esperti siano infallibili, ma piuttosto che siano le persone più qualificate (spesso le uniche) per esprimere un giudizio su questioni tecniche.
Il lato negativo di questa prospettiva, invece, sembra il fatto che se pensassi – e lo penso – che Deepak Chopra dice sciocchezze quando parla di elisir di giovinezza meccanici quantistici, dovrei prima diventare un esperto di mistica quantistica. Il problema è che il misticismo quantistico è una ciarlataneria (credo io) e quindi non esiste una “competenza” nel misticismo quantistico, benché la meccanica quantistica sia una delle teorie scientifiche più consolidate di tutti i tempi (d’altronde, io non sono nemmeno un esperto di meccanica quantistica!). Quindi, la domanda si pone di nuovo: come fa una persona di media intelligenza a distinguere tra scienza e pseudoscienza senza diventare un esperto di entrambe? E per di più, come è mai possibile diventare esperti di assurdità?
Il filosofo Alvin Goldman (2006) ha suggerito una risposta che ha il vantaggio di essere radicata in una profonda comprensione del problema e al tempo stesso di offrire suggerimenti pratici per coloro che non sono esperti di tutto. Goldman propone una guida in cinque punti per capire se la nostra fiducia in un potenziale esperto è fondata o meno:
- Esaminare gli argomenti presentati dall’esperto e dai suoi rivali;
- Cercare prove che altri esperti siano concordi;
- Cercare prove indipendenti che l’esperto sia effettivamente un esperto;
- Indagare su quali pregiudizi possa avere l’esperto in merito alla questione in oggetto;
- Esaminare il curriculum e la storia professionale dell’esperto.
Talvolta il primo criterio è sufficiente. Pur non essendo esperti, a volte siamo in grado di capire se le argomentazioni di un presunto esperto reggono anche a un esame superficiale, oppure possiamo capire che si tratta di un impostore anche se non siamo in grado di confutarne direttamente le argomentazioni. Per esempio, si presume che un politico sia un esperto di politiche pubbliche, una persona che vuole convincerci di avere un’idea migliore dei suoi avversari su come gestire le cose. Potremmo essere in grado di valutare la sua affidabilità utilizzando il primo criterio di Goldman. Per cominciare, la maggior parte dei politici non è più esperta di noi in materia di economia, il che significa che almeno alcuni dei loro argomenti possono essere valutati direttamente, se ci si prende la briga di ascoltare e di informarsi un po’. Esistono anche approcci indiretti: a volte è possibile cogliere i politici in contraddizioni flagranti mentre dicono cose diverse a pubblici diversi, per cui sospettiamo immediatamente che ci sia qualcosa che non va.
Il problema del primo criterio di Goldman si presenta quando si tratta di ambiti più complicati, come i dibattiti sull’evoluzione o sul riscaldamento globale. In questi casi, la maggior parte delle persone non ha il bagaglio tecnico necessario per una valutazione diretta degli argomenti, e le tecniche indirette spesso falliscono perché, per esempio, un predicatore evangelico creazionista può essere più abile dal punto di vista retorico di un accademico che esce di rado dal suo laboratorio.
Passiamo quindi al secondo criterio di Goldman, cioè cercare prove di accordo tra gli esperti. In pratica, si tratta di questo: puoi anche essere convinto che la tua auto non parte per colpa di un problema alle candele, ma se vari meccanici ti dicono che le candele sono a posto e che invece devi sostituire, per esempio, la pompa di iniezione, saresti uno sciocco se andassi a comprare delle candele nuove. Tuttavia, purtroppo è fin troppo facile trovare almeno alcuni “esperti” che difendono quasi ogni tipo di assurdità. Gli annali della scienza sono pieni di scienziati (a volte anche di spicco) che si sono fatti abbindolare da qualche idea strampalata, basti pensare alla fascinazione di Newton per l’alchimia o alla difesa dello spiritismo da parte di Alfred Russel Wallace (scopritore insieme a Charles Darwin della selezione naturale).
Ecco quindi il terzo criterio di Goldman: esaminare qualsiasi prova indipendente che dimostri che l’esperto è, di fatto, un esperto. Questo esclude immediatamente la maggior parte dei creazionisti e dei sostenitori dell’intelligent design: la stragrande maggioranza di loro non ha una laurea in scienze, e quei pochi che ce l’hanno spesso hanno ricevuto quelle “lauree” da università non accreditate. Inoltre, i pochi con lauree legittime, come Michael Behe della Lehigh University o Bill Dembski del Discovery Institute, spesso le hanno acquisite in campi non correlati (rispettivamente, biochimica e filosofia): un dottorato in biochimica non fa di qualcuno un esperto di biologia evolutiva, così come il mio dottorato in biologia evolutiva non fa di me un esperto di biochimica (credetemi, non lo sono).
Anche gli esperti, tuttavia, possono essere prevenuti o semplicemente comprati, per esempio, da un’azienda farmaceutica o del tabacco (essere comprati è un’altra forma di pregiudizio); ecco perché il quarto criterio di Goldman dice che dovremmo indagare sui pregiudizi che potrebbero influenzare l’opinione di un esperto. L’esempio che cita è quello di un famoso studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association (JAMA), in cui gli autori hanno esaminato le ricerche sui farmaci antitumorali tenendo traccia della provenienza dei loro finanziamenti. I risultati, forse non sorprendenti per chi conosce la natura umana, sono imbarazzanti per la comunità della ricerca medica: il 38% degli studi sponsorizzati da organizzazioni indipendenti (come il governo federale) ha dato valutazioni negative sull’efficacia dei farmaci testati, mentre solo il 5% degli studi sponsorizzati dall’industria farmaceutica ha riferito che non avevano effetti.
Naturalmente, la scienza è un’attività umana e ci si aspetta che i pregiudizi umani possano farne parte. Ma bisogna osservare che lo studio del JAMA è stato condotto da scienziati: è la capacità della scienza di autovalutarsi, autocriticarsi e autocorreggersi che ci mostra ancora una volta sia il potere sia i limiti dell’impresa scientifica.
Esaminiamo infine la quinta fonte di prova a disposizione di un profano istruito per capire quanta fiducia riporre in un sedicente esperto: il suo curriculum e la sua storia professionale. In effetti, è quello che facciamo nelle situazioni di tutti i giorni: continuiamo a rivolgerci allo stesso meccanico perché ha avuto successo nel risolvere i problemi della nostra auto; se non ci fosse riuscito, ne avremmo cercato un altro. Naturalmente, come ogni strumento descritto finora, anche questo deve essere usato con cautela. Un uso improprio comune è legato a quello che potremmo definire effetto celebrità, ovvero la tendenza di alcune persone di successo a esprimersi su qualunque cosa, facendo dichiarazioni che molti prenderanno per buone anche se riguardano campi completamente scollegati da quello in cui la persona in questione ha avuto successo.
Goldman sa bene che le sue cinque raccomandazioni non sono un metodo infallibile per distinguere la competenza dalle mistificazioni. In effetti, una parte importante della mia argomentazione è che un metodo infallibile non esiste. Ma Goldman ci invita ad affidarci all’approccio generale noto come inferenza verso la spiegazione migliore, che cerca di soppesare tutte le prove disponibili per poi formulare un’ipotesi informata su dove possa trovarsi la verità. Il più delle volte, le ipotesi informate sono tutto ciò che abbiamo, e in quel caso, più sono informate, meglio è.
L’originale di questo articolo è stato pubblicato su Skeptical Inquirer, volume 47, n. 5, 2023. Traduzione di Fara di Maio. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati
Bibliografia
- Goldman, A.I., 2006. «Experts: Which ones should you trust? », in The Philosophy of Expertise, E. Selinger and R.P. Crease (a cura di), Columbia University Press