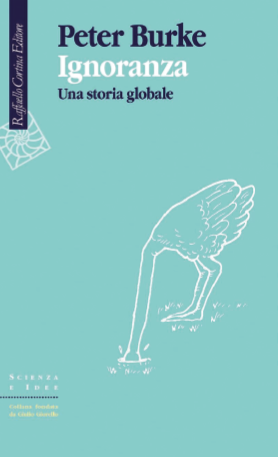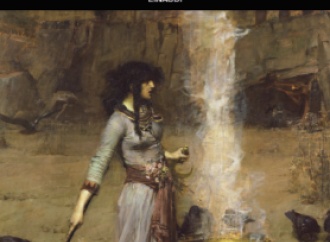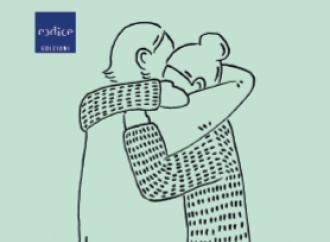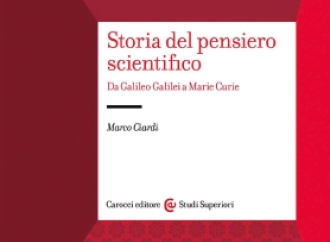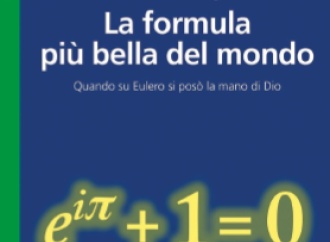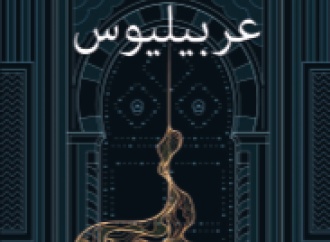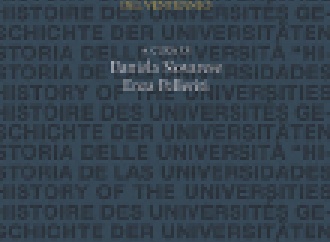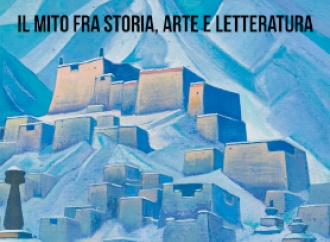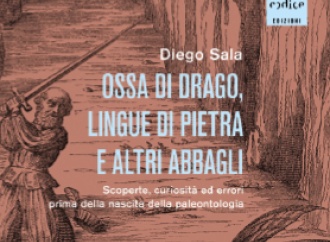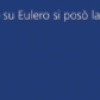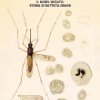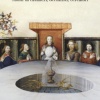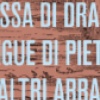Ignoranza.
Una storia globale
di Peter Burke
Raffaello Cortina, Milano, 2023
pp. 388, euro 25,00
In una conferenza stampa ai tempi della guerra in Iraq, l’allora segretario alla Difesa americano Donald Rumsfeld se ne uscì con una celebre classificazione: esistono i known knowns, le cose che sappiamo; i known unknowns, le cose che sappiamo di non sapere; e gli unknown unknowns, le cose che non sappiamo di non sapere. L’intero scibile umano è dedicato a mappare le cose che sappiamo; ci sono alcune rarissime opere che tracciano i confini della nostra conoscenza e praticamente nulla riguardo a ciò che semplicemente ignoriamo.
A colmare questa lacuna ci ha pensato Peter Burke, tra i massimi storici viventi, fondatore di intere discipline (dalla storia culturale allo studio delle culture popolari fino alla storia sociale dei media), dotato di cultura enciclopedica. E un’enciclopedia sui generis è in effetti questa sua ultima opera, che si apre con una professione di ignoranza: è una storia globale sì, alla maniera della moderna corrente della global history, ma quasi tutto riguarda la storia dell’Occidente, e il motivo è molto semplice: «Per ignoranza, Madame, per pura ignoranza» (la frase è di Samuel Johnson).
Questo tuttavia non è un problema, proprio perché si tratta di un libro che si propone di tracciare delle rotte lasciando ad altri il compito di proseguire l’itinerario, quasi una sorta di testamento spirituale che Burke ci affida dopo un’esistenza passata a colmare le lacune della nostra conoscenza. Ignoranza non è una trattazione sistematica, ma un insieme di suggestioni e digressioni sul tema: l’ignoranza nella scienza, nella geografia, nella politica, nelle organizzazioni, ovviamente nella storia, insieme a un elenco delle conseguenze che ne derivano, a volte drammatiche, a volte ridicole, a volte entrambe le cose. Come quando scopriamo che Mussolini ignorava lo stato della sua aeronautica militare perché «durante i giri di ispezione estiva degli squadroni dell’aviazione vennero più volte mostrati gli stessi contingenti militari, senza suscitare alcun sospetto». O che un sondaggio del Daily Mail rivelava nel 2012 che oltre il 50% degli inglesi adulti pensava che l'Everest fosse in Gran Bretagna.
Al di là dell’aneddotica, Burke ci porta a riflettere su come il modo in cui cambia il nostro livello di conoscenza (e dunque di ignoranza) nel corso della storia abbia ripercussioni sociali. Un esempio è quello della peste bubbonica, affrontata ogni volta in modi diversi: processioni per placare la collera di Dio, persecuzioni contro gli Ebrei accusati di avvelenare i pozzi, caccia agli untori; e aggiungiamo Don Ferrante, che nei Promessi sposi cerca di interpretare il fenomeno con categorie aristoteliche e spiegazioni astrologiche, e fa la fine che fa.
Studiare ciò che l’umanità ignora nelle diverse epoche storiche è quindi un ottimo modo di fare storia culturale, e Burke fa sua una suggestione di C.S. Lewis, il quale osservava come gli umanisti rinascimentali disprezzassero la filosofia medievale non per fondate conoscenze, ma appunto per ignoranza, e ciò in quanto «ogni nuovo apprendimento fa spazio a sé stesso creando una nuova ignoranza».
La conseguenza è una evidente relativizzazione del nostro attuale livello di conoscenze come civiltà. Perlomeno, nel Medioevo si accettava che gli Antichi ne sapessero di più e si accettavano principi come la docta ignorantia (espressione coniata da Nicola Cusano), secondo cui tutto ciò che si può dire di Dio è ciò che non è. Ancora nella seconda metà dell’Ottocento, Emil Du Bois-Reymond pronunciava la celebre ammissione: «Ignoramus et ignorabimus» (ignoriamo e ignoreremo). Ma negli anni Trenta il matematico David Hilbert gli avrebbe replicato: «Dobbiamo sapere, sapremo», per poi imbattersi negli hic sunt leones (altra formula per definire la nostra ignoranza) dei teoremi di Gödel e della meccanica quantistica.
Freud ha parlato di “ignoranza inconscia” riguardo il vero significato dei sogni, Popper di “ignoranza attiva” da parte di quanti rifiutano di accettare nuove idee, John Rawls di “velo di ignoranza” nei confronti delle peculiarità etniche, nazionali, di classe e di genere per fondare una vera uguaglianza, e di recente si parla di “ignoranza virtuosa” suggerendo di dimenticare i princìpi di costruzione delle bombe atomiche. Anche il concetto stesso è dunque destinato a mutare nel tempo (Sant’Agostino parlava della “ignoranza invincibile” dei pagani morti prima dell’avvento di Cristo), e Burke ci invita a prenderne atto per non cullarci nella nostra presunzione di superiorità, immaginando cosa penseranno di noi i nostri pronipoti quando scriveranno di tutto ciò che oggi ignoriamo.