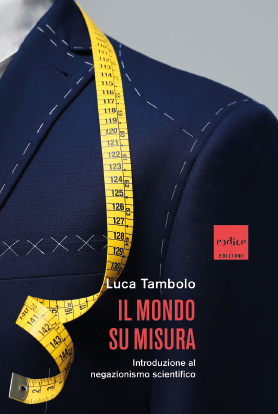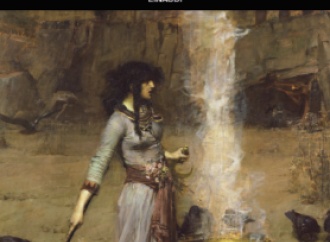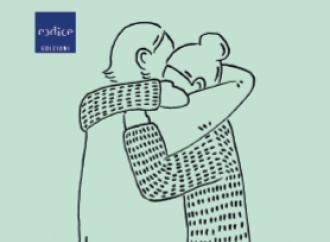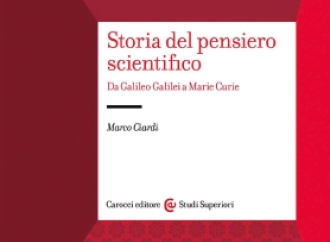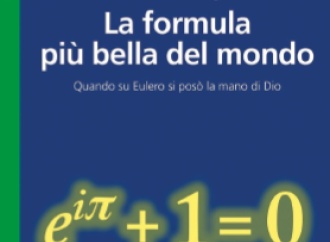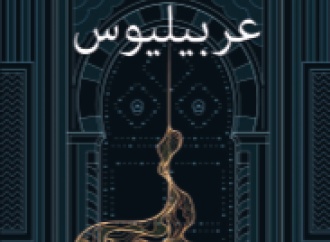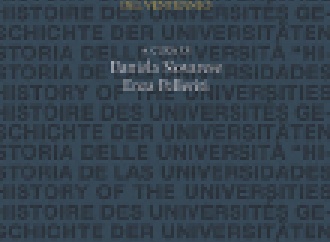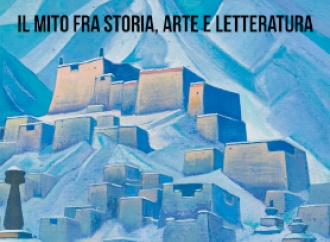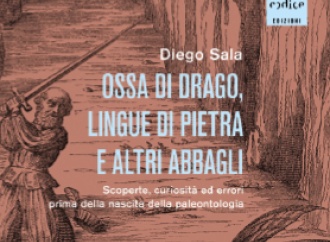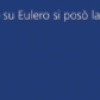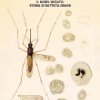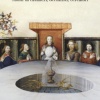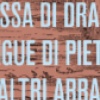Il mondo su misura.
Introduzione al negazionismo scientifico
di Luca Tambolo
Codice Edizioni, Torino, 2024
pp. 216, euro 18,00
Il concetto di “negazionismo scientifico” è relativamente recente: l’espressione è entrata nell’uso corrente, a quanto pare, con la pubblicazione di Denialism di Michael Specter nel 2009. Intendiamoci: non che prima non ci fossero negazionisti scientifici, e comunque il termine è stato usato fin dagli anni ’70 del Novecento per descrivere una particolare corrente del revisionismo storico, il “negazionismo dell’Olocausto”, secondo la quale le stragi di ebrei negli anni ’40 non sarebbero mai avvenute.
Anche solo basandosi su una definizione “ingenua” di negazionismo scientifico, cioè genericamente come una corrente di pensiero che per qualche ragione nega i risultati acquisiti dalla scienza, se ne intuiscono subito i rischi; per esempio, nell’influenza sui processi decisionali pubblici, che si vorrebbero razionali e basati su conoscenze consolidate. Un esempio ovvio e recente sono le politiche vaccinali, la cui discussione non è solo scientifica (implicando per esempio argomentazioni sulle libertà individuali), ma non può prescindere dai dati scientifici sull’efficacia e sicurezza dei vaccini.
Appena si guarda meglio, però, ci si rende conto che questa definizione “ingenua” non basta. Un negazionista non dovrebbe rifiutare in toto i risultati scientifici, o la scienza stessa? E allora perché molti antivaccinisti non hanno alcun problema, per dire, con la teoria dell’evoluzione o il cambiamento climatico? Negazionismo scientifico e pseudoscienza sono la stessa cosa? In che senso un risultato scientifico è “acquisito”, e come si distingue il negazionismo dal normale dibattito interno alla scienza? Quali sono le ragioni del negazionismo? E, infine, come possiamo difenderci?
Esiste una letteratura scientifica su queste domande, anche piuttosto vasta; Il mondo su misura è un buon punto di accesso a un tema complesso, e può servire anche come introduzione a un ragionamento più generale su come funziona la scienza, dato che non dà nulla per scontato e fornisce una ampia e accessibile bibliografia per allargare lo sguardo.
Si tratta perciò, ed è la sequenza dei capitoli, di definire anzitutto con precisione cosa sia un negazionista scientifico e come riconoscerlo, per poi cercare di capire come mai le idee negazioniste abbiano l’innegabile successo che si osserva. Solo dopo si potranno cercare delle strategie per difendersi.
Il negazionista non è, come detto, qualcuno che rifiuta in toto la scienza (personaggio che magari esiste, ma è certamente rarissimo e, se davvero coerente, destinato a una vita ai margini del mondo e probabilmente breve) ma ne rifiuta alcuni particolari, specifici risultati: Tambolo lo chiama il carattere “sartoriale” del negazionismo scientifico. È questo aspetto che suggerisce come una possibile spiegazione del successo delle idee negazioniste sia la dissonanza tra uno specifico risultato scientifico e un qualche aspetto identitario del negazionista; un esempio ovvio è il rifiuto della teoria dell’evoluzione per ragioni religiose. Ma a questo si aggiungono anche altri meccanismi. Per esempio, la mentalità negazionista somiglia in certi aspetti a quella complottista: le accomuna, tra le altre cose, la strategia della ricerca di una minima crepa nella “versione ufficiale” dei fatti che permetta di farla crollare completamente, o perlomeno di seminare dubbi.
Queste somiglianze suggeriscono come un ulteriore elemento sia l’interazione tra la dissonanza citata prima e i bias cognitivi che influenzano, inevitabilmente, la percezione e l’interpretazione della realtà: il bias di conferma, per esempio, spingerà il negazionista a fidarsi principalmente delle informazioni che offrono sostegno alle sue idee, esattamente come il complottista (e, in realtà, ognuno di noi). Ma anche queste spiegazioni hanno i loro limiti, e c’è ancora del lavoro di ricerca da fare sia per comprendere a fondo il fenomeno, come spiega l’autore, sia per trovare strategie di difesa.
Tuttavia, dato che non esiste una ricetta semplice e automatica per definire un negazionista scientifico, si può provare a riconoscerlo dalle strategie che usa per affermare le sue idee; per esempio, il ricorso alla “fallacia di Galileo”: Galileo aveva contro tutto l’establishment scientifico del suo tempo ma aveva ragione, io ho contro tutto l’establishment scientifico di oggi e, dunque, potrei aver ragione. La risposta definitiva a questa argomentazione l’ha data Carl Sagan in Broca’s Brain: «Hanno riso di Cristoforo Colombo, hanno riso di Robert Fulton e dei fratelli Wright, ma hanno riso anche di Bozo il clown».