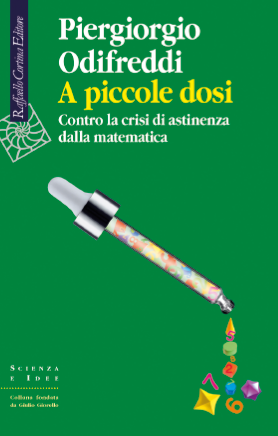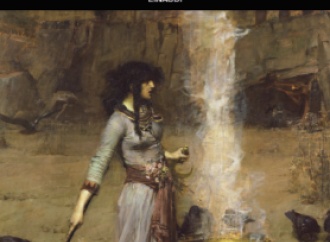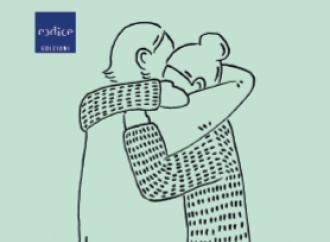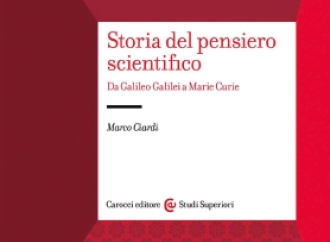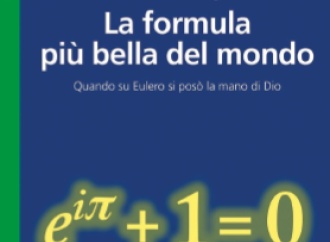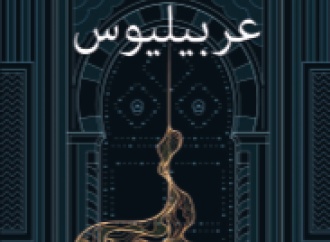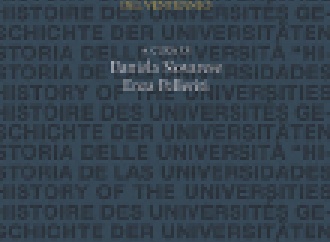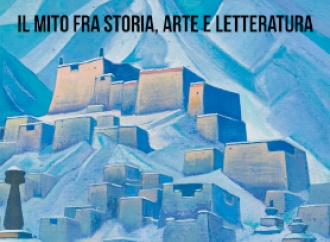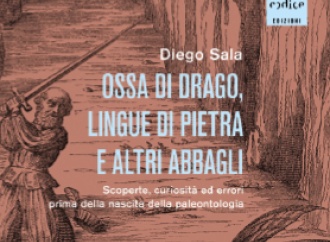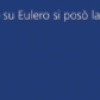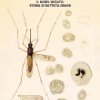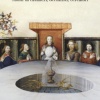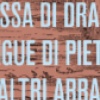A piccole dosi
di Piergiorgio Odifreddi
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2023
pp. 357, euro 25,00
Nel numero di dicembre 2023 di Le Scienze, l’edizione italiana di Scientific American, Piergiorgio Odifreddi ha pubblicato l’ultimo articolo della sua rubrica “Il matematico impertinente”. È probabile che il titolo della rubrica sia stato a suo tempo scelto dal logico piemontese come una via di mezzo tra un gioco di parole e un manifesto programmatico: Odifreddi è infatti uno dei pochissimi matematici che siano riusciti a farsi conoscere dal grande pubblico, e lo ha fatto anche valicando spesso gli angusti confini della scienza dei numeri.
Forse per questo ha scelto quell’aggettivo dalla duplice valenza: “impertinente” ha infatti un primo significato preciso, quasi giuridico, che indica proprio l’assenza di spettanza, di competenza, ovvero del diritto di esprimere un giudizio qualificato su un determinato argomento; per esempio, un processo non può essere celebrato da un tribunale che non abbia pertinenza geografica sul reato ascritto. Ma il linguaggio colloquiale riserva a “impertinente” anche un altro significato, ovvero quell’attributo che si assegna a coloro che si mostrano un po’ irrispettosi e dotati di un eloquio portato alla dissacrazione. Odifreddi ha sempre cavalcato gioiosamente entrambe le letture della parola, esprimendo le proprie opinioni, anche su questioni non matematiche, senza risparmio di giudizi spesso pungenti.
Nel caso specifico di una rubrica per Le Scienze, però, era difficile mantenere la duplice tipologia di impertinenza: se gli era consentito (e forse auspicato) spaziare su temi anche apparentemente lontani dalla matematica, era la stessa natura scientifica della rivista a costringerlo a trovare le connessioni che poi riportavano tutti gli articoli, per quanto variegati, nell’alveo della matematica: e la matematica è l’unico campo in cui Odifreddi non può chiamarsi impertinente, almeno nel significato più rigoroso della parola.
Anche se quello dello scorso dicembre non è stato un vero addio alla rivista (curerà una rubrica bimestrale sui classici della letteratura scientifica), la chiusura della sua ventennale “impertinenza” rappresenta una cesura comunque significativa, perché la rubrica è durata vent’anni esatti, per un totale di 240 articoli in cui la matematica è protagonista: talvolta fin dall’inizio del pezzo, talvolta invece entra in scena quasi a sorpresa, come un deus ex machina chiamato a risolvere una situazione difficile.
Come lo stesso autore riconosce, tenere una rubrica fissa di matematica su Le Scienze conduce immancabilmente al confronto con Martin Gardner, nume sacro a tutti i matefili del mondo occidentale, e Odifreddi non nasconde di aver sentito il peso, vent’anni fa, di cotanta eredità. Se Gardner riusciva ad alternare articoli di cultura matematica a problemi di matematica ricreativa da sottoporre ai lettori, Odifreddi ha preferito tralasciare l’aspetto ludico in favore delle analisi sul ruolo della matematica rispetto alla società e alle altre discipline della cultura.
Così, i 240 articoli generati da questa ventennale esperienza risultano indipendenti l’uno dall’altro (anche se si trovano spesso rimandi ad argomenti già trattati in articoli confratelli) ed era quasi inevitabile che si ritrovassero infine raccolti in un libro. In due libri, a dire il vero: il primo è uscito nel 2022 con il titolo Pillole di matematica, seguito pochi mesi fa dal gemello A piccole dosi. I due libri si dividono con aritmetica equità gli articoli, raccogliendone 120 per uno, e il criterio di assegnazione a uno o all’altro volume è quello del grado di difficoltà della matematica trattata: un po’ più leggero nella prima raccolta, dove sono più frequenti i testi interdisciplinari, un po’ più alto nella seconda, in cui sono convogliati gli articoli con un maggiore tasso di teoria.
Certo, chi apprezza la prosa di Odifreddi dovrebbe procurarsi entrambi i volumi, perché la scissione in due libri appare comunque artificiale, dovuta più a esigenze editoriali e di marketing che ad altri reali motivi. I due libri sono insomma due parti della stessa opera, che di per sé è già atomizzata in 240 piccoli saggi di argomento variabilissimo. Ciò comporta la quasi totale impossibilità di dare giudizi di merito sui contenuti specifici, ma è più che abbastanza per riconoscere che l’augurio veicolato dal sottotitolo del secondo volume (Contro la crisi di astinenza dalla matematica) possa essere serenamente soddisfatto.