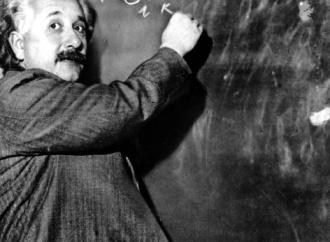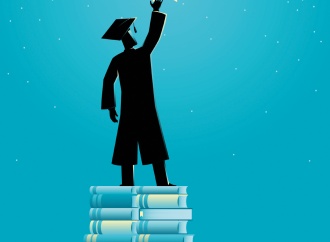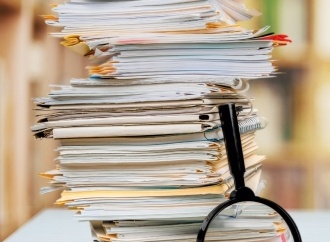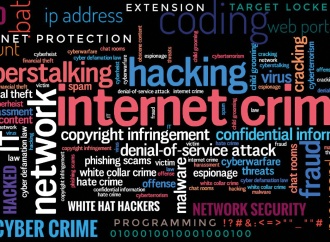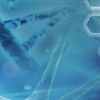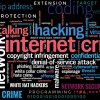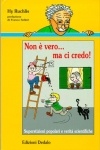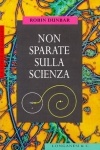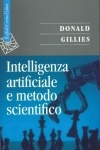Tuttavia la questione è molto più complessa di quanto potrebbe apparire da questo riassunto, e richiede un approfondimento. Il problema di fondo è questo: soltanto i ricercatori che lavorano in un determinato campo sono davvero in grado di valutare con cognizione di causa se un’affermazione relativa a quel campo è scientificamente valida o no. La capacità di interpretare i risultati di una disciplina e di collocarli in un quadro accurato che tenga conto di tutte le sfumature e le problematiche del settore appartiene solo agli scienziati di quella disciplina e non si può trasferire a nessun’altra, spesso nemmeno a quelle contigue. E, dato il ritmo martellante delle pubblicazioni scientifiche, solo chi è immerso in un settore possiede un quadro aggiornato della ricerca. Quando gli scienziati di una stessa area di ricerca raggiungono conclusioni diverse, chi non fa parte di quell’area non ha gli strumenti necessari per determinare autonomamente quale sia la conclusione più affidabile, e per questo deve fare riferimento al consenso.
La scelta di affidarsi al consenso scientifico può non piacere, ma non potendo giudicare le controversie scientifiche autonomamente l’unica alternativa sarebbe rimettersi al parere di un singolo studioso e in questo modo la probabilità di sbagliare sarebbe più alta, come mostra nella giurisprudenza americana il “paradosso dell’esperto”. All’interno di un processo, sia l’accusa sia la difesa hanno il diritto di chiamare a testimoniare singoli esperti per aiutare il giudice o la giuria ad accertare i fatti in complesse questioni scientifiche o tecnologiche. In questi casi non si tratta di valutare un fenomeno nel suo insieme, ma le sue conseguenze individuali, per esempio se una determinata sostanza chimica possa aver causato un certo danno biologico. Gli esperti chiamati dall’accusa e dalla difesa possono dare opinioni opposte e spetta al giudice decidere quali testimonianze esperte escludere in quanto basate su fatti insufficienti o su metodi inappropriati. Ma gli esperti sono stati chiamati a testimoniare proprio perché, a differenza del giudice e della giuria, conoscono bene i fatti disponibili e i metodi da seguire. Come può il giudice stabilire chi tra loro è più attendibile? A causa di questo evidente paradosso, alcuni giuristi propongono di abbandonare il ricorso alle testimonianze di singoli esperti e affidarsi invece… al consenso scientifico.
Bisogna precisare che, come accade con molti altri termini, nel linguaggio scientifico anche la parola “consenso” ha un significato articolato che non coincide con quello del linguaggio comune. Il “consenso scientifico” non rappresenta semplicemente il parere della maggioranza degli scienziati, come quello che si raccoglie con un sondaggio di opinione, ma comporta una valutazione complessiva dell’attendibilità di una posizione scientifica, che deve comprendere tipologie di prove indipendenti ma convergenti verso la stessa conclusione. Per esempio, nel caso del riscaldamento globale esistono prove ricavate da discipline diverse come geologia, fisica dell’atmosfera, planetologia, eccetera. Il più delle volte il consenso scientifico richiede una buona familiarità con la letteratura scientifica per essere accertato in quanto non è definito in modo formale. Fanno eccezione, per esempio, le consensus conference in medicina e i rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sul riscaldamento globale, che definiscono formalmente il consenso scientifico in un dato momento.
Non sempre i ricercatori di una determinata area raggiungono il consenso: per esempio, nei rami della fisica teorica che tentano di unificare in un solo quadro concettuale la relatività generale e la teoria dei campi quantistici, in mancanza di dati non c’è ancora un consenso sul modello da adottare, ma ci sono teorie concorrenti. In futuro è possibile che una delle attuali teorie, opportunamente sviluppata, prevalga sulle altre oppure che più teorie differenti finiscano per convergere in un unico modello più avanzato ancora da realizzare, ma solo gli specialisti saranno in grado di stabilirlo.
Questo non significa che il consenso scientifico fornisca certezze assolute: può cambiare nel tempo, anche in maniera profonda, attraverso le cosiddette “rivoluzioni scientifiche”. Tra i casi più recenti in cui un consenso scientifico apparentemente solido si è sgretolato in seguito all’emergere di nuovi dati e nuove teorie si può ricordare quello dell’ulcera peptica. Per decenni in medicina ha conosciuto un ampio consenso l’idea che l’ulcera peptica fosse causata principalmente dallo stress e dai cibi troppo speziati. Solo nel 1982 Barry Marshall e Robin Warren svilupparono l’ipotesi dell’origine batterica dell’ulcera peptica che valse loro il Nobel per la medicina nel 2005 e rivoluzionò il trattamento della malattia.
Certo, non è soltanto l’emergere di nuove prove che può cambiare il consenso scientifico: possono influenzarlo anche interessi economici o pressioni politiche, con conseguenze talvolta indesiderabili. Un esempio è quello dei danni del fumo passivo alla salute. Per decenni è stato impossibile raggiungere un robusto consenso scientifico sull’argomento, soprattutto perché il Center for Indoor Air Research (CIAR), un ente finanziato dall’industria del tabacco, promuoveva la pubblicazione di studi che contestavano l’esistenza di prove definitive in materia. Da quando il CIAR è stato chiuso, nel 1998, il consenso scientifico sui danni del fumo passivo si è affermato. Naturalmente possono sempre emergere ulteriori distorsioni da correggere: gli scienziati sono esseri umani e il rischio che il consenso scientifico sia inquinato da interessi di varia natura non può essere mai eliminato del tutto ma deve essere riconosciuto e mitigato da pratiche di trasparenza e scrutinio scientifico indipendente. Il consenso scientifico non è quindi una garanzia di assoluta oggettività, ma resta il miglior punto di partenza possibile per le ricerche future, nonché la base più ragionevole per le decisioni politiche.
Contestare teorie scientifiche senza avere gli strumenti per valutarle nel merito non è un atto di spirito critico ma di presunzione. Lo spirito critico si esercita invece nel conoscere i procedimenti che la scienza usa per costruire le proprie conoscenze in modo da capire nel modo più obiettivo possibile lo stato attuale della ricerca su questioni diverse, pur senza poterle giudicare direttamente. Lo spirito critico aiuta così a non lasciarsi guidare soltanto dalla propria ideologia e dai propri pregiudizi. Questo è un risultato tutt’altro che banale, se si considera che, come mostra proprio la controversia sul riscaldamento globale, spesso non riescono a ottenerlo nemmeno scienziati affermati quando si avventurano al di fuori della propria specializzazione.
Bibliografia
- Cheng, E. K. 2022. “The Consensus Rule: A New Approach to Scientific Evidence”, in Vanderbilt Law Review, n. 75
- Socol, Y., Shaki, Y. Y., Yanovskiy, M. 2019. “Interests, Bias, and Consensus in Science and Regulation”, in Dose Response vol. 17 n. 2