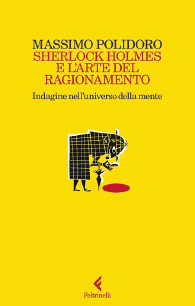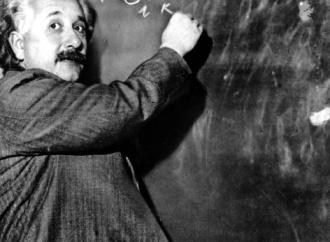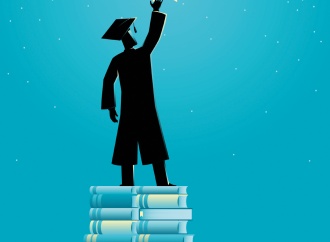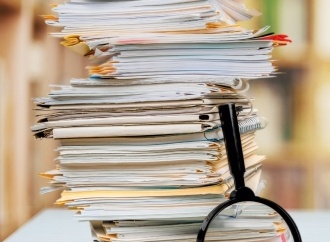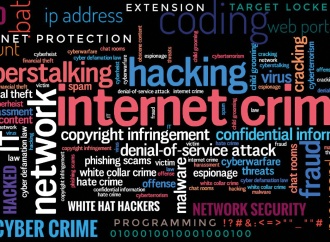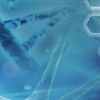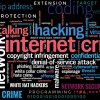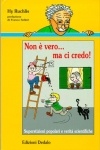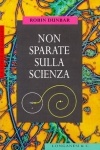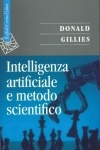«Dottor Watson, il signor Sherlock Holmes» disse Stamford, incaricandosi delle presentazioni.
«Piacere,» disse lui cordiale, stringendomi la mano con una vigoria insospettata. «Vedo che è stato in Afghanistan.»
«Come diavolo fa a saperlo?» domandai stupefatto.
«Lasciamo perdere,» fece lui, con una risatina.
È il primissimo esempio in cui vediamo Holmes dimostrare le sue capacità deduttive fuori dal comune, per poi sminuirle come se niente fosse. Ma al dottor Watson sembra impossibile che quell’uomo che non aveva mai visto prima potesse conoscere un’informazione tanto precisa su di lui. E così, più tardi, gli dirà che certamente doveva avergliela rivelata qualcuno.
«Niente affatto. Sapevo che lei veniva dall’Afghanistan. Il filo del mio ragionamento, per annosa abitudine, è talmente fulmineo che sono arrivato alla conclusione senza passaggi intermedi. Però quei passaggi c’erano. Ecco come ho ragionato: “Abbiamo un signore che sembra un medico ma con un’aria vagamente militaresca. Quindi un ufficiale medico. È appena arrivato dai tropici perché ha la faccia scuretta, che però non è la sfumatura naturale della sua carnagione dato che i polsi sono pallidi. Viene da un brutto periodo, pieno di problemi e acciacchi, lo dimostra il volto segnato. Ha riportato una ferita al braccio sinistro, dalla posizione rigida e innaturale. In quale regione dei tropici un medico dell’esercito inglese può vivere tante vicissitudini e beccarsi una ferita a un braccio? Sicuramente in Afghanistan”. Tutto questo lavorio mentale non ha occupato più di un secondo. A quel punto le ho detto che veniva dall’Afghanistan e lei è rimasto a bocca aperta»
Così come ha lasciato a bocca aperta tutti i lettori che da quel lontano 1887, anno di pubblicazione del romanzo, si sono innamorati di un personaggio tanto straordinario. E chi non resterebbe incantato di fronte a un uomo che, messo a confronto con un enigma che sembra inspiegabile, utilizza il ragionamento e la logica fino a venirne a capo nel modo più brillante possibile? A tutti piacerebbe scoprire con uno sguardo come stanno veramente le cose, risolvere problemi complessi con una fumata di pipa o riconoscere al volo le bugie. Ma è davvero possibile?
Senza pensarci troppo, rispondete a questa domanda: Quanti animali di ciascuna specie — ripeto, di ciascuna specie — fece salire Mosè sull’arca? Quanti? Se avete risposto “due” siete caduti in una trappola predisposta dalla vostra mente: fu Noè infatti a costruire l’arca, non Mosè. Non rattristatevi, però, siete in buona compagnia: la maggioranza delle persone cade vittima di questo trabocchetto mentale. Ed è del tutto normale. Significa forse che il nostro cervello è così fallace che non potremo mai diventare come Sherlock Holmes? Il problema è che della mente non ci si può mai fidare fino in fondo. Per quanto sia un organo unico e stupefacente, qualche volta può indurci in errore. L’evoluzione ha infatti plasmato il cervello in un sistema efficacissimo per aiutare l’essere umano a relazionarsi con il mondo. Tuttavia, per gestire con efficacia il numero impressionante di informazioni che riceve simultaneamente, il cervello è costretto a semplificare la realtà.
Ma nemmeno se ci mettiamo d’impegno e se studiamo con dedizione potremmo diventare abili come Sherlock Holmes?
La risposta sincera è no. Però a certe vette ci si può avvicinare, anche molto, in determinate circostanze, e forse questa è la ragione principale per cui dovreste davvero leggere le prossime pagine.
Per quanto Holmes sia stato portato in vita, per così dire, da centinaia di film, sceneggiati, fiction, radiodrammi, romanzi apocrifi, fumetti e spettacoli teatrali, semplicemente… non esiste. È solo un personaggio della fantasia. Ma, ciò che è più importante, un essere umano come Sherlock Holmes non potrebbe mai esistere nel mondo reale poiché noi esseri umani, cioè gli appartenenti alla specie Homo sapiens, non solo abbiamo un cervello che, proprio per il modo in cui funziona, ogni tanto ci trae in inganno, ma, soprattutto, non siamo animali che vivono di sola logica e razionalità. Come dice molto bene il celebre neuroscienziato dell’Ucla, direttore del Brain and Creativity Institute a Los Angeles, Antonio Damasio, noi «non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano».
La parte emotiva e impulsiva è ciò che ci rende umani. Se dovessimo decidere qualcosa solamente sulla base della pura razionalità, nel migliore dei casi ci vorrebbe troppo tempo per valutare tutte le possibilità e le ramificazioni di ogni scelta, nel peggiore non si arriverebbe a nulla, e ci si ritroverebbe paralizzati, come «smarriti nel labirinto dei calcoli». Le emozioni, come la paura, la rabbia o l’entusiasmo, ci indirizzano a prendere rapidamente decisioni sulla base delle nostre esperienze passate e delle relative emozioni a esse collegate. Certo, ogni tanto queste emozioni ci portano fuori strada, come vedremo, ma è molto difficile evitarlo, e a volte è impossibile.
Sherlock Holmes, invece, in quanto creatura di fantasia può permettersi di non avere emozioni. Ecco l’impressione che Watson ne ricava dopo anni di convivenza con lui, come ci racconta ne L’interprete greco:
Durante la mia lunga e intima amicizia con Sherlock Holmes non gli ho mai sentito fare alcun cenno alla sua famiglia, e ben pochi agli anni della giovinezza. Questa reticenza non faceva che aumentare l’impressione di trovarmi al cospetto di un essere pressoché sovrumano, tanto che certe volte mi accorgevo di considerarlo un fenomeno isolato dal contesto, un cervello senza un cuore, privo di empatia umana quanto strabordante di intelligenza.
In realtà, non è così. Anche Sherlock Holmes ha emozioni: mostra ogni tanto il suo carattere insofferente, si arrabbia per qualche contrattempo o per la stupidità di qualcuno, diventa intrattabile o malinconico se si annoia, e poi ride di gusto con Watson o con qualche ufficiale di polizia, si entusiasma di fronte a un problema (o dopo un concerto di Norman Neruda o una performance di Carina alla Albert Hall). Ma c’è anche un episodio, all’interno del racconto L’avventura dei tre Garrideb in cui, per la prima e unica volta, il dottor Watson può cambiare il suo iniziale punto di vista e osservare da vicino l’umanità del suo compagno di avventure. Succede quando un assassino che i due hanno intrappolato estrae un’arma e spara, ferendo Watson a una coscia:
«È ferito, Watson? Per l'amor del Cielo, mi dica che non è ferito!»
Valeva la pena di soffrire una ferita, o anche molte ferite, per scoprire la profondità della lealtà e dell’affetto che si nascondeva dietro quella maschera gelida. Per un momento, i suoi occhi chiari e duri si annebbiarono e le labbra rigide gli tremarono. Per la prima e unica volta intravidi un grande cuore, oltre a un grande cervello. Tutti gli anni di umile ma determinato servizio furono ripagati da quel momento di verità.
Dunque, anche Holmes ha un grande cuore, dopotutto. Tuttavia, le emozioni di Sherlock Holmes sono abilmente calibrate dal suo creatore, Arthur Conan Doyle, che le tiene lontane a piacimento e può fare in modo che non interferiscano minimamente con le straordinarie capacità analitiche del suo detective perfetto. Cosa che, negli esseri umani in carne e ossa, è decisamente più difficile da ottenere.
E allora? È dunque la conferma che riuscire a pensare come Sherlock Holmes è impossibile? Se così fosse, il mio ultimo libro potrebbe chiudersi qui. Come ho detto, noi non possiamo sperare di diventare abili come Sherlock Holmes, almeno non ventiquattr’ore su ventiquattro ogni giorno! Ma, mettendoci di impegno e, soprattutto, imparando a conoscere meglio la macchina straordinaria che abbiamo nella testa e gli strumenti di ragionamento più efficaci, possiamo applicare il modo di pensare di Holmes nei momenti in cui questa attività può tornarci più utile. Possiamo imparare a riflettere in maniera più concreta, a fare scelte sensate, a prendere decisioni più razionali ed efficaci sul lavoro e nella vita di tutti i giorni, ma anche a vedere oltre le apparenze, a fare ipotesi sensate e a trarre conclusioni logiche dagli indizi che abbiamo a disposizione.
Sherlock Holmes e l’arte del ragionamento
di Massimo Polidoro,
Feltrinelli Editore, 2024