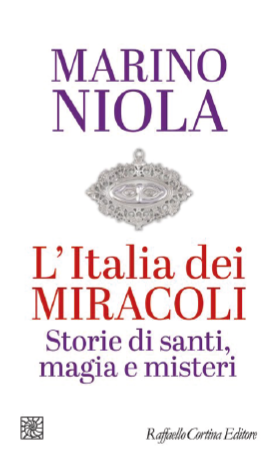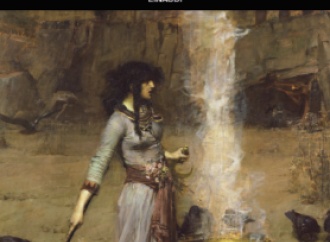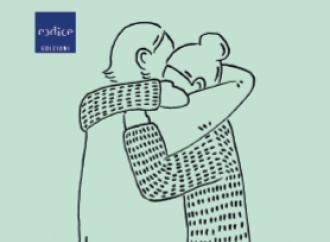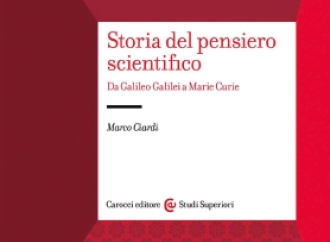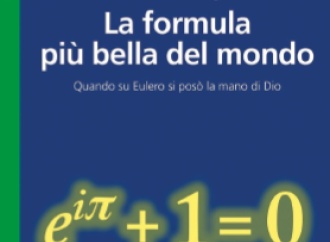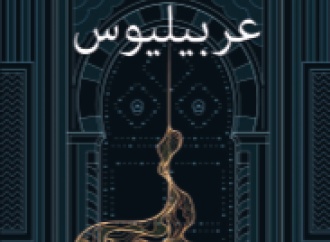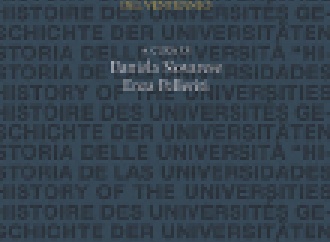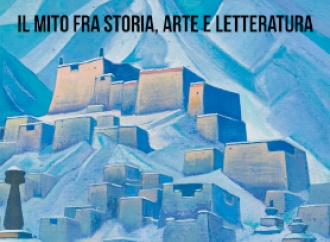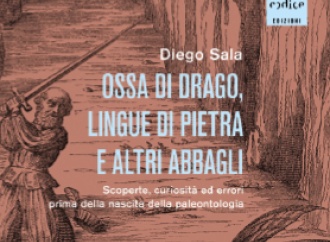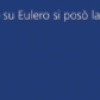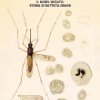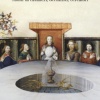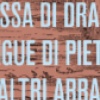L’Italia dei miracoli. Storie di santi, magia e misteri
di Marino Niola
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024
pp. 164, euro 14,00
Racconta Marino Niola che quando apparve (era il 1961) La terra del rimorso di Ernesto De Martino, frutto delle sue ricerche sul tarantismo del Salento, «per l’Italia del miracolo economico fu uno shock culturale». Per quel paese di tradizioni ancestrali che cercava di dismettere gli abiti vecchi per imboccare la via della modernità, fatta di metropoli e autostrade, constatare la persistenza di mentalità considerate arcaiche, magiche, superstiziose dovette provocare la stessa reazione degli inquisitori romani che nell’Italia del Cinquecento scoprivano la radicata diffusione di culti pagani. Niola, che di De Martino condivide professione e natali napoletani, ci mostra ne L’Italia dei miracoli come invece la nostra contemporaneità post-moderna si trovi a proprio agio con il sincretismo di riti popolari paganizzanti che convivono con i problemi della tarda modernità, dopo che, tramontato appunto l’abbaglio del miracolo economico, abbiamo finito per tornare ai più sicuri miracoli di un tempo, seppur rivisitati in chiave contemporanea.
Ovviamente l’epicentro di tutto non può che essere Napoli, la città di Niola, dove il sincretismo è all’ordine del giorno e il culto di san Gennaro convive con quello di Maradona fino a confondersi e generare «un ibrido mitologico ribattezzato san Gennarmando». Al più celebre miracolo italiano — studiato, contestato, replicato in laboratorio, ma in realtà poca cosa se paragonato ai continui scioglimenti del sangue di santa Patrizia nel vicino monastero di san Gregorio Armeno [si veda anche l’articolo “Sangui napoletani” a p. 43, NdR] — si affiancano i pellegrinaggi alla chiesa di santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, «ultimo rito di fertilità dell’Occidente», che attrae donne da tutto il mondo alle prese con la piaga dell’infertilità (solo in Italia coinvolge un terzo delle coppie). Una «liturgia glocal», osserva Niola, che non solo non conosce crisi ma gode anzi di crescente successo, tanto che negli ultimi anni si è aggiunto anche il flusso dei crocieristi di passaggio.
Analogo scenario a sant’Anastasia, nell’imponente santuario della Madonna dell’Arco, dove le centinaia di migliaia di persone che si affollano per chiedere un miracolo alla Vergine, la cui icona fu forse la prima a lacrimare sangue nella storia italiana, non fanno che aumentare nei secoli: e forse nei millenni, se è vero, come afferma l’antropologo, che le violente trance all’ingresso del santuario, dopo un estenuante pellegrinaggio schiacciati tra la folla, richiamano quelle del culto di Cibele a cui era dedicato il tempio sui cui resti sorge il santuario cristiano. Le richieste restano le stesse, cambiano le persone, dato che alla folla di «sottoproletari, precari, contadini, operai, malati, disoccupati, cassintegrati, impiegati, immigrati, camorristi» da qualche anno si aggiungono le «schiere di nuovi devoti: filippini, cingalesi, polacchi, latino-americani e tanti, tantissimi rom».
Ma non è solo Napoli, ché altrimenti si ricadrebbe nell’ingenuità di contrapporre sacche di presunta arretratezza a un paese socialmente risolto. La Val di Susa, dove sorge il più contestato cantiere d’Europa, icona del progresso tecnologico, continua ad attirare folle nella notte dell’Epifania intorno al “masso trottola” di Alpignano, calamita di culti sincretici. La Padova di Galileo è più famosa per i milioni di pellegrini che invocano il suo celebre santo attraverso il sequero, preghiera responsoriale che deve il suo nome alle prime parole in latino si quaeris miracula, “se chiedi i miracoli”, a cui Sant’Antonio continua infallibilmente a rispondere. E a San Rocco, in tutta Italia, ci si è rivolti nei giorni più bui dell’ultima pandemia, in qualità di «virologo di Dio», più affidabile dei virologi con la loro incerta scienza; mentre a Guardia Sanframondi, nel Sannio, i penitenti incappucciati che ogni sette anni si battono a sangue il petto in onore della Madonna Assunta oggi affluiscono da tutti gli angoli del mondo, figli della diaspora: sono «il manager di Melbourne, il proprietario terriero di Caracas, il webmaster di San Francisco» che tornano nelle loro dimore avite per intonare il miserere.
Con questo libro Niola ci fa intravedere i contorni di un nuovo sincretismo, non più tra culti pagani e cristiani, come accadde all’inizio dell’era volgare, ma tra ritualità popolari e miti del secolo, e che sembra dare forma a quella profezia con cui Roberto Calasso chiude il suo postumo Opera senza nome: «un mondo dove di “religioni” non è più appropriato parlare, ma le “favole” continuano a infuriare, per lo più sotto mentite spoglie».