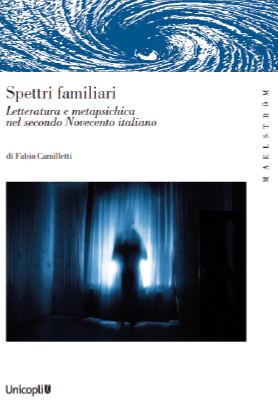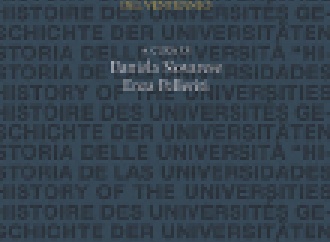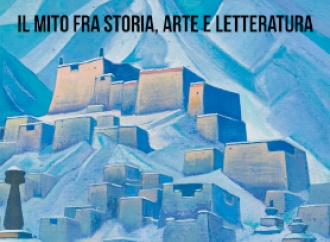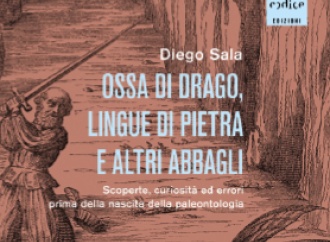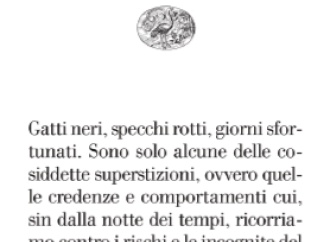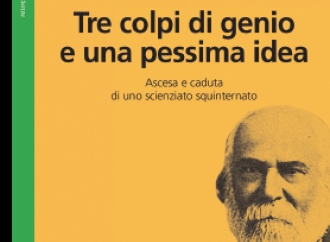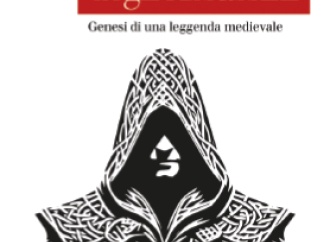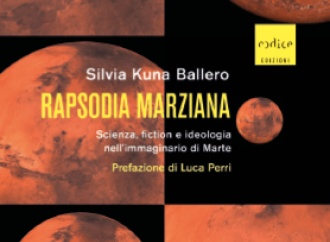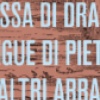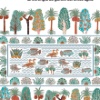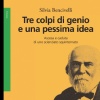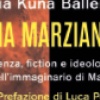Spettri familiari. Letteratura e metapsichica nel secondo Novecento italiano
di Fabio Camilletti
Unicopli Edizioni, Trezzano sul Naviglio (MI)
pp. 239, euro 19,00
Spiritismo e letteratura: vedendo questo binomio, a molti verranno in mente alcune celebri pagine della narrativa italiana, come La casa del Granella di Pirandello o la scena della seduta spiritica ne La coscienza di Zeno di Svevo. La critica, d’altra parte, ha ampiamente scandagliato gli interessi per l’occulto di autori italiani come Vamba (Luigi Bertelli), Antonio Fogazzaro, Luigi Capuana. Meno esplorato è stato questo aspetto per gli scrittori del secondo Novecento, spesso ricondotti all’etichetta del “fantastico italiano”. Eppure si tratta di autori che magari hanno avuto interessi, frequentazioni, contatti con il mondo del “mistero” e del paranormale.
Il libro appena pubblicato da Fabio Camilletti, docente di letteratura italiana all’Università di Warwick, sopperisce ora a questa mancanza. Il volume prende in esame cinque autori del dopoguerra che hanno trattato il tema dei fantasmi, mettendoli in relazione con quanto stava accadendo in quel periodo nel mondo del paranormale e dell’occulto. Il testo è infatti concepito come un continuo dialogo tra le teorie e le pubblicazioni metapsichico-parapsicologiche e i testi letterari presi in esame, con l’idea che le prime possano aiutare a capire meglio il contesto e le ispirazioni dei secondi.
Nell’elenco degli autori scelti da Camilletti c’è Pitigrilli (Dino Segre), ex spia dell’Ovra che nel 1943, all’indomani dell’armistizio con gli Alleati, partecipa alle sedute spiritiche della medium Libia Martinengo. Inseguito dagli spettri del regime, prima di convertirsi al cattolicesimo, l’autore cerca nel tavolino spiritico un modo per recuperare un mondo ormai perduto: evoca i “vecchi amici”, scrittori morti come Ernesto Ragazzoni e Guido Gozzano, che compongono versi e brani, secondo Pitigrilli indubbiamente autentici.
C’è poi Eduardo De Filippo, scettico sulla reale esistenza del paranormale, convinto che “i fantasmi li vede chi ci crede”. La sua commedia Questi fantasmi! viene concepita in un’epoca, fra gli anni '30 e '40, in cui le case infestate balzano di continuo agli onori delle cronache. Ma è anche il periodo in cui la metapsichica si fonde alle teorie dell’inconscio di Freud e parapsicologi come Nandor Fodor ipotizzano che i poltergeist siano l’estrinsecazione di conflitti sepolti nell’inconscio, impossibilitati a tradursi in elaborazione cosciente. Ed ecco che in qualche modo, anche per De Filippo, i fantasmi diventano un modo per parlare del “non detto”, raccontando un tradimento extraconiugale che “aleggia” in un palazzo di via dei Tribunali a Napoli.
Segue Giorgio Vigolo, che ambienta le sue storie in una Roma fatata, dove passato e presente coesistono. Il suo racconto Avventura a Campo de’ Fiori sfrutta letterariamente l’idea che i fantasmi possano spiegarsi con la natura del tempo, cioè che siano “registrazioni” del passato che in certi contesti e certe occasioni possono essere percepite anche dai nostri sensi: un’ipotesi che prende vita dalle teorie ottocentesche sulla psicometria e si consolida con le teorie di Einstein, rilette da una certa pubblicistica parapsicologica che vede tempo e spazio come due dimensioni del tutto simili e i fenomeni paranormali come un’irruzione oltre la soglia della coscienza di un passato e di un futuro perennemente presenti.
Si passa poi a Dino Buzzati, che nel 1965 scrive per il Corriere della Sera 14 articoli per raccontare “qualcuno dei misteri grandi o piccoli che esistono anche da noi”, dove l’occulto ha le sembianze di Gustavo Adolfo Rol o del medium Bruno Lava. Per Buzzati, il punto non è la realtà dei fenomeni raccontati, ma l’esperienza soggettiva “formidabile”, il brivido ricercato attraverso quei fugaci contatti con l’aldilà.
Da ultimo compare Giorgio Bassani, che ne Il giardino dei Finzi Contini mette in scena una seduta spiritica con lettere e bicchierino nel 1939, in cui si interroga l’oracolo sulla guerra incipiente: la tavola Ouija diventa quindi un modo per dire “ciò che molti condividono, ma non osano dire apertamente”. Lo stesso “gioco” compare, negli stessi mesi, tra le pagine un trattatello di metapsichica come Gli uomini conversano e non lo sanno di Salvatore Occhipinti, che interroga il bicchierino - come i protagonisti di Bassani - sugli esiti del conflitto.
Per Camilletti, insomma, libri come Il giardino dei Finzi Contini e la pubblicistica metapsichica dialogano tra loro, aprendo uno squarcio sui desideri e le paure della provincia italiana, nell’ultima estate prima della Seconda guerra mondiale. Tenere presente la storia e le idee della parapsicologia è dunque un modo per arricchire la fruizione letteraria, permettendoci una visione più completa di questi autori.