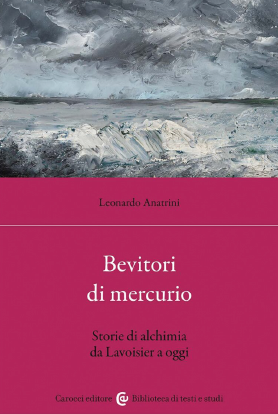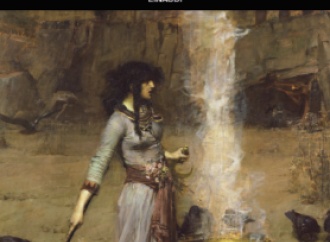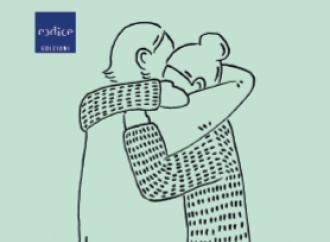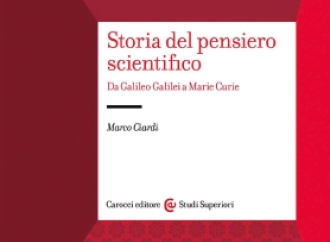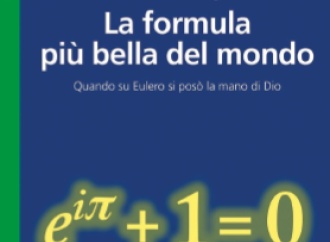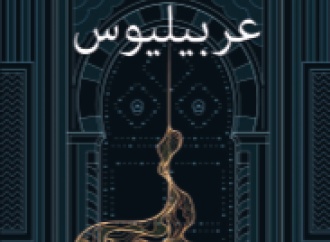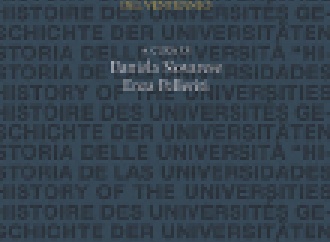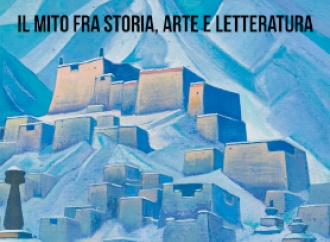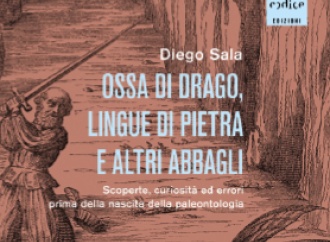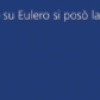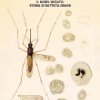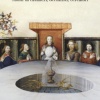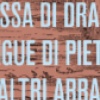Bevitori di mercurio. Storie di alchimia da Lavoisier a oggi
di Leonardo Anatrini
Carocci Editore, Roma, 2024
pp. 288, euro 29,00
Cosa ne fu dell’alchimia dopo l’avvento della chimica? Una delle idee più diffuse è che cessò sostanzialmente di esistere come disciplina intorno al 1789, quando Antoine-Laurent de Lavoisier pubblicò la prima edizione del suo Traité élémentaire de chimie, il testo fondamentale che aprì la strada alla chimica come scienza quantitativa. In seguito, l’alchimia sarebbe diventata appannaggio di truffatori, incompetenti e qualche povero illuso. Come spesso accade, però, la realtà fu più complessa.
A spiegarlo in dettaglio è oggi Leonardo Anatrini, storico della scienza e della tecnica presso le Università di Firenze e di Ferrara, con il suo nuovo saggio. Sul piano storico, infatti, non ci fu una sostituzione netta fra chimica e alchimia, e questo per un motivo fondamentale: l’alchimia non fu soltanto una “pre-chimica” zoppicante e ridicola nelle sue pretese, ma un insieme di modi di leggere il mondo. Accade così che scienziati di prima grandezza riuscirono a far convivere studi di chimica e di alchimia, vedendo spesso la seconda come versante filosofico della prima, cioè come teoria generale del mondo che ben completava gli approcci più empirici.
C’è, dunque, moltissima alchimia dopo Lavoisier, ed è questa ricchezza di idee che Anatrini esplora, seguendo quattro linee direttrici, che coincidono in parte con periodi diversi. La prima (“Uniformare e classificare. La scienza più giovane affronta i propri fantasmi”) riguarda il rapporto per nulla scontato tra i primi chimici e l'alchimia; la seconda (“Rinnovare e sistematizzare. Uno scomposto e multiforme avanguardismo”), è incentrata sull'analisi di quei pochissimi trattati alchemici che furono pubblicati dopo Lavoisier, nella prima metà dell'Ottocento; la terza linea direttrice (“Aspettando la nuova età dell’oro. Chimica, alchimia e occultismo”) è incentrata per lo più sulla ricezione dell'alchimia da parte degli occultisti ottocenteschi, come i francesi Éliphas Lévi (1810-1875) e “Papus”, pseudonimo di Gérard Encausse (1865-1916). L’ultima sezione, infine, per certi versi la più interessante (“Fra utopia e tradizione. Un sogno senza fine") analizza l’evoluzione dell’alchimia tra il 1894 e il 2023, quando questa disciplina entrò in contatto con filosofie di tipo idealistico, che mettevano al loro centro intuizione e illuminazione come momenti fondanti del processo conoscitivo e quindi, per loro, anche dell’innovazione scientifica.
Sul piano più generale dell’influenza culturale, però, quando si parla di rinascita dell’alchimia è impossibile non citare due testi fondamentali che ne allargarono il campo di azione e la consacrarono al pubblico generalista: Psicologia e alchimia di Carl Gustav Jung (1944) e Il mattino dei maghi di Louis Pauwels e Jacques Bergier (1960).
Il primo, in particolare, fu l’esito finale di lunghi anni d’interesse per l’alchimia di Jung, mediata dalla sua passione per i simboli, visti come chiave per accedere agli archetipi; e, dunque, facilmente associabili a quelli di cui i trattati di alchimia abbondavano. Questi, molto di più che semplici metafore, si trasformarono per lo psicoanalista in veri e propri mezzi di esplorazione dell’inconscio: la trasmutazione del piombo in oro, il più classico dei sogni dell’alchimista, diventò per esempio un segno di quello che Jung chiamava processo d’individuazione, quello in cui le istanze della personalità si integrerebbero con successo, dando vita a una personalità in cui ombre e complessi sono sempre presenti, ma non prevalgono.
Altrettanto importante secondo Anatrini fu Il mattino dei maghi, testo fondamentale dell’occultismo moderno, che rilanciò al grande pubblico la figura di Fulcanelli, il misterioso personaggio che firmò Il mistero delle cattedrali (1926) e Le dimore filosofali (1930): due trattati interamente votati alla ricerca di simboli e corrispondenze alchemiche nei bassorilievi delle antiche basiliche cristiane.
Il lavoro di Anatrini è rivolto a chi ha già una certa dimestichezza con l’evoluzione della scienza moderna e le questioni storiografiche connesse; potrebbe dunque risultare un po’ ostico per chi non ha già un’infarinatura in questo campo. Si tratta, però, di un libro documentatissimo e pieno di spunti, utilissimi per chiunque sia interessato ai confini - spesso non così netti - fra scienza e pseudoscienza.