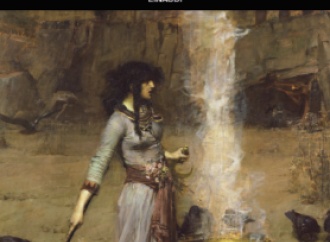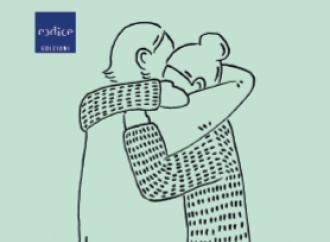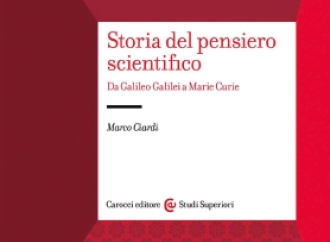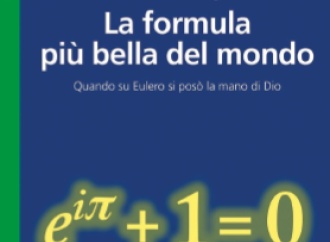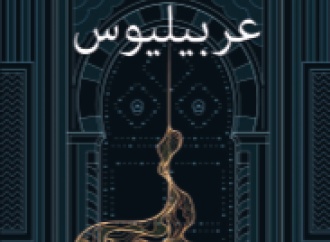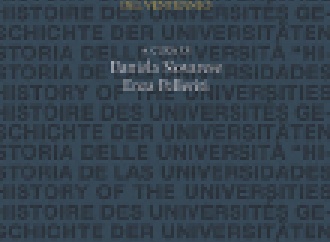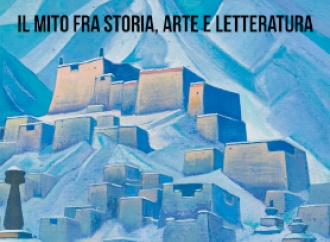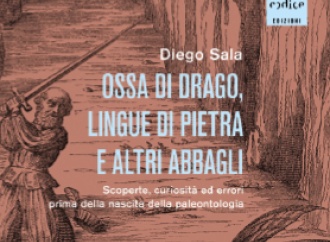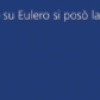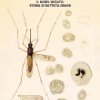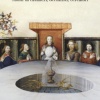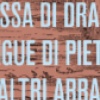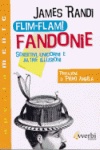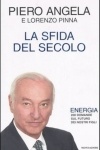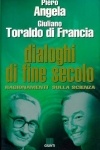Penso sia una delle qualità più nobili dell’essere umano. È un segno di apertura mentale, di capacità critica, di tolleranza, di intelligenza... Quante persone conosciamo, soprattutto sui social, sicure delle proprie opinioni come rocce? Ma chi ha troppe certezze rischia di smarrirsi.
Nella scienza, lo abbiamo visto, accade invece il contrario.
Sì, perché a differenza delle ideologie o delle religioni, qui il punto di partenza è rovesciato: nella scienza non esistono verità assolute con la V maiuscola, né tantomeno dogmi, ma piccole verità transitorie con la v minuscola, utili solo per proseguire nella ricerca e sostituirle poi con altre, che attendono di essere scoperte. È la debolezza e, al tempo stesso, la grande forza della scienza, perché quello che riesce a fare è costruire delle conoscenze (non parliamo di verità) sia pure provvisorie, ma intersoggettive, cioè sperimentabili, ripetibili e provate. Il progresso della scienza si basa sul dubbio e, per questo, tutte le conoscenze acquisite sono da considerarsi temporanee, o comunque devono essere inserite in un sistema in movimento, sottoposto a frequenti cambi di prospettiva. Il che non significa affatto che, quando si scopre qualcosa di nuovo, le conquiste precedenti debbano essere gettate alle ortiche. Restano sempre valide, magari in un ambito più limitato di fenomeni e possono essere inglobate in teorie più ampie. La meccanica di Newton funziona ancora molto bene per descrivere i moti di oggetti che si muovono lentamente rispetto alla velocità della luce. La relatività di Einstein ha poi dimostrato che tale teoria fa previsioni errate per velocità prossime a quelle della luce. Allora, ecco che la nuova prospettiva non cancella Newton, ma lo ingloba come caso limite. C’è dunque, nella scienza, un allenamento quotidiano al dubbio, visto che le certezze che non vengono rimesse in discussione finiscono per essere solo delle gabbie, delle prigioni del pensiero.
A volte è difficile far capire alle persone che la scienza si basa sul dubbio e che, contrariamente a quanto molti pensano, non ha certezze.
Certezze no, ma punti di riferimento sì. Sono tutte quelle idee generalmente accettate perché collaudate e verificate. Tuttavia qualunque scienziato sarebbe disposto a disfarsene se si scoprisse (e soprattutto si dimostrasse) che sono superate da nuove conoscenze.
Solo che dubitare è faticoso, non ci viene spontaneo.
È vero. Quante volte hai sentito dire a un politico o a un uomo di fede: “Hai ragione, le mie idee erano sbagliate: la tua dimostrazione è convincente”?
Mai.
Appunto. Questa disponibilità a cambiare idea, la profonda umiltà della scienza, che rende possibile a chi se ne occupa di rinunciare alle proprie teorie se qualcun altro le dimostra errate, fa proprio a pugni con la natura umana. Gli esseri umani tendono infatti a ritenere le proprie idee fondamentalmente giuste ed è molto difficile far cambiare opinione a qualcuno.
A essere sinceri, qualche volta accade anche nel mondo della scienza.
Certo, non è solo un limite della politica, dell’economia o di qualunque altro campo dove il giudizio personale conta. Anche nella scienza un ricercatore si può impuntare su un’ipotesi particolare e rifiutare gli esperimenti che la contraddicono. Ma, a differenza della politica o degli altri ambiti di cui dicevamo, un atteggiamento di questo tipo alla fine non porta a premi e promozioni, ma può semplicemente far sprecare anni di lavoro e danneggiare gravemente la reputazione di chi lo assume. Per riprendere l’esempio dello sport, ci si può affezionare ai propri campioni e alla propria squadra, ma alla fine quello che conta sono i risultati. E se qualcun altro segna più punti, corre più veloce o salta più in alto, tutti alla fine devono riconoscere il suo primato (almeno provvisoriamente, in attesa che qualcuno ottenga nuovi risultati ancora migliori).
Cambiare idea, nella scienza, non significa diventare opportunisti.
Assolutamente. L’opportunista cambia idea per convenienza, a seconda dell’interesse immediato, lo scienziato la cambia perché nuove prove dimostrano che ciò che si credeva era sbagliato o incompleto. Qui serve ancora quella flessibilità mentale di cui dicevamo, una flessibilità (e un’umiltà) che consente di esporre le proprie idee alla verifica o alla smentita del mondo esterno senza timori.
Che cosa rispondi a chi ti dice che mettere continuamente in discussione le proprie convinzioni è scomodo e faticoso?
Gli do ragione, ma aggiungo che è bellissimo! Perché è come salire sempre su nuove colline e spingersi oltre: si scoprono paesaggi sconosciuti, si vedono cose di cui si ignorava l’esistenza. Il piacere intellettuale di esplorare, di cercare di capire il nuovo, il diverso, ripaga ampiamente della fatica di pensare. Certo, bisogna rinunciare a quel senso di sicurezza che le certezze ti possono dare. Avere un Aristotele che ha già “detto” e spiegato ogni cosa a cui ricorrere, come si faceva in passato, è rassicurante e confortevole. Ma è anche un modo per rimanere seduti mentalmente. È una specie di ergastolo intellettuale. Col rischio di renderci intolleranti verso tutto ciò che contrasta con le nostre idee.
Un discorso che non vale solo per la scienza.
No, infatti. Una società moderna deve accettare la diversità delle idee: non c’è qualcuno che è detentore di una verità universale valida per tutti, in ogni momento e in ogni luogo, deve esserci l’accettazione della diversità. La convivenza richiede quindi che ognuno rispetti le idee degli altri. È un punto essenziale, mi sembra, che per l’appunto riguarda non solo la scienza ma molti aspetti della vita.
Solo che noi esseri umani facciamo fatica ad accettare ciò che non conosciamo, l’ignoto, l’incertezza...
È vero, esiste questa contraddizione: da una parte c’è un profondo bisogno di avere appigli a cose salde, immutabili; dall’altra c’è la ragione che spinge a dubitare, a verificare, a cambiare. È una contraddizione antica. Qualunque tipo di conoscenza, infatti, viene a turbare un equilibrio precedente, e ciò crea dei problemi di adattamento mentale che, a volte, possono essere faticosi.
Come l’esempio che facevi prima, spiegando che il fatto stesso di camminare ci porta in una posizione di squilibrio che deve essere subito corretta per riportare l’equilibrio.
Precisamente. Solo che qui è un po’ come camminare nell’acqua e quindi, oltre a dover ritrovare sempre di nuovo l’equilibrio, mentre si avanza si creano onde tutt’intorno. Onde che possono essere fastidiose per gli altri. È inevitabile che sia così. Se si vuole restare in equilibrio e non provocare onde c’è una sola soluzione: restare immobili. O, per uscire dalla metafora, rinunciare a percorrere la strada della conoscenza. A questo proposito, mi piace sempre citare Erasmo da Rotterdam, che nel suo Elogio della follia ironicamente scrive: “Le cognizioni scientifiche non soltanto non contribuiscono a quella felicità per condurre alla quale si dice siano sorte, ma anzi la ostacolano; tanto che, come si legge in Platone, un prudente monarca biasimò con eleganza l’invenzione dell’alfabeto. Così le scienze, insieme con tutte le calamità della vita, si diffusero largamente per merito di quegli stessi esseri che furono anche la causa di tutti gli altri flagelli dell’umanità i sapienti ”.
Come dire che l’analfabeta (o il bigotto, se è per questo) non sperimenta i dubbi e le incertezze della conoscenza, ma allo stesso tempo non va molto lontano...
Sembra anche a me. Restare tranquilli vuol dire anche rimanere fermi. Se invece scegliamo di percorrere la strada della collina dobbiamo sapere che rinunceremo a certe cose. Ma ci arricchiremo di altre. E, comunque, potremo portarci nello zainetto alcuni valori saldi a cui ci si può aggrappare: il valore della tolleranza, per esempio, della comprensione, della ricerca. Oltre a quello dell’onestà, dell’autocritica e del coraggio. Sono buoni compagni di viaggio, non tradiscono mai e, in migliaia di anni, non sono mai stati smentiti da nessun esperimento di laboratorio.
Estratto da: La meraviglia del tutto, di Piero Angela e Massimo Polidoro, Mondadori, 2024. Riprodotto per gentile concessione di Mondadori Editore.