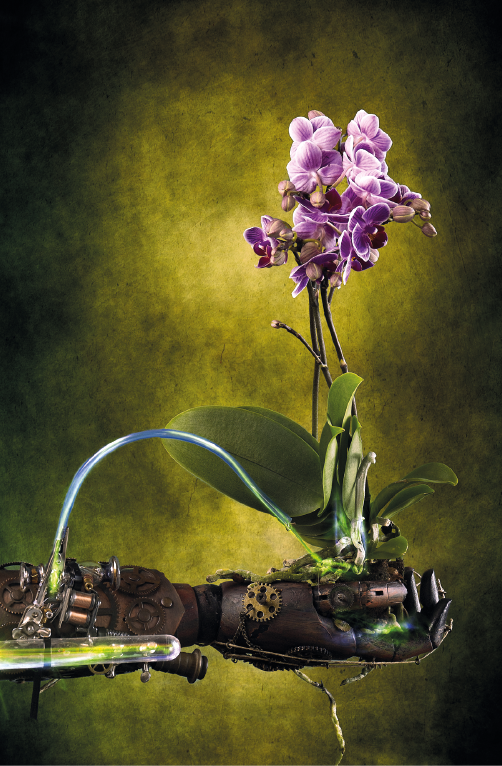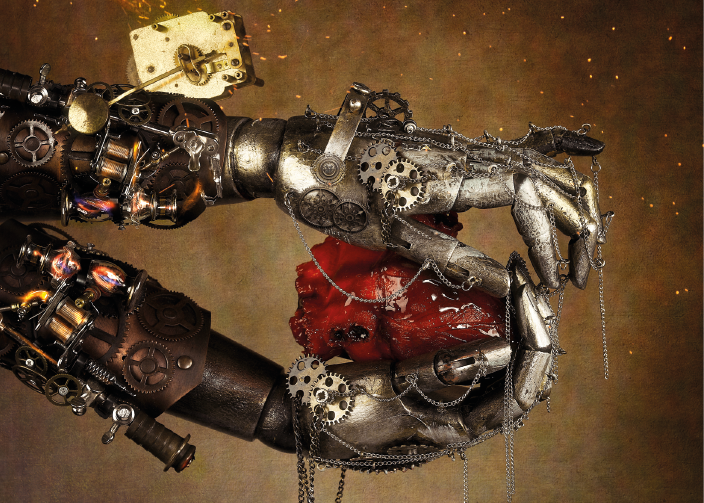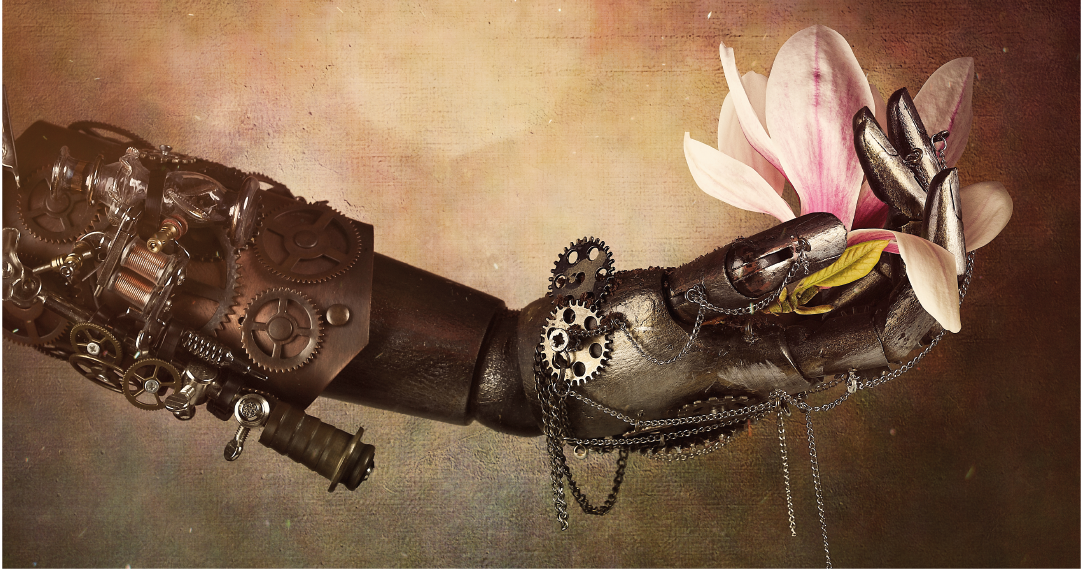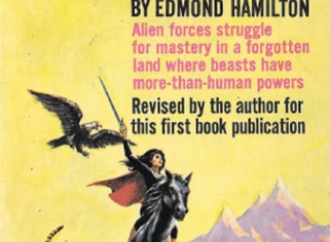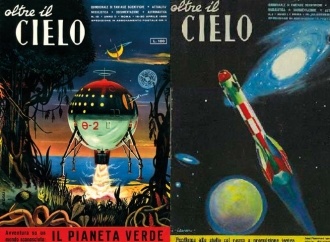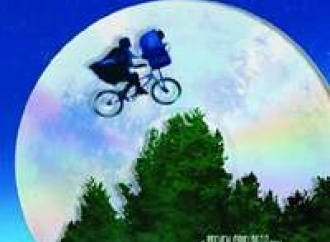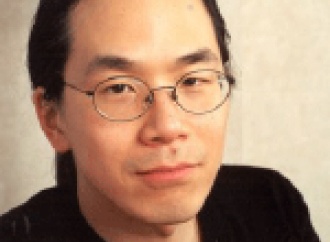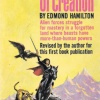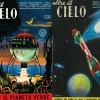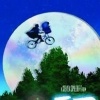In questo articolo non considererò tutte quelle tecniche che non ricadono in quelle che convenzionalmente consideriamo come scienze sociali o scienze dure, quali tarocchi, oroscopi e altre simili forme di divinazione, che sono, peraltro, estremamente variegate e numerose e sembrano vivere una nuova popolarità. Ciò non significa che non possano essere oggetto di studio e indagine per comprendere le forme, le condizioni socio-psicologiche e le motivazioni che spingono gli esseri umani a interrogare il futuro; significa, più semplicemente, che le informazioni che possiamo ricavare sul futuro da queste tecniche di predizione sono completamente inaffidabili. D’altronde, proprio la questione dell’affidabilità della (possibile) conoscenza del futuro è uno degli snodi epistemologici più complessi, problematici e ricchi di implicazioni.
La nascita degli approcci anticipanti
Per orientarci nell’evoluzione recente dello studio del futuro può essere metodologicamente utile seguire gli sviluppi e i dibattiti interni ai Futures Studies, la disciplina che si occupa esplicitamente dell’analisi, della teoria e della critica del futuro. Questi dibattiti, a loro volta, riflettono i grandi orientamenti che hanno caratterizzato il percorso delle scienze sociali dopo la Seconda guerra mondiale. Pur con una forzatura imposta dallo spazio a disposizione e dalla complessità del tema, possiamo qui inquadrare i macro-approcci filosofici ed epistemologici come caratterizzati, rispettivamente, da un orientamento positivista oppure da prospettive postpositiviste e costruttiviste (in realtà, c’è anche una solida posizione intermedia tra queste due grandi famiglie che fa riferimento al realismo critico). Questi approcci, che caratterizzano ancora largamente il metodo delle scienze sociali contemporanee sia pure in forme e modi mutati nel tempo, hanno implicazioni enormi in termini di visione del rapporto scienza–società e del ruolo del processo scientifico, dello sviluppo della conoscenza e, nel nostro caso, degli approcci al futuro.
Il piano epistemologico e quello storico sono intimamente connessi. Nel caso dei Futures Studies, storicamente un significativo cambio di passo nell’approccio al futuro avviene negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, nel contesto del consolidamento degli approcci positivisti e behaviouristi nelle scienze sociali e dell’egemonia politica e militare statunitense in Occidente. I futurologi della RAND, ancora oggi uno dei principali think tank e istituti di ricerca a livello internazionale, si lasciarono ispirare da approcci quali la game theory, la cibernetica o il metodo Monte Carlo per favorire l’applicazione di modelli matematico-quantitativi per predire gli sviluppi e le implicazioni di un possibile conflitto nucleare con l’Unione Sovietica. Ma in quegli anni, a riprova della centralità della dimensione militare, lo stesso governo statunitense aveva creato un “oracolo elettronico” (lo Standard Eastern Automatic Computer – SEAC) per analizzare scenari potenziali della guerra di Corea. Gli obiettivi delle simulazioni matematiche erano duplici, cioè calcolare la probabilità che un evento potesse avvenire e le sue conseguenze, ed esplorare il futuro con l’obiettivo di influenzare il presente: come vedremo, ancora oggi una delle applicazioni dei Futures Studies. Il milieu del tempo ci consegna anche alcuni esperimenti rivelatori della mentalità dell'epoca, tra cui il Progetto Camelot, promosso dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti per predire l’evoluzione dei movimenti insurrezionali in America Latina. Così, mentre le scienze sociali, nella loro aspirazione alla conoscenza esatta e al controllo quasi-laboratoriale, provavano a mimetizzare le scienze dure, il “futuro” e la previsione si offrivano come un campo privilegiato di sperimentazioni.
La svolta degli anni Sessanta
Gli approcci empirico-matematici hanno dominato lo scenario degli studi di futuro almeno fino agli anni Sessanta inoltrati. Ma a partire dalla fine di quel decennio, lo spettro delle basi epistemologiche dei Futures Studies inizia progressivamente a cambiare e allargarsi. Da un lato, diventa evidente l’impossibilità di una conoscenza esatta, matematica, del futuro, e quindi di controllare “il futuro”. Dall’altro, gli orientamenti postpositivisti (o anche definiti come postmoderni) iniziano a diventare sempre più importanti nelle scienze sociali. Assistiamo, così, a una nuova ondata di studi e ad alcuni cambiamenti significativi. Tra questi, il primo è l’estensione degli studi di futuro e delle tecniche di previsione ad ambiti civili e non più solo a questione di tipo strategico-militare. Il secondo grande cambiamento, che si deve in particolare all’intellettuale francese Bertrand de Jouvenel e alla generazione di critical thinkers di quegli anni, è legato alla non identità ontologica di presente e futuro.
In altre parole, e a differenza degli approcci positivisti, il futuro non è una mera “propaggine” del presente determinata da una serie di reazioni lineari di causa–effetto, cioè non segue deterministicamente e teleologicamente il presente. Questo per una ragione banale, e cioè che quello che noi chiamiamo “presente” è un coacervo complesso e contradditorio di linee di tendenza, processi, multipli rapporti di forza e piani di azioni che, interagendo in forme e modi potenzialmente infiniti, danno vita a ciò che noi chiamiamo “il futuro”. Al contempo, il principio di non-identità apre anche a una diversa visione del futuro come uno spazio di possibilità multiple.
Questa diversa ontologia del futuro ha comportato, anche, un progressivo allargamento e consolidamento degli approcci metodologici allo studio del futuro stesso. Alle precedenti tecniche predittive basate su un approccio matematico-empirico e una visione lineare del futuro, si affiancano nuovi metodi che – in parte – abbandonano l’idea di conoscere per controllare il futuro a favore di una propensione più esplorativa verso i futuri possibili e probabili. Tra i nuovi approcci meritano di essere menzionati soprattutto il metodo Delphi (sviluppato proprio dalla RAND dopo aver compreso il fallimento degli approcci strettamente matematici), il metodo per scenari e, successivamente, la Causal Layered Analysis sviluppata da Sohail Inayatullah.
Il metodo Delphi si basa sulle conoscenze di un gruppo di esperti indipendenti interrogati su un certo fenomeno o una certa tendenza. L’obiettivo è arrivare a un consenso circa le possibili previsioni future di un certo fenomeno, attraverso fasi successive gestite da un coordinatore e che hanno di solito avvio con la somministrazione di un questionario con risposte aperte. Il metodo per scenari — che può essere svolto in forme e modalità diverse, e con diversi livelli di complessità — consiste in una serie di descrizioni esplicite e sistematiche di possibili situazioni future; quindi, nella possibilità, a partire da un certo numero di ipotesi e alla luce di un certo numero di dati fattuali e di variabili, di ricavare informazioni circa gli sviluppi futuri di un fenomeno. Il senso di un’analisi di scenario è molteplice: abbassare il livello di incertezza; aumentare il livello di conoscenza delle conseguenze future di azioni e tendenze presenti; migliorare il livello di decisione pubblica attraverso la predisposizione di diversi possibili sviluppi di un’azione; strutturare informazioni e “proiettarle” nel futuro; sviluppare una serie di strategie anticipanti adattandole ai possibili scenari futuri di una certa situazione.
In questa breve panoramica di alcuni tra i metodi più impiegati nei Futures Studies, la Causal Layered Analysis è forse tra i più interessanti. In estrema sintesi, si basa su una visione della società e del presente come stratificata su diversi livelli di profondità, visibilità e durata che, interagendo in forme e modi complessi, predispongono il futuro, senza naturalmente determinarlo in modo univoco. Questo approccio ha l’indubbio merito di fornire una visione di tipo sistemico del cambiamento, che non è il frutto di singole variabili ma dell’interazione complessa dei diversi fattori e processi casuali.
Questi metodi sono solo alcuni tra quelli che compongono l’armamentario metodologico e le strategie di ricerca nel campo degli studi sul futuro. Ma oltre alla divisione tra approcci positivisti e postpositivisti, altri autori (per esempio Toni Ahlqvist e Martin Rhisiart) suddividono nel contesto dei Futures Studies l’approccio ai futuri in termini utilitaristi o emancipativi a seconda della tensione fondamentale e degli scopi. Ancora una volta, una distinzione storico-temporale ci permette di comprendere in profondità, in questi casi, i diversi “usi” del futuro.
Nel caso dell’approccio utilitaristico, questo si forma in tre principali contesti storici e dimensioni: (1) negli anni Cinquanta, in ambito militare statunitense (il già citato caso della RAND); (2) negli anni Ottanta, rispettivamente nel campo della consulenza (previsione e forecasting) e (3) nelle policy (quest’ultima è oggi particolarmente rilevante a livello europeo).
L’altro paradigma che caratterizza i Futures Studies è quello emancipatorio. Questo è suddiviso in tre contesti: (1) la dimensione sistemica globale degli anni Settanta, soprattutto grazie al movimento ambientalista e alla sua visione della Terra come limitata e interconnessa (il famoso rapporto del Club di Roma I limiti dello sviluppo, del 1972, è un esempio chiave di questa nuova consapevolezza); (2) la dimensione metodologica critica, sviluppatasi a partire dagli anni Ottanta e tuttora in corso, che ha proposto una visione interna e più critica/consapevole dell’uso delle metodologie negli studi sul futuro (spinta da idee come quella dei “futuri alternativi”, dei critical futures studies o della Causal Layered Analysis); (3) la terza dimensione, consolidatasi soprattutto a partire dagli anni Novanta e tuttora in corso, si nutre in particolare dell’incontro tra Futures Studies e critical theory, e dunque è in aperto dialogo con gli studi di genere, con la critical political economy, l’analisi del discorso e il post-strutturalismo. In quest’ultimo caso, questa panoplia di approcci critici ha soprattutto l’obiettivo di enfatizzare gli squilibri, le disuguaglianze strutturali e le ingiustizie che, caratterizzando il presente, comportano il rischio di influenzare in modo significativo anche le possibilità di un futuro più giusto ed equilibrato.
Verso i futuri possibili: conoscenza, decisione, emancipazione
Ritorniamo ora alla questione di partenza: è possibile sviluppare una conoscenza affidabile e solida del futuro? A questa domanda non esiste una risposta univoca, e con tutta probabilità gli studiosi e le studiose di futuro darebbero risposte diverse.
Dal mio punto di vista la risposta è affermativa, ma ad alcune condizioni epistemologiche fondamentali. La prima è escludere una conoscenza esatta di cosa sarà il futuro (sia esso a breve, medio e lungo termine). Ciò che possiamo sviluppare, alla luce di una analisi complessa e stratificata del presente, è una serie di congetture relative a possibili scenari futuri. Il presente, con le sue strutture multiple, influenza ma non determina il futuro: ciò nondimeno, possiamo ricavare informazioni preziose e affidabili su numerosi temi e linee di tendenza, per esempio il cambiamento climatico, la demografia, il rapporto tra Stati e mercati, il sistema internazionale o i principali rischi globali. In fondo, se tutte le analisi in qualche modo si proiettano, anche solo implicitamente, nel futuro, nel caso dei Futures Studies le analisi invece estrapolano e rendono evidenti gli scenari possibili.
Al contempo, proprio la natura elusiva dei Futures Studies ci invita anche a una creatività metodologica e di strategie di ricerca spesso assente in altri rami delle scienze sociali. In altre parole, capire ed estrapolare futuri possibili può nutrirsi di una felice convergenza tra metodi qualitativi, che ad esempio permettono di comprendere in profondità le visioni di futuro che hanno specifici gruppi sociali (un elemento essenziale della costruzione di scenari), e metodi quantitativi, che invece possono aiutare a comprendere in che modo le grandi e radicate tendenze del presente, espresse in forma numerica, possono proiettarsi nel futuro. In quest’ultimo caso, naturalmente, bisogna guardarsi dal rischio del positivismo ingenuo per cui una o alcune variabili influenzeranno in modo univoco il futuro. Al contrario, la triangolazione tra approcci qualitativi e quantitativi può aiutarci a sviluppare degli approcci non univoci dei futuri possibili.
Il secondo tema, strettamente connesso al primo, concerne gli usi di futuro. In questo ambito, riprendendo parte delle considerazioni sopra esposte, distinguerei tra un uso pratico e un uso critico-emancipatorio. Nel primo caso rientrano tutti quegli usi di futuro impiegati nei processi decisionali pubblici e privati, che consentono a diversi attori di prepararsi a possibili sviluppi o implicazioni futuri di un certo processo. In questo senso, la previsione sociale e gli approcci anticipanti stanno diventando sempre di più parte del processo decisionale pubblico, soprattutto in campo internazionale e sovranazionale. Esempi sono l’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE) e l’Unione Europea, che hanno creato diverse unità di strategic foresight per anticipare e preparare le istituzioni e le politiche pubbliche ai possibili cambiamenti e alle sfide globali in numerosi settori.
L’altro possibile uso del futuro è quello critico-emancipatorio e politico-partecipativo. Anche in questo caso possiamo avere usi diversi a seconda dei nostri obiettivi. Un uso partecipativo degli “esercizi di futuro” può prevedere, per esempio nell’analisi di scenario, il coinvolgimento delle comunità locali al fine di produrre politiche pubbliche partecipative e dunque maggiormente condivise da chi ne è coinvolto. L’approccio critico-emancipatorio è ancora più generale: qui l’obiettivo non è produrre decisioni migliori estraendole dal contesto, ma partire dalle ingiustizie strutturali del contesto per capire come impatteranno i futuri dei diversi gruppi sociali e il rapporto società-ambiente. Questo modo di guardare al futuro — che può impiegare metodi quali l’etnografia, l’analisi critica del discorso e/o le interviste — è fondamentale non solo verso l’esterno, cioè verso una comprensione profonda della società e delle sue ingiustizie, ma anche verso l’interno: in altre parole, è un necessario invito sia agli studiosi e alle studiose, sia ai decisori politici, di guardare a questa disciplina teorico-pratica non come un campo neutrale o come un mero esercizio tecnocratico, ma come un campo di studi e analisi che ha delle necessarie ripercussioni sociali. Dunque, con precise responsabilità morali e politiche.
In conclusione, il campo della previsione oggi è un cantiere di elaborazioni teorico-concettuali e pratiche, di elaborazioni accademiche e applicazioni decisionali, di usi pratici e usi emancipatori. Se, molto probabilmente, come genere umano non avremo mai la possibilità di predire il futuro con certezza, ciò non significa non essere in grado di sviluppare una maggiore consapevolezza, conoscenze affidabili e un ragionevole grado di preparazione verso i futuri possibili.