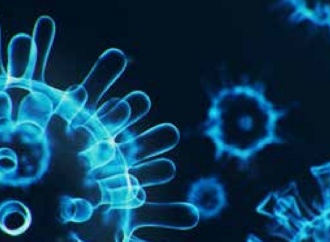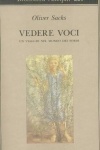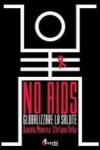Ma “la PET” è forse qualcosa di molto meno noto. Eppure si tratta di una tecnica diagnostica che è stata sviluppata con un crescendo di tecnologie e affidabilità come in pochi altri casi. La cosa particolarmente avvincente è che la PET è un approccio diagnostico che si basa su fenomeni di natura fisica particolarmente esotici e che hanno tenuto impegnato per molti anni le migliori menti di scienziati sia sul fronte teorico che su quello sperimentale.
Facciamo qualche passo indietro nel tempo, alle origini della fisica dei quanti, sviluppata durante il ventesimo secolo. Nel 1926 Erwin Schrödinger (a quanto pare durante un movimentato periodo di vacanza in uno chalet austriaco in compagnia di un’amante) propone al mondo della scienza fisica la sua celebre equazione, in grado di descrivere e predire il comportamento di oggetti materiali su scale atomiche (o anche meno) in termini di onde, che a loro volta sono legate matematicamente al calcolo della probabilità di misurare determinate grandezze osservabili fisicamente.
Sembra molto complicato, e infatti lo è. Ma si può dire che Schrödinger, e poco prima di lui Louis De Broglie, riescono a intuire un comportamento apparentemente assurdo del nostro mondo materiale, che in realtà così banalmente materiale non lo è per nulla. Ciò che ci pare solida materia si comporta in determinate condizioni come un’onda: viene diffratta e interferisce con altre onde, ossia con altra materia.
Se questo ci pare un punto di vista strano e bizzarro, la situazione si fa ancora più sorprendente se cerchiamo di capire cosa succede quando le velocità in gioco nei nostri fenomeni fisici sono grandi, molto grandi, così grandi da non poter essere trascurate rispetto alla velocità limite del nostro universo (limite, a parte interpretazioni gelminiane degli esperimenti con i neutrini del CERN/Gran Sasso), cioè la velocità della luce (nel vuoto).
In questi casi la teoria delle probabilità di misura “quantistica”, “ondulatoria” di Schrödinger, deve venir estesa a un sistema di equazioni più complicate, per la prima volta proposte da Paul Dirac attorno al 1928 e capaci di descrivere la natura dell’elettrone come particella elementare dotata di spin, ossia di una particolare caratteristica magnetica di natura puramente quantistica.
Non è tutto: l’equazione di Dirac prevede anche l’esistenza di una nuova particella oltre all’elettrone: si tratta un anti-elettrone, ovvero di un oggetto che ha la stessa massa dell’elettrone ma carica opposta. Se si trattasse solo di questo, un elettrone e un anti-elettrone dovrebbero solo attrarsi e niente di più, come fanno sempre due cariche di segno opposto. Non è però solo questione di carica: un elettrone e un anti-elettrone si attirano, certo, ma se si avvicinano sufficientemente, “scompaiono” in una minuscola deflagrazione che non lascia sul campo nessun residuo materiale delle due particelle, bensì energia nella forma di radiazione elettromagnetica e, nello specifico, di radiazione cosiddetta gamma, con valori che sono migliaia di volte maggiori di quelli caratteristici del bilancio energetico di un tipico atomo. Si dice anche che un elettrone e un anti-elettrone annichilano.
Lo fanno in tempi rapidissimi (meno di un miliardesimo di secondo, in certi casi). Dirac, nella sua teoria, e poi Anderson nel 1932 e Blackett e Occhialini nel 1933 (e non Zichichi come lui stesso dice di avere fatto per primo – cosa strana visto che il suddetto allora aveva tre anni, precoce va bene, ma c’è un limite a tutto) parlano di antimateria e, nel caso specifico dell’anti-elettrone, di positrone (o positone). Non ci si ferma a questi casi: si stabilisce (e si conferma sperimentalmente, un po’ alla volta) che per ogni tipo di particella esistente nel nostro universo deve anche esistere un tipo di anti-particella, con la caratteristica di annichilare se le capitasse la ventura di incontrare la sua partner “normale”.
Cosa c’entra tutto questo con la PET di cui abbiamo iniziato a parlare? Certo, l’acronimo contiene il nome dell’antiparticella dell’elettrone. Ma come si usano gli antielettroni, o positroni, per fare diagnosi medica?
Dobbiamo anzitutto ribadire quanto già accennato: un positrone che incontra un elettrone vuol dire annichilazione sicura, in breve tempo. Risultato? Emissione di radiazione elettromagnetica sotto forma di radiazione gamma, cioè di fotoni di energia di ammontare pari a quella quantità di massa (materia) che costituiva, prima del loro “sacrificio”, il totale della massa dell’elettrone e del positrone sacrificati.
Per chi vuole dare i numeri: 511.000 eV x 2 (elettrone e positrone hanno eguale massa, ovvero energia – grazie a Einstein), energia che si accaparrano due fotoni gamma (a volte tre, ma questa è una storia più complicata che qui non ci deve interessare). La cosa molto importante per il discorso che stiamo sviluppando qui è che i due fotoni gamma emessi in questa mostruosamente minuscola disintegrazione se ne vanno allontanandosi uno rispetto all’altro con un angolo di 180°: uno da una parte, l’altro dalla parte opposta.
In pratica: laddove si trovino elettroni a spasso, se da quelle parti capitano positroni, tutt’attorno si misurerà un fiotto di fotoni gamma che si allontano dalla zona di annichilazione a coppie perfettamente sincronizzate in direzioni opposte.
Si immagini ora di avere iniettato una certa quantità di materiale in grado di emettere positroni in una zona più o meno ricca di elettroni, e si pensi anche di mettere “attorno” a quest’area dei rivelatori di radiazione gamma progettati in modo da mandare un segnale di ricevuto ogni qualvolta questi strumenti vengono simultaneamente colpiti da due impulsi elettromagnetici (ovvero fotoni) di energia gamma, pari a 511.000 eV provenienti da direzioni opposte. Il risultato di tutto ciò è che sarà possibile risalire a una mappa della densità di popolazione di elettroni in funzione del numero di segnali di annichilazione provocati dall’incontro-scontro fra elettroni e positroni, i primi presenti già da prima nella zona di tessuto osservata, i secondi iniettati a bella posta.
Ora succede che gli elettroni la cui presenza può essere osservata e visualizzata grazie ai segnali indotti dall’annichilazione con i positroni iniettati a bella posta, fanno parte di atomi che sono costituenti fondamentali dei tessuti studiati ovvero sono partecipi delle reazioni chimiche o biochimiche di queste porzioni di materia: gli atomi e le molecole che sono impegnati nel funzionamento delle attività viventi delle cellule sono fatti anche da elettroni che vengono scambiati, acquisiti, ceduti durante la vita biologica del sistema.
Quando questi elettroni annichilano con i positroni iniettati, generano getti di fotoni gamma che sono dunque indice assai preciso dell’attività atomica (e dunque molecolare e biochimica) della zona studiata. Incluse attività anomale, come nel caso di patologie che modificano in modo anche radicale la mappatura delle reazioni di interesse biochimico, principalmente come accade in tessuti tumorali.
Resta il dubbio fondamentale: da dove vengono i positroni (l’antimateria) che viene iniettata nel corpo umano? E poi, come si possono elaborare – in pratica – i segnali delle annichilazioni che avvengono nel tessuto studiato?
Per quanto riguarda la provenienza dell’antimateria, si osservano in natura isotopi (nuclei che appartengono alla stessa specie atomica ma con valori differenti di massa) che hanno la caratteristica di essere instabili e di trasformarsi in altri nuclei emettendo positroni. La diagnosi PET prevede l’inoculazione di isotopi che emettono antimateria ma che lo fanno per tempi relativamente brevi, allo scopo di permettere una rapida “fotografia” dei tessuti irradiati ma un’altrettanta veloce eliminazione dell’isotopo intruso dal corpo umano. Questione di pochi minuti, di solito.
Ci deve dunque essere a disposizione di un macchinario PET un acceleratore di particelle, relativamente compatto, che “attiva” nuclei stabili trasformandoli in nuclei produttori di antimateria.
Non è tutto: i fotoni gamma che vengono emessi in seguito alle annichilazioni fra elettroni (del tessuto) e positroni (iniettati) devono venire raccolti da un sistema di rivelazione (si tratta di “scintillatori” – oggetti che emettono un lampo di luce quando sono attraversati da forti impulsi elettromagnetici, come i fotoni gamma, e di fotomoltiplicatori, ovvero oggetti che a partire da questi lampi di luce producono un segnale amplificato di intensità tale da essere agevolmente misurata) accoppiato a un computer in grado di utilizzare la posizione spaziale di questi lampi luminosi per ricostruire le zone di varia concentrazione di elettroni e, soprattutto, la variazione di detta concentrazione, fatto questo che indica l’evolversi di reazioni chimiche.
Se si vuole, possiamo pensare alla PET come a una potentissima versione tridimensionale (o stratigrafica, a strati, da qui il nome di “tomografia”) delle TAC che, per il tramite di raggi X, producono visioni interne della struttura del nostro corpo. La PET, oltre a ciò, consente la visione della funzionalità di nostre parti anatomiche, in modo essenzialmente non invasivo, affidabile anche se molto costoso. Fantascienza? No. Scienza al servizio del nostro benessere.