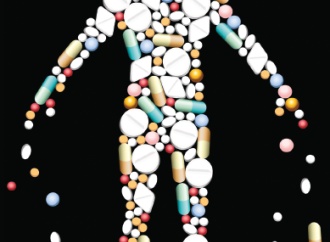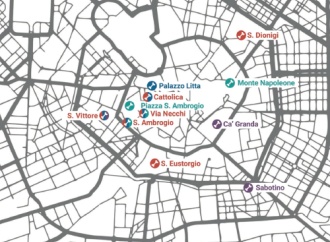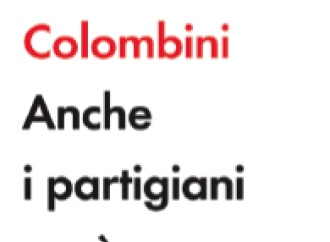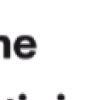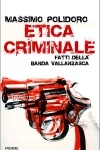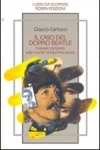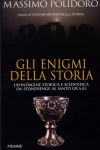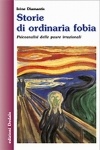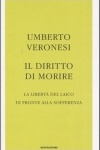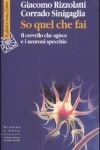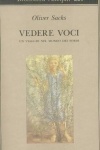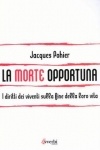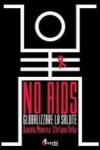Passano altri due secoli. È il 1830, e l’Italia è investita dalla seconda pandemia di colera. La mortalità è comparabile con quella della Morte Nera, ma gli scritti lasciati dai medici testimoniano l’ostinazione nel praticare il salasso, nonostante sia evidente che di liquidi i malati ne hanno già persi in abbondanza. «Le vene sono talmente assottigliate da resistere ai tentativi di trarne sangue», si lamentano i clinici, ma non demordono. Questi esempi, come quelli che seguono, sono la testimonianza dell’atteggiamento mentale che ha rappresentato il maggiore ostacolo alla ricerca delle conoscenze in medicina: considerare un ragionamento più significativo di un esperimento.
Il salasso, codificato da Galeno nel II secolo d.C. in ossequio alla teoria del riequilibrio dei quattro umori (sangue, bile nera, bile gialla e flemma), domina la scena terapeutica sino a metà del XIX secolo, da solo e in associazione con qualsiasi altro trattamento chirurgico e medico: viene usato per curare anche le emorragie. Nel Medioevo, diventa appannaggio dei barbieri, che già fanno estrazioni di denti, incisioni di ascessi e altra piccola chirurgia poiché i medici, diventati dei dotti al pari dei teologi con la fondazione delle università, non possono sporcarsi le mani. Il salasso è così diffuso, e le botteghe così numerose, che a Londra nel 1307 si vieta di esporre alla finestra come insegna il vaso pieno in cui è stato raccolto il sangue, indubbiamente sgradevole alla vista e all'olfatto. La gilda dei barbieri decide quindi che l’insegna sarà un attrezzo usato per praticare il salasso: un palo, con in cima il pomo che il paziente stringe per tenere fermo il braccio durante l’incisione della vena, con delle fettucce rosse avvolte intorno a spirale per richiamare il sangue che defluisce. Con il passare del tempo, l’insegna diventa sempre più stilizzata, finché nei neonati Stati Uniti si aggiungono le strisce blu e si arriva a quella che oggi si può trovare davanti ai barbieri.
Anche nella preparazione e prescrizione dei farmaci ci si preoccupa solo che siano formulati in ossequio alla dottrina degli umori e dei loro equilibri, declinata ora sul principio dei simili, ora su quello degli opposti. Il veleno della peste si elimina con il veleno della vipera e/o dello scorpione, che sono le componenti base del teriaco, o teriaca, un farmaco che viene dall'antica medicina greca ed è il più usato in Europa, in numerose varianti locali, e non solo contro la peste: come il salasso, sarà prescritto sino ai primi dell’Ottocento. Alla carne secca di vipera e/o scorpioni si aggiungono numerosi altri componenti (fino a 64 in alcune versioni) tra cui non mancano mai oppio ed erbe dagli odori fetidi e sapori amari, oltre a una selezione di preziose spezie esotiche. Il tutto viene bollito, mescolato, omogeneizzato e filtrato, nella convinzione che i pezzi di scorpione e vipera diano vigore alla pozione. Il più ambìto nel mondo è il teriaco di Venezia, che viene preparato una volta l’anno in gran quantità in un campo dove si danno appuntamento i farmacisti della Serenissima.
Le prime verifiche
L’efficacia di teriaco e salasso è certificata dalla loro coerenza con le teorie. Qualcuno osserva che durante le epidemie medici e farmacisti muoiono come gli altri, oppure che la mortalità dei colerosi curati è maggiore rispetto a quella di chi non è stato trattato affatto, ma, come tante altre osservazioni che contraddicono le dottrine in voga, nessuno ci fa caso. La prima verifica sperimentale del salasso arriva nel corso della seconda pandemia di colera: la esegue Pierre Charles Alexandre Louis nel 1835 a Parigi. Ne seguono molte altre, stimolate da quanto va predicando Claude Bernard, che nel 1865 formalizza le sue idee nel suo ponderoso trattato Introduzione allo studio della medicina sperimentale. Bisogna sottoporre a verifica sperimentale ogni conoscenza del corpo umano, delle malattie e delle cure, sostiene Bernard, come si fa già nelle altre scienze da Galileo in poi, anche se applicare il metodo scientifico in medicina è molto più difficile che in fisica o in chimica.
I dati che emergono dalle verifiche sono drammatici: in tutte le patologie studiate, tra i salassati si contano più decessi che tra i malati che non hanno ricevuto alcuna cura. Il risultato desta scalpore, qualcuno pensa a quante vittime può aver provocato la procedura da quando la sostenne Galeno. I personaggi illustri che si sospetta siano stati uccisi dai salassi sono molti, tra cui, per esempio, Raffaello e Richelieu; di sicuro ne morì George Washington, sottoposto a salasso per curare la malaria. Tuttavia, nell’immediato le conseguenze pratiche di queste scoperte sono scarse e contraddittorie e il salasso continua a essere eseguito fino alla fine del secolo. Contro il colera invece viene subito abbandonato.
La “peste grigia”
Tra il Quattrocento e il Settecento, secoli martoriati dalle epidemie, il mondo conosce una serie di progressi. Gutenberg, con la stampa a caratteri mobili, rende accessibili a tutti conoscenze vecchie e nuove, idee e informazioni; ci sono il Rinascimento, la riforma di Lutero, la rivoluzione di Copernico. Galileo partorisce la scienza sperimentale (nel 1633 c’è la peste mentre viaggia verso l’Inquisizione a Roma), Newton forgia la fisica moderna (nel 1686 scrive il trattato sulla gravitazione universale in campagna perché a Londra imperversa la peste). Anche le conoscenze di anatomia e fisiologia progrediscono. Vesalio dimostra che l’anatomia di Galeno che si insegna è sbagliata, si capisce come avvengono la circolazione del sangue e la respirazione, a cosa servono i reni e tante altre funzioni vitali. Tuttavia, la pratica della medicina, e in particolare le terapie, rimangono più o meno le stesse: l’approccio alla conoscenza delle cure continua a resistere al metodo scientifico.

Emblematico è il destino opposto di due gravi problemi che funestano l’Era della Vela, gli oltre tre secoli che vanno dal viaggio di Colombo fino alla metà dell’Ottocento, quando i piroscafi sostituiscono i velieri. Uno è un problema medico, l’altro di navigazione, ma solo quest’ultimo viene affrontato in modo scientifico.
Il problema medico è lo scorbuto. Magellano completa la prima circumnavigazione della Terra nel 1522. Partono tre velieri con 232 uomini e ne rientra uno solo con 18 marinai; gli altri due sono stati abbandonati perché sono rimasti senza equipaggio. Ripercorrendo giornali di bordo, relazioni dei medici imbarcati, racconti dei marinai, registri delle marine militari e commerciali alla luce di quello che sappiamo oggi sui sintomi, si scopre che, durante l’Era della Vela, lo scorbuto uccide equipaggi, passeggeri e schiavi dieci volte più che tempeste, naufragi, battaglie, arrembaggi e affondamenti, peste, tifo, vaiolo e colera messi insieme. Emblematico è il bilancio della Royal Navy britannica del 1763. Alla fine della Guerra dei Sette anni, su un totale di 184.899 uomini imbarcati ci sono 49.679 sopravvissuti; 1512 sono morti in battaglia mentre 133.708 sono deceduti per malattie, soprattutto scorbuto.
La “peste grigia”, come veniva chiamato l’effetto della carenza di vitamina C, ferma esploratori e conquistatori, navi mercantili e flotte militari, favorisce nemici e concorrenti, per puro caso rimasti indenni o meno colpiti. Tre secoli in cui una frazione trascurabile e trascurata dell’umanità decide i destini delle nazioni e delinea il mondo com’è oggi. Sarà solo la diffusione del vapore dalla metà dell’Ottocento a far sbarcare lo scorbuto da tutte le navi: i piroscafi abbattono i tempi di percorrenza in mare aperto al di sotto del mese oltre il quale, in assenza di vegetali freschi, compare lo scorbuto.

In mare aperto
I frequenti rifornimenti di frutta e verdura freschi ricchi di vitamina C favoriti dalla navigazione sotto costa praticata fino a Colombo, cessano con le traversate oceaniche. Ci si nutre di alimenti conservati oltre quei 30 giorni di media in cui le riserve di vitamina C si esauriscono e finisce quell’azione antiossidante che protegge l’organismo dall’aggressione dei residui del metabolismo noti come radicali liberi, che sono il principale fattore di invecchiamento precoce alla base di arteriosclerosi, cancro e demenza. Inoltre l’acido ascorbico è indispensabile per la formazione di alcuni mediatori chimici cerebrali che permettono alle cellule nervose di comunicare, oltre che per la sintesi del collagene, molecola strutturale di ossa, cartilagini, legamenti, derma, arterie, vene, capillari e qualunque tessuto del corpo. Così, alla carenza di vitamina C seguono prima disturbi nervosi e dell’umore, poi un lento sfacelo del corpo. Inizia dove il collagene è più rinnovato: i legamenti dei denti, le gengive, il tubo digerente, i capillari, la pelle, oppure dove è prodotto ex novo, come nelle ferite che non si rimarginano più. È uno sfacelo progressivo, un corteo di sintomi diversi uno dopo l’altro, da sbalzi d’umore e irritabilità a emorragie sottocutanee, dai dolori intestinali alle ferite che non guariscono e si infettano. Per i marinai sono devastanti già i sintomi iniziali: malumore, perdita dei denti, gengive gonfie, infiammate e debolezza; è impossibile masticare gallette e carne secca, e non c’è neanche il conforto dell’amato rum perché brucia la bocca.
Nell’Era della Vela, sullo scorbuto si pubblicano dozzine di trattati, per lo più nel Settecento. Dopo lunghe disamine teoriche, la causa è indicata in: miasmi, umidità, freddo, eccesso di bile nera, pigrizia, intossicazione da rame, predisposizione ereditaria, occlusione dei pori della pelle e, ovviamente, l’ira divina, a cui i marinai spesso aggiungevano l’impuro, il posseduto dal demonio che Dio punisce con uragani, bonacce o malattie varie. Altrettanto fuori dalla realtà sono le cure, tutte mai verificate: purghe, acqua di mare assunta via clistere o bevuta in abbondanza oppure somministrata a secchiate sul corpo; sorsate di aceto o di acido solforico diluito, e, se c’era un chirurgo a bordo, l’immancabile salasso. Nonostante la totale assenza di benefici, nessuna di queste cure viene mai abbandonata del tutto.
Un premio sontuoso
Nel frattempo, anche l’altro problema aperto dalle traversate oceaniche sta provocando centinaia di morti. Nel 1707, un’intera flotta della Royal Navy britannica di ritorno dall’America si infrange di notte sulla costa inglese che, secondo i calcoli, avrebbe dovuto essere ben più lontana. I morti sono 1450, le navi affondate 20, persi i ricchi bottini sottratti agli spagnoli. È l’ennesima strage causata dall'imprecisione dei metodi di calcolo astronomici della longitudine che indica la posizione navigando lungo il parallelo, e quindi la distanza dalla costa.
Pochi anni dopo, nel 1714, il governo di Londra scatena la corsa alla soluzione del problema mettendo in palio 20.000 sterline (circa 10 milioni di euro di oggi): il sontuoso premio andrà a chi scopre «un sistema, semplice, pratico, che si dimostri capace di determinare la posizione della nave lungo il parallelo». Nel 1761, taglia il traguardo John Harrison, quando il suo quarto prototipo di cronometro marino arriva in Giamaica dopo tre mesi di navigazione segnando l’ora di Greenwich con uno scarto di quattro secondi, nonostante i beccheggi, rollii e scuotimenti vari trasmessi dallo scafo e le dilatazioni e contrazioni subite dalla meccanica a causa delle variazioni di temperatura. La differenza tra il mezzogiorno locale (il picco di altezza del Sole sull’orizzonte rilevato col sestante) e l’ora segnata sul cronometro, che è quella del luogo di partenza, indica la distanza e quindi la posizione sul parallelo. I quattro secondi di scarto corrispondono a un possibile errore di un miglio scarso, una precisione mai raggiunta prima e più che sufficiente per evitare i naufragi.
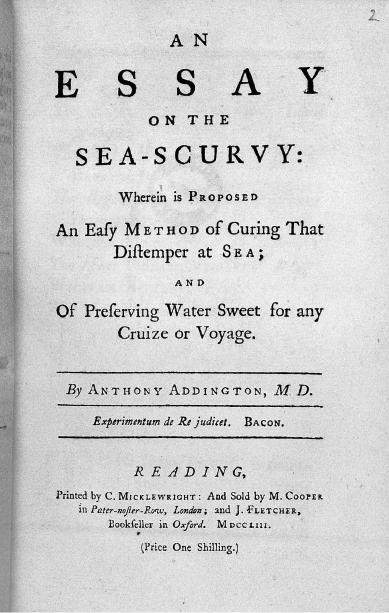
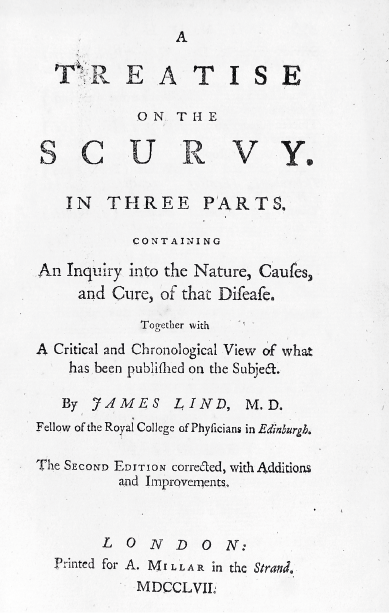
La relazione è ignorata. Ignorata anche la relazione che il medico militare James Lind consegna alla Royal Navy e alla Royal Academy nel 1753. È il Trattato sullo scorbuto, considerato la prima sperimentazione farmacologica della storia. Confrontando le terapie praticate fino a quel momento (dall’acqua di mare ai clisteri di acido solforico diluito), l’unica che si dimostra efficace sono gli agrumi, che, scrive Lind, contengono un principio benefico che deve essere presente in tutta la frutta e verdura fresca. Nel 1776, oltre venti anni dopo Lind, un prestigioso premio scientifico è assegnato a James Cook. Nei tre anni del suo primo giro del mondo compiuto, anche, ironia della sorte, per effettuare ulteriori verifiche del cronometro di Harrison, non ha un malato di scorbuto a bordo: Cook ha finalmente applicato la scoperta di Lind facendo frequenti rifornimenti di frutta e verdura fresche. Ma ancora una volta cambia poco o nulla; bisogna aspettare altri 21 anni perché sia emessa l’ordinanza dell’ammiragliato che impone di imbarcare scorte di agrumi sulle navi militari. È il 1795; passano altri 70 anni e arriva l’ordinanza anche per la marina commerciale. Ma siamo nel 1865, quando ormai i piroscafi non danno più tempo allo scorbuto di colpire.
Dimostrazioni fasulle
La vicenda è emblematica delle anomalie che intralciano l’applicazione della conoscenza in medicina più che in altre aree del sapere. La più importante è l’atteggiamento di fronte al mistero. Diversamente da ciò che accade in fisica o in chimica, un problema medico sconosciuto desta preoccupazione, timore di soffrire, paura per la nostra salute e la nostra sopravvivenza: ansie che diventano insopportabili se, oltre a non capire cosa ci succede, rimaniamo passivi, non sapendo come reagire. Da qui la necessità di fare subito qualcosa, qualsiasi cosa, basta che abbia un senso ai nostri occhi.
Questo apre la strada alle altre due anomalie. La prima è la dimostrazione fasulla. Dopo un miglioramento o una guarigione ne cerchiamo spontaneamente l’origine in un gesto precedente, privilegiando quello che più ha attirato la nostra attenzione. Così finiamo per considerare efficace il farmaco appena preso, magari elaborato con un procedimento suggestivo, complicato e incomprensibile, meglio se amaro e ributtante (come il teriaco), o l’emorragia inquietante del salasso, o altre pratiche sorprendenti e inusuali.
Se si è continuato a praticare questi metodi per secoli è anche perché sono apparsi efficaci, mentre il merito è della natura. Tutte le patologie, infatti, anche le più inesorabili come il cancro, hanno fasi in cui si sta o ci si sente meglio, fasi che dipendono dall’andamento delle malattie, che, come tutti i fenomeni della natura, non sono né lineari né costanti. Sempre alla natura, inoltre, vanno imputate le guarigioni dovute alla capacità dell’organismo di difendersi e ripararsi, che ha la meglio in molti casi. A sua volta, la dimostrazione fasulla portava a ignorare quella vera. Lo dimostra bene la vicenda dello scorbuto, in cui una dozzina di trattamenti strampalati a volte erano comunque seguiti da miglioramenti spontanei, molto frequenti in una malattia lunga e capricciosa come quella. Inoltre, avevano il vantaggio di essere più facili da reperire e conservare in un veliero che sta attraversando un oceano rispetto a frutta e verdura.
Oggi i meriti della natura li conosciamo, ma non ci vengono in mente: a lasciarli in secondo piano è la visione meccanicistica del nostro corpo che abbiamo tutti, anche se la imputiamo solo alla medicina.

Un intreccio fatale
Quando un’automobile ha un problema la portiamo dal meccanico perché non si ripara da sola. Anche per i “guasti” della nostra macchina-corpo ci aspettiamo che qualcuno o qualcosa intervenga, e pensiamo di rado che, in quanto organismi naturali, possiamo autoripararci, e men che meno ci viene in mente che la nostra malattia, in quanto processo naturale, è soggetta ad alti e bassi. Il merito di queste guarigioni va quindi a qualcosa che non c’entra nulla, ed è così che per secoli si sono affermate terapie tanto suggestive quanto poi rivelatesi micidiali una volta sottoposte a verifica, e che oggi resistono trattamenti a cui attribuiamo meriti che non hanno.
Gli antibiotici per “stroncare l’influenza”, come si sente ancora dire, sono l’esempio classico di quanto sia attivo questo intreccio tra dimostrazioni fasulle e visione meccanicistica del corpo che cancella i meriti della natura. Il fenomeno è diffuso, in particolare in Italia, dove abbiamo il record europeo di uso di antibiotici, perlopiù contro l’influenza (che spesso è un raffreddore), nonostante sia dimostrato da quando esistono che non agiscono sui virus: anzi, innescando ulteriori selezioni di ceppi resistenti, contribuiscono al tragico bilancio delle migliaia di morti all’anno causate da infezioni ospedaliere. Ed è un fenomeno così diffuso che per spiegarlo non basta qualche prescrizione fatta per compiacere l’industria farmaceutica. Si continuano ad ascoltare affermazioni come: «dopo una settimana di febbre alta e tosse non ce la facevo più, ma con gli antibiotici finalmente sono guarito», una convinzione che rimane granitica malgrado la spiegazione scientifica - gli antibiotici non uccidono i virus - sia semplice da capire.
Poi ci sono convinzioni come “bere tanta acqua ricca di calcio per la salute delle ossa” e “il pesce contiene tanto fosforo e migliora l’intelligenza” malgrado sia ben noto che aumentare l’introduzione di una sostanza non ne aumenta l’assorbimento. Oppure c’è la galassia delle complicate prescrizioni dietetiche per curare fantomatiche intolleranze alimentari, per non parlare dei classici ricostituenti, oggi diventati integratori. E che dire dell’infilata di luoghi comuni impossibili, oltre che mai dimostrati, come «asciugati i capelli se no ti viene la cervicale» o «se prendo caffè nel pomeriggio poi non dormo», un’insonnia che persiste anche dopo aver appreso che la caffeina di un espresso si elimina in 45 minuti.
Infine ci sono i rimedi che, come il salasso e il teriaco, discendono direttamente da ragionamenti affascinanti articolati intorno a termini evocativi come equilibrio, squilibrio e riequilibrio oppure tossine, intossicare e disintossicare, che in medicina hanno altri significati, diversi e precisi. E tralasciamo gli agguati tesi dagli “spacciatori di miracoli” ai malati di cancro e di altre patologie a lenta evoluzione, che annunciano con largo anticipo la morte, dove non sorprende che venga a mancare il pensiero critico.
La spinta commerciale da sola non spiega la convinzione con cui si continuano ad abbracciare antibiotici contro i virus o diete contro le intolleranze: alla base c’è lo stesso approccio conoscitivo che, fornendo spiegazioni tanto suggestive quanto fasulle, ha evitato per secoli la verifica sperimentale del salasso e delle altre cure. Come quelle spiegazioni, si basa sui fatti più evidenti, inevitabilmente quelli che hanno un contenuto emotivo più forte, e questo basta alla nostra mente per stabilire tra loro una relazione di causa ed effetto.