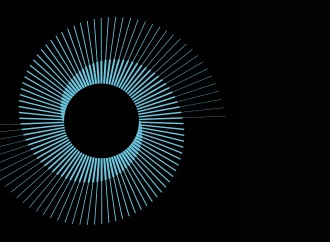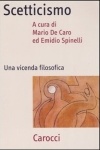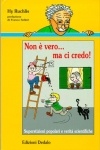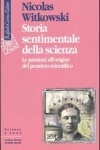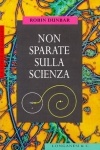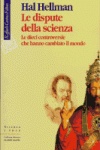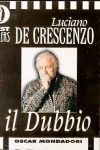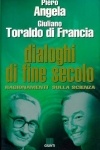Le obiezioni di Lenard ci appaiono oggi chiaramente infondate e furono in gran parte smentite già l’anno successivo con lo spettacolare esperimento di Eddington che misurava la deflessione della luce durante un’eclissi solare totale. Ma sarebbe riduttivo esaminarle soltanto dal punto di vista puramente scientifico, senza considerare la visione del mondo da cui nascevano. Se non conoscete già l’ideologia di Lenard, riuscite a indovinare qual era? Si tratta dell’antisemitismo.
Sostenitore della prima ora del partito nazista, Lenard era un acceso antisemita; nel 1922, da direttore dell’Istituto di Fisica di Heidelberg, si rifiutò di onorare il lutto istituito dalla sua università in seguito all’assassinio del ministro degli esteri, l’imprenditore ebreo Walther Rathenau. Insieme a Johannes Stark, un altro premio Nobel per la fisica, Lenard promosse la “fisica tedesca” o “fisica ariana”, che perseguiva la coerenza con la cultura tradizionale germanica e rifiutava l’astrattezza e il materialismo della “fisica ebrea” di Einstein.
Il legame con l’antisemitismo e il nazismo è essenziale per capire come nascono le tesi di Lenard in campo scientifico, così come la relazione con il materialismo dialettico e lo stalinismo è fondamentale per comprendere quelle di Trofim Lysenko, l’agronomo che impose in Unione Sovietica pratiche agricole pseudoscientifiche basate sul rifiuto della teoria di Darwin, con conseguenze tragiche per la popolazione.
Ai giorni nostri il negazionismo scientifico continua ad avere spesso, anche se non sempre, una forte base ideologica. Il padre di tutti i negazionismi, quello dell’Olocausto, ha radici documentate nel neonazismo e nell’antisemitismo. L’intelligent design, che non è tanto una teoria pseudoscientifica a sé stante quanto una forma di negazionismo dell’evoluzione, nasce dalle organizzazioni della destra cristiana fondamentalista. Il negazionismo del cambiamento climatico è correlato con l’avversione per l'interferenza del governo nelle attività imprenditoriali, mentre quello del Covid-19 è diretto contro l’intervento statale nella salute pubblica.
A volte il rapporto con l’ideologia è più articolato. Per esempio, il movimento contro i vaccini nella sua lunga storia non è stato l’espressione di un sistema di valori univoco, ma è stato associato a una varietà di posizioni differenti e spesso in contrasto tra loro, dall’obiezione di matrice religiosa a una pratica che interferiva con l’ordine naturale delle cose voluto da Dio, alla diffidenza nei confronti degli interessi economici delle aziende farmaceutiche, all’opposizione verso l’intrusione governativa nella privacy dei cittadini con le app di sorveglianza per il Covid-19.
Alle motivazioni ideologiche si possono poi aggiungere altri fattori: per esempio, nel caso del cambiamento climatico sono determinanti gli interessi economici delle aziende di combustibili fossili, così come quelli dell'industria del tabacco hanno avuto un ruolo cruciale nel negare i danni del fumo per la salute.
Spesso il vero obiettivo dei negazionisti, che la storica della scienza Naomi Oreskes ha giustamente definito “mercanti di dubbi”, non è promuovere una propria teoria, come le pseudoscienze tradizionali, ma creare nel pubblico l’impressione di un dibattito aperto, laddove invece la comunità scientifica ha raggiunto un sostanziale consenso intorno a fatti consolidati. La stessa tattica veniva usata negli anni Venti del Novecento dall’anti-relativista americano Arvid Reuterdahl, il quale diffuse negli Stati Uniti il mito che la teoria di Einstein fosse controversa tra gli scienziati, mentre dopo l’esperimento di Eddington era ormai ampiamente accettata.
Perché le tesi dei negazionisti facciano danni, infatti, non è necessario che convincano la maggioranza dei cittadini: è sufficiente che indeboliscano il consenso dell’opinione pubblica, in modo da rallentare o paralizzare le decisioni democratiche, come quelle che riguardano le normative sul fumo o la mitigazione del riscaldamento globale. Nel caso dell’intelligent design, suscitare dubbi sull’evoluzione ha lo scopo specifico di aprire la strada a un cambiamento culturale che sostituisca il materialismo dominante nella società di oggi con una visione religiosa. Gli antievoluzionisti hanno chiamato questo approccio “strategia del cuneo”, perché i dubbi sull’evoluzione sono il cuneo da inserire nel tronco del materialismo per aprire una crepa che ne avvii la distruzione.
Anche se la sfera di competenza del CICAP sono gli aspetti scientifici e metodologici e non quelli ideologici, credo che sarebbe sbagliato ignorare l’importanza di questi ultimi nelle varie forme di negazionismo contemporaneo, proprio come lo sarebbe stato nel caso di Lenard. Come sostiene il filosofo della scienza Sven Ove Hansson, è invece importante mettere in evidenza quali correnti di pensiero e quali interessi si celano spesso dietro i movimenti negazionisti, per mostrare che il loro scopo ultimo non è far avanzare la conoscenza, ma promuovere una determinata agenda politica. Essi stessi capiscono perfettamente l’importanza strategica di questo punto e si guardano bene dal rendere pubblico il proprio retroterra. I sostenitori dell’intelligent design non pubblicizzano certo i loro legami con i movimenti religiosi fondamentalisti, così come i finanziamenti dell’industria fossile agli scienziati che negano il riscaldamento globale non avvengono alla luce del sole. Rivelare al pubblico le strategie usate dalle multinazionali del tabacco per nascondere i danni del fumo per la salute è stato determinante per screditare gli studi da esse finanziati. Allo stesso modo è opportuno sottolineare quali ambienti alimentano oggi il negazionismo in campo climatico e in campo sanitario. Questo non significa tradire l’imparzialità politica del CICAP, ma al contrario denunciare che un dibattito che dovrebbe essere strettamente scientifico è condizionato da fattori di altra natura.
Proprio per migliorare la qualità della discussione su questi temi il CICAP si è fatto promotore, insieme all’associazione di comunicazione scientifica Frame, di un’iniziativa chiamata “Scienza e Politica nell’Interesse dei Cittadini - SPIC” con lo scopo di favorire una comunicazione costruttiva tra i decisori politici e la comunità scientifica, in modo da ridurre il rischio che le conoscenze scientifiche siano distorte per ragioni ideologiche.
Bibliografia
- Sven Ove Hansson, S. O., 2018. “Dealing with climate science denialism: experiences from confrontations with other forms of pseudoscience”, in Climate Policy n. 18
- Godulla, A., Seibert, D., e Klute, T., 2024. “What Is Denialism? An Examination and Classification of Definitional Approaches and Relevant Actors”, in Journalism and Media n. 5