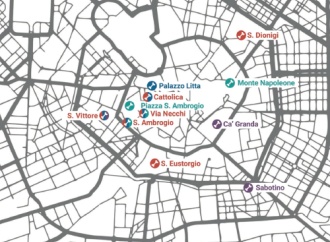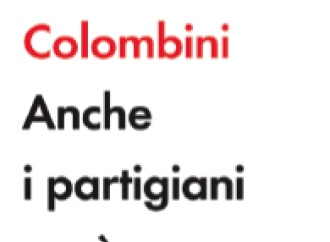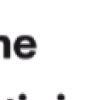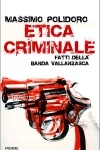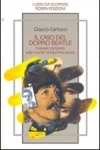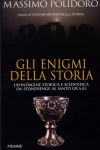Sappiamo che Copernico terminò la redazione del De revolutionibus orbium coelestium già verso il 1530 e che la sua teoria era ben conosciuta dai dotti dell’epoca, grazie anche alla circolazione del Commentariolus, un manoscritto redatto da Copernico prima del 1514. Tuttavia, Copernico non aveva alcuna intenzione di dare alle stampe la sua opera, temendo gravi conseguenze, nonostante le persone a lui vicine, a partire da Tiedemann Giese (vescovo di Kulm dal 1537), lo incitassero a rendere pubbliche le sue idee.
Nella primavera del 1539 giunse a Frauenburg Georg Joachim Rheticus, o Retico, un giovane professore di matematica dell’Università di Wittenberg che godeva della protezione di Filippo Melantone (il praeceptor Germaniae, il maestro di tutta la Germania): nato nel 1514 a Feldkirch nel Tirolo austriaco, la regione che i Romani chiamavano Rezia, Georg aveva latinizzato il suo cognome in Rheticus proprio per ricordare la terra delle origini. Accolto calorosamente da Copernico, Retico studiò in modo attento per circa due anni il De revolutionibus, convincendosi che le nuove idee cosmologiche dovessero essere diffuse in maniera palese. Nacque così la Narratio prima, un sunto del sistema eliocentrico che, con il consenso di Copernico, fu stampato a Danzica nel 1540.
Il testo ottenne un grande successo e molte reazioni favorevoli, tanto che una nuova edizione vide la luce a Basilea nel 1541. Data la situazione, le resistenze di Copernico caddero ed egli acconsentì a far pubblicare integralmente la sua opera, preceduta dalla dedica a papa Paolo III e da una lettera che Nicolas Schönberg, vescovo di Capua, gli aveva scritto da Roma il 1° novembre 1536, esortandolo a pubblicare la sua opera: «Poiché da vari anni tutti mi parlano continuamente del tuo valore, ho cominciato ad averti in grande stima e a congratularmi anzi con i nostri uomini fra cui prosperi con tanta gloria. Ho appreso infatti che non solo sei versato in modo eccellente nelle scoperte degli antichi matematici, ma anche che hai fondato una nuova dottrina del mondo, con cui insegni che la Terra si muove e che il Sole sta nel luogo più basso e quindi nel mezzo del mondo [...] Pertanto, uomo dottissimo, se non t’importuno, ti chiedo instantemente di comunicare agli studiosi questa tua scoperta [...]».
Il manoscritto del De revolutionibus venne consegnato da Copernico a Giese, che a sua volta lo trasmise a Retico, incaricato di farlo stampare a Norimberga. Purtroppo, però, ci fu un imprevisto: nel 1542, Retico dovette trasferirsi all’Università di Lipsia a causa dei problemi relativi alla sua omosessualità che lo perseguitarono per tutta la vita. Egli lasciò così la cura della stampa del De revolutionibus al suo amico Andreas Osiander, un teologo luterano passato alla storia per aver anteposto all’opera una prefazione (anonima, e quindi a lungo ritenuta scritta da Copernico) intitolata Ad lectorem de hypothesibus huius operis, nella quale si invitava i lettori a considerare quelle contenute nel testo soltanto come ipotesi matematiche e non come verità fisiche. Osiander tradì deliberatamente le intenzioni di Copernico, il quale, ormai malato, non poté seguire in alcun modo le vicende editoriali del suo lavoro, che uscì non molto prima della sua morte.
Ecco cosa recitava la prefazione: «Non dubito che alcuni dotti — poiché già si è divulgata notizia della novità delle ipotesi di quest’opera, che pone la Terra mobile e il Sole invece immobile in mezzo all’universo — ne siano rimasti vivamente offesi e giudichino inopportuno turbare le discipline liberali da tempo istituite. Ma se vorranno ponderare esattamente la cosa, troveranno che l’autore di quest’opera nulla ha commesso che meriti di essere biasimato. È proprio dell'astronomo, infatti, mettere insieme con osservazione diligente e conforme alle regole, la storia dei movimenti celesti; poi le loro cause, ossia — non potendo in alcun modo raggiungere quelle vere — escogitare e inventare qualunque ipotesi, con la cui supposizione sia possibile calcolare quei medesimi movimenti secondo i principi della geometria, tanto nel futuro quanto nel passato [...]. Lasciamo dunque che anche queste nuove ipotesi si facciano conoscere accanto a quelle antiche, per nulla più verosimili, tanto più che esse sono insieme ammirevoli e facili, e portano seco un ingente tesoro di dottissime osservazioni. E perché non si lasci questo studio più stolti di quando lo si era intrapreso, prendendo per vere cose preparate per altro uso, nessuno si aspetti dall’astronomia, per quello che si attiene alle ipotesi, alcunché di certo, perché niente di simile essa può mostrare».
Attenzione, però. Queste parole non sono il gesto sconsiderato di un isolato predicatore fanatico: in realtà, l’avversione alle verità del copernicanesimo fu molto forte anche nei paesi protestanti, non solo in quelli cattolici. Massimo Bucciantini ha scritto: «Già nel 1539, in seguito alla divulgazione orale delle tesi copernicane, Lutero aveva rifiutato energicamente la teoria eliocentrica nel corso di una conversazione a tavola, richiamandosi a un passo della Bibbia (Giosué 10, 12-14). Secondo Lutero l’assunto copernicano era determinato principalmente dal desiderio di conseguire la fama attraverso la corrotta cultura contemporanea. Lo stesso Melantone, che pure aveva favorito il viaggio di Rheticus presso Copernico, diede una spiegazione analoga ma senza chiamare in causa le Scritture. In una lettera a B. Mithobius dell’ottobre 1541, quando ormai le idee di Copernico si conoscevano grazie alla pubblicazione, nel 1540, della Narratio prima di Rheticus, scrisse che il moto della Terra era un esempio della tendenza contemporanea a dare una veste dignitosa alle assurdità, perciò il potere politico avrebbe dovuto incaricarsi di reprimere simile petulanza (Profecto sapientes gubernatores deberent ingeniorum petulantiam cohercere). Lo stesso Giovanni Calvino, anche senza far esplicito riferimento alla Bibbia o a Copernico, condannò la tesi del moto della Terra come segno di pazzia e indizio di una natura mostruosa volta a pervertire l’ordine naturale. Nelle sue opere numerose volte fa esplicito riferimento alla centralità e immobilità della Terra come a un fatto indubitabile».
In sostanza, sotto questo profilo, le posizioni dei vertici del mondo protestante furono perfettamente simmetriche a quelle della chiesa cattolica, e ciò ci fa comprendere ancora una volta quanto la storia non possa essere ridotta a ricostruzioni di comodo, posizioni semplicistiche o poco documentate. E come la storia e la comprensione dei libri postumi, non più controllati dal loro autore, possano essere molto accidentate e complicate.
Bibliografia
- Bucciantini, M., 2017. “Riforma protestante e nuova scienza”, in Rendiconti dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, vol. XLI, Parte II, Tomo II
- Ciardi, M., 2013. Terra. Storia di un’idea. Laterza
- Copernico, N., 1975. De revolutionibus orbium coelestium (1543), a cura di A. Koyré. Traduzione di C. Vivanti, Einaudi