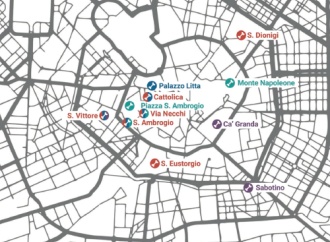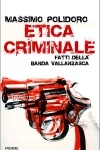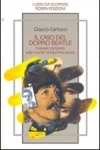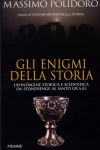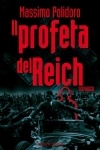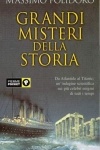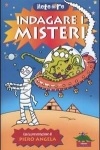Attraverso una documentazione inedita proveniente dall’Archivio apostolico vaticano, dall’Archivio della Congregazione per la dottrina della fede e dall’Archivio romano dei gesuiti, Tutino dimostra che, nell’immediatezza dei fatti, la Curia romana volle evitare «di creare panico inutile e di esacerbare la credulità del suo gregge». Allo stesso tempo, però, nel timore che basarsi «su spiegazioni naturali potesse mettere a repentaglio la fede delle persone», la Curia «cercò di monitorare da vicino la situazione» per «evitare che sia i laici che il clero cedessero a timori superstiziosi», tentando contemporaneamente «di escludere il soprannaturale dal dibattito e anche di verificare i meriti scientifici delle opere prodotte dai membri della Chiesa».
Infatti, mentre il viceré spagnolo non aveva consentito la pubblicazione di una memoria di un astrologo «ripieno di funestissimi presagi, come di peste generali, guerre civili, morte di Re e d’altre sciagure», i censori romani avevano invece chiesto correzioni a un’opera del maggior esponente della comunità scientifica della Compagnia di Gesù di quei tempi, Athanasius Kircher (1602-1680), che insegnava matematica e fisica al Collegio Romano.
Lo studioso aveva scritto quello che oggi chiameremmo un instant book, in cui insisteva sull’origine naturale del fenomeno delle croci, dovute secondo lui ai vapori del vulcano, rischiando però così di diffondere scetticismo sulla fede.
In più, essendo stato scritto nell’immediatezza delle prime descrizioni del fenomeno, il testo si concentrava solo sulle croci sui panni, ma, notavano i censori, la sua spiegazione non teneva conto degli altri posti in cui erano poi apparsi i segni, e quindi c’era il rischio che lo studio apparisse affrettato e che le persone istruite lo deridessero. Più in linea con le aspettative della Curia dovette invece apparire il testo di un giurisperito della burocrazia napoletana, Carlo Calà (1617-1683), che, pur legando anch’egli il fenomeno al vulcano, sottolineava il carattere divino dell’accaduto.
In realtà, quando i due testi uscirono, nel 1661, non era più necessario calmare il popolo napoletano: le croci avevano smesso di apparire ormai da qualche mese e il fenomeno era divenuto materia di studio per eruditi. La ricerca di una spiegazione continuò nei secoli successivi; da ultimo, nel 1972 il vulcanologo Antonio Parascandola (1902-1977) propose che le croci fossero cristalli geminati di pirosseno (in particolare augite) prodotti dall’eruzione vulcanica, individuando anche alcuni panni con segni a forma di croce che sarebbe interessante rintracciare e analizzare[2]. Forse però, anche qui, come in altri casi simili, bisognerebbe aprire una discussione sulla possibilità che, in tutto o in parte, il fenomeno abbia invece avuto una natura psicogena, collegata al trauma dell’eruzione vulcanica vissuto dalla popolazione.