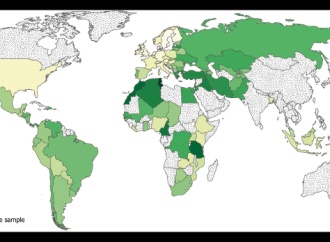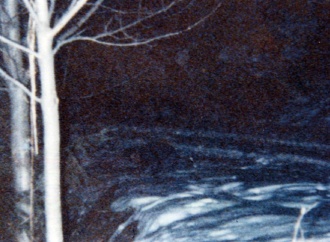La geografia e la storia, basti pensare ai continui spostamenti di confine in tempi anche recenti, spiegano la marginalità del Friuli Venezia Giulia nelle vicende italiane, per cui in passato veniva spesso assimilato al Veneto. Ha acquistato visibilità e un’identità sua propria a livello nazionale in seguito al sisma del 6 maggio 1976 e al modello di ricostruzione post terremoto.
Per secoli ai margini della vita culturale ed economica italiana, la regione è invece molto interessante e articolata dal punto di vista delle tradizioni popolari che rispecchiano la compenetrazione di culture diverse che si sono influenzate a vicenda per secoli al punto che è più difficile che altrove per gli studiosi rintracciare l’origine e l’evoluzione di molte credenze e figure mitiche.
La sua posizione di “porta d’oriente” ha esposto il Friuli a ricorrenti invasioni barbariche e non (Visigoti, Unni, Ostrogoti, Longobardi, Avari, Franchi, Ungari, Turchi) a partire dal 452 fino al 1479, anno dell’ultima incursione turca. Le invasioni hanno lasciato devastazioni terribili, ma anche un ricco patrimonio leggendario. A questo proposito, nella sua raccolta Fiabe Italiane Italo Calvino assegna un posto particolare al Friuli “dove la leggenda pare avere un predominio sulla fiaba”[2].
Il protagonista assoluto delle leggende sulle invasioni è Attila, re degli Unni, non a caso soprannominato Flagellum Dei. Storicamente viene presentato così: “Attila era tozzo e basso di statura. Era abile, astuto, giusto ed implacabile. A differenza di tanti altri condottieri barbari, si dimostrava lealmente misericordioso con le popolazioni che si arrendevano spontaneamente. In ciò si dimostrò migliore di molti condottieri romani, Cesare compreso (autore del genocidio di molte popolazioni), anche se le leggende popolari lo hanno dipinto come un mostro”[3].
Infatti nell’immaginario popolare Attila non solo diventa il prototipo del barbaro feroce, ma anche un essere soprannaturale: Attila era figlio del demonio (in altre versioni figlio di cane), era un mostro col muso di cane, abbaiava tre volte prima di emettere parole umane, portava finimenti d’oro su rozze pelli. Dove passava il suo cavallo non cresceva più erba per sette anni. Sopra la distrutta Aquileia romana fece spargere sale, perché non potesse più risorgere dalle rovine. Si ricorderà che nella mitologia il cane è animale associato agli Inferi.
Secondo un’altra leggenda, Attila ordinò di innalzare un colle da cui contemplare comodamente le fiamme dell’incendio da lui fatto appiccare a quello che rimaneva di Aquileia, compito che i suoi soldati completarono in tre giorni portando la terra nei loro elmi. Il colle, di origine morenica, è quello che si erge isolato nella pianura friulana e su cui sorge il castello di Udine.
Si cerca ancora il pozzo in cui i ricchi Romani assediati da Attila nascosero oro e preziosi. Sembra che fino all’inizio del secolo scorso i contratti di compravendita di terreni nella zona di Aquileia prevedessero una clausola che assegnava al venditore il diritto di proprietà sul fantomatico pozzo d’oro, lo ius putei[4].
Un altro ciclo leggendario molto diffuso in Friuli e più ameno nei contenuti è quello che ha come protagonisti il Signore e San Pietro, sia alle prese con il problema di chi ammettere o non ammettere in Paradiso, sia come viandanti in terra friulana, come già Giove e Mercurio.
Rientra in un filone narrativo comune ad altre località la leggenda del Ponte del Diavolo sul Natisone a Cividale. La storia ci dice che la costruzione cominciò nel 1442 e si protrasse fino all’inizio del secolo successivo. La leggenda racconta che i cividalesi, stanchi dei continui ritardi nei lavori, incaricarono dell’opera il diavolo che assicurò che l’avrebbe costruito in una sola notte e che al risveglio avrebbero trovato un bel ponte nuovo in pietra a unire le alte sponde rocciose. In cambio chiese l’anima del primo essere vivente che fosse passato sul ponte. I cividalesi accettarono ma, a ponte ultimato, vi lanciarono sopra una pagnotta inseguita immediatamente da un cane. Beffato e furibondo, il diavolo scaraventò l’animale sul macigno su cui poggia l’unico pilone centrale, dove lo si può vedere pietrificato. In altre versioni l’animale era un gatto e il macigno era stato gettato nel fiume dalla madre del diavolo che era venuta in loco per aiutare il figlio e aveva trasportato il masso nel grembiule. Ci sono almeno altri tre ponti in Friuli costruiti con simili mezzi ‘alternativi’[5].
Detto per inciso, il Ponte del Diavolo di Cividale è il terzo ponte più bello d’Italia nella classifica stilata nel febbraio 2015 dal sito di viaggi SkyScanner, dopo il ponte di Fermignano vicino a Urbino nelle Marche e quello di Echallod-Arnad in Val D’Aosta.
Passando dalle leggende alle fiabe troviamo in Friuli un’ampia schiera di esseri mitici: orchi, streghe, maghi e maghe, fate, folletti, fantasmi, spiriti e spiritelli, simili per natura, aspetto e funzioni ai loro corrispettivi ad altre latitudini e soprattutto nell’arco alpino.
A questi si aggiungono degli esseri un po’ particolari: i Salvàns e i Pagàns. I due termini vengono spesso usati come sinonimi, anche se il primo di solito si riferisce a misteriosi e selvaggi abitanti dei boschi e il secondo, almeno originariamente, agli abitanti del pagus, il villaggio, contrapposti agli abitanti di città (paganus contrapposto a civis). I Salvàns non sembrano avere niente in comune con divinità della natura, come il dio Silvano o Fauno o Pan, anzi sono presentati come rozzi e primitivi: sono di statura superiore al normale, e questo a scapito dell’intelligenza che è poco sviluppata, non hanno linguaggio umano, sono antropofagi, hanno un fiuto acutissimo, come l’orco, e a volte rapiscono bambini. Salvàns e Pagàns sono pastori, ma rubano nei campi e nei villaggi vicini[6].
Come da tutti gli esseri soprannaturali gli umani si difendono ricorrendo contemporaneamente alla magia e alla religione.
“Sul monte di Cabia in Carnia, un giorno le donne pagane presero a sbertare un boaro che stava pascendo i suoi animali... Conchiusero invitandolo a una scommessa: tornasse in altra giornata con i suoi buoi e il carro; esse vi butterebbero sopra tutte le loro masserizie: se riusciva a condurle via col carro, gliele abbandonavano; ma se il carro non si fosse mosso, egli avrebbe perduto carro e buoi. Il contadino accettò il patto e fissò il giorno. All’alba di questo, prima di aggiogare i buoi, spartì fra loro un granello di fava; saldò il giogo al timone con un chiovolo (cerchio o staffa in cui si infila la testa del timone) e si recò all’appuntamento. Le pagane erano tutte indaffarate a portar fuori cenci, mobili, stoviglie, e caricarono tutto sul carro, ben sicure di vincere la scommessa. Quando fu il momento il contadino, sfidato a dipartirsi, afferra il pungolo, trincia con esso un segno di croce per terra davanti alle sue bestie, poi le sferza gridando:
“ Va, Fiore, va Bruno, né pasciuto, né digiuno,
Chiovolo di viburno, pungolo di corniolo.
Avanti in nome di Dio, ché nessuno vi può far del male.”
E i buoi sollevarono il peso del carro come fosse una piuma, e lo trascinarono diritto a Cabia, lasciando le pagane scornate a strillare e lamentarsi per avere scioccamente perduto il buono e il meglio di ogni loro avere[7].”
La cosa curiosa è che il termine Pagano assume accezioni diverse nei vari momenti storici: viene attribuito inizialmente agli ultimi idolatri, ritiratisi sui monti per sfuggire alle persecuzioni dei cristiani, successivamente a gruppi di Longobardi che all’arrivo dei Franchi scelsero l’"opzione partigiana" e si rifugiarono anch’essi preferibilmente sui monti; sembra che proprio a loro alluda Ottone II nel 981, quando parla della Chiesa di Aquileia “da lungo tempo devastata da pagani e malvagi predoni”. Il termine viene riferito anche a nuclei di Slavi, prima respinti dai Longobardi e poi riammessi a ripopolare zone devastate dalle invasioni barbariche[8].
Salvàns e Pagàns sono esseri ibridi, a metà fra leggenda e favola e Pagano diventa un termine generico per indicare il Diverso, lo Straniero. è significativo che i toponimi legati ai Salvàns o ai Pagàns, numerosi nella zona alpina, non raggiungano la pianura dove la vita era meno dura e dove l’"opzione partigiana" non era facilmente praticabile.
Nella pianura le creature dell’immaginario popolare sono meno terribili e pericolose. Nella Bassa e nella fascia verso il Veneto, è più facile incontrare le fate o favis o fadis o falis (il termine fata è il plurale di Fatum) vestite di bianco che lavano e stendono i panni nottetempo, ballano e giocano con una pallina d’oro. Se si riesce a trovare questa pallina magica, si avrà denaro a profusione e per sempre, purché si mantenga il segreto sulla sua origine. Una ragazza di Cordenons che era in giro a pascolare le pecore vide le fate che giocavano a palla ma che, appena si accorsero di lei, si dileguarono. Nella fretta a una di loro era sfuggita di mano la pallina. La pastorella la cercò dappertutto nell’erba, ma non riuscì a trovarla[9].
Sono in genere amichevoli con gli umani, a volte fanno loro dei regali. A Tiezzo una fata portava del tabacco a un vecchietto. Talvolta gettavano un loro filo alle filatrici che, al mattino, trovavano raddoppiato il filo. A Montereale Valcellina le vedevano le donne che si alzavano alle due, tre di notte per andare a falciare l’erba. Qualche volta capitava che una donna andasse da sola e vedeva le fate che l’accompagnavano per un tratto della salita[10].
“La gente le temeva solo perché “non erano dei nostri”, non erano umane... Nelle Valli del Natisone si sentiva, in certe notti, rumore come di un carro che avanzasse a fatica, cigolando, sulla via. Dove il carro magico dava volta, per tornare indietro, in quella zona ci sarebbe stata, in quell’anno, grande abbondanza di prodotti; inoltre, se uno avesse avuto il coraggio di uscire e gettare su quel carro la sua corona del Rosario, avrebbe conseguito grandi guadagni. Nella fantasia popolare queste presenze sono dunque il filo misterioso che lega la vicenda umana a quella cosmica[11].”
Le fate possono anche essere dispettose, ma in fatto di dispetti il primato spetta ai folletti che normalmente hanno la funzione di aiutanti magici, di gnomi domestici; quando, però, decidono di divertirsi un po’, prendono di mira non solo la gente di casa, ma anche gli estranei. In Friuli hanno una grande varietà di nomi: mazzaròt di bosc, martorel, massariùl, vèncul, skarific’, skrat, sbilf, comparìtul; sono omini piccoli, vestiti di rosso e con una cuffia rossa in capo, qualche volta verde, tutti con un vasto repertorio di scherzi; uno dei più comuni è quello di portare i viandanti fuori strada nottetempo e abbandonarli in mezzo ai campi o ai boschi sigillando l’opera con una gran risata, tanto perché sia chiaro ai malcapitati a chi devono la cortesia. A Concordia è sufficiente calpestare inavvertitamente l’orma del martorel per smarrirsi. è l’unica spiegazione logica della disavventura capitata ad un ragazzo che conosceva a menadito il bosco in cui era andato a far legna e che, presa la via del ritorno al crepuscolo, gira e rigira, si trovava sempre al punto di partenza; finché, stanco morto, si rassegnò a passare la notte su di un albero. Solo la mattina dopo fu capace di uscire dal bosco e tornare a casa[12].
Mentre portano a compimento i loro scherzi, i folletti sono di solito protetti dall’invisibilità, ma hanno anche il potere di trasformarsi a piacimento in oggetti, animali o esseri umani, e questo offre altre allettanti possibilità di prendere in giro gli sprovveduti mortali. A Rigolato il mazzaròt ha l’abitudine di apparire sotto le mentite spoglie di un ubriaco appoggiato con le braccia penzoloni alla spalletta del ponte coperto sopra il paese. Una volta però il passante di turno non abboccò allo scherzo, anzi lo rimproverò aspramente: “Dovevi bere il vino, ma non il giudizio. Non perdo tempo con te, buono a niente!” e tirò dritto[13].
Quando lavorano sono però molto efficienti, come un folletto di nome Tinuniti Tinunai che si era impegnato a tessere in tre giorni la tela per una donna, a condizione che lei scoprisse il suo nome. In realtà era convinto che la donna non sarebbe mai riuscita a scoprirlo. Ma il caso volle che qualcuno lo sentisse canticchiare il suo nome e lo riferisse alla tessitrice in angustie che, rivedendo il folletto allo scadere dei tre giorni, lo salutò con un rispettoso: “Salute, Signor Tinuniti Tinunai!”. Al che il folletto andò su tutte le furie, buttò a terra la tela e scappò pieno di rabbia[14].
Evidentemente il nome è tabù per questo come per altri esseri mitici, in quanto dire il nome equivale a scoprire, a togliere il potere, come togliere la maschera ai mascherati.
Non meno segreti devono rimanere i sabba delle streghe e chi vuole curiosare nelle loro abitudini rischia molto. Si racconta di un bambino irrequieto, Menut, che era sempre in giro a cercare cose nuove e che una notte piano piano andò ad appostarsi sotto la finestrella di una casetta persa in mezzo alla campagna in cui vivevano tre vecchiette in odore di stregoneria (sempre tre come le Parche, le Moire, le Norne, le streghe di Macbeth, ecc.). E vide una gran stramberia: le vecchiette saltellavano per la cucina come cavallette, poi tiravano fuori un pentolino da un armadietto, una alla volta si ungevano i piedi e poi volavano via attraverso la cappa del camino. Menut non raccontò niente a nessuno, ma ogni sera tornava a sbirciare, finché le streghe lo scoprirono, lo portarono dentro e poi con loro in volo a casa di un omone loro amico che aveva la faccia da diavolo. Questo gli tolse le scarpe, gliene fece indossare un paio di ferro e gli ordinò di lavorare per lui e lo avrebbe fatto finché non si fossero consumate le scarpe. Menut piangeva tutte le sue lacrime e lavorava, ma le scarpe invece di consumarsi, sembravano sempre più nuove. Una notte sentì qualcuno battere alla sua finestra: era un giovane con il viso luminoso e vestito di turchino. Era venuto ad aiutarlo: Menut doveva raccogliere una certa erba acidina, darla da mangiare al suo asino e poi mettere le scarpe nell’urina dell’animale. L’urina fumava come se avesse avuto tutti gli spiriti del mondo e le scarpe si consumavano un po’ alla volta. Un giorno finalmente Menut si presentò al diavolo con le scarpe tutte consunte. Il diavolo cominciò a sbuffare, urlare, saltare, pestare i piedi e alla fine sparì in mezzo a un finimondo di fuoco e fiamme. Al suo posto comparve il bel giovane che aveva aiutato Menut e che lo accompagnò a casa da sua madre dopo un lungo viaggio che non finiva mai, con le scarpe di ferro in mano e i piedi scalzi[15].
Le tre vecchiette e il loro amico rientrano nella tradizione dei racconti di stregoneria, ma in questo racconto le streghe hanno anche la funzione di spauracchio per bambini. Col tempo le credenze evolvono e acquistano valenze nuove. Di origine pagana e/o personificazioni delle paure e dei desideri umani, a volte assimilati ad angeli o demoni, gli esseri mitici sono spesso intercambiabili, ambivalenti, benefici o malefici a seconda del contesto o del capriccio del momento. Non a caso nel modello medievale dell’universo non avevano una collocazione precisa, vivevano nel sottosuolo o nella natura selvaggia o in cielo, ma sempre al di sotto del cielo della Luna, cioè al confine fra il mondo materiale e caduco e il mondo spirituale ed eterno.
La difficile convivenza fra paganesimo e cristianesimo viene in superficie nella stessa tradizione popolare: ci sono racconti in cui si parla del Concilio di Trento come punto di svolta a partire dal quale gli esseri mitici escono di scena, perdono i loro poteri, ma non ovunque, o almeno così pare. Anche in questo caso la tradizione popolare non è univoca. In un caso si afferma: “Prima del Concilio di Trento era tutto visibile; adesso è tutto invisibile e se si incappa in questi spiriti, guai! Lo ha detto anche il prete[16].”
Secondo un’altra interpretazione: ‘Quando c’è stato il Concilio di Trento tutte queste porcherie sono sparite. Hanno chiamato tutti i Santi, hanno fatto una gran festa e hanno fatto in modo che non ci siano più queste robe. Infatti non è successo più niente![17]’