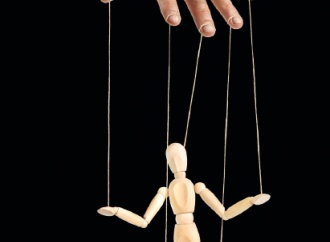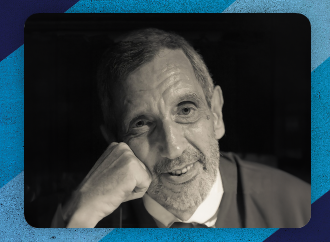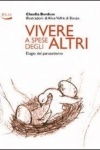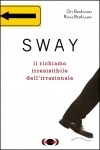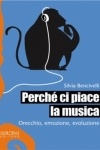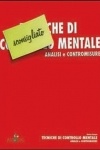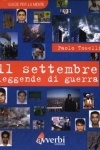La domanda di partenza era questa: perché, se tutte le ricerche indicano che la maggior parte degli americani crede a qualche forma di teoria del complotto, in generale i complottisti hanno una pessima reputazione? Julia P. Prims, docente di psicologia e autrice dello studio, ha avanzato un’ipotesi: esiste una sorta di “cecità della cospirazione” (conspiracy blindness), che fa sì che sia molto difficile etichettare un’idea come cospirazionista se si tratta di qualcosa in cui crediamo.
Per mettere in luce questo meccanismo, Prims ha condotto due esperimenti, ognuno con circa 250 partecipanti, reclutati attraverso il Web. Il primo protocollo di ricerca prevedeva che i soggetti leggessero una ventina di articoli di news che potevano includere o meno una teoria cospirazionista (per esempio, l’idea che il 5G sia pericoloso per la salute o che l’epidemia di Covid-19 fosse usata per rendere obbligatorio il riconoscimento biometrico). I partecipanti dovevano valutare la propria fiducia in ciò che avevano letto e poi decidere se l’articolo conteneva o meno una teoria del complotto.
I risultati hanno messo in evidenza l’esistenza di una “cecità della cospirazione”: più il soggetto era convinto che la teoria descritta fosse autentica, più gli era difficile riconoscerla come complottista. E questo era vero indipendentemente dalle posizioni politiche: sia che i partecipanti si definissero come “conservatori” sia che si definissero come “liberali”, tendevano a comportarsi allo stesso modo. Il software utilizzato per la somministrazione del questionario misurava anche i tempi di risposta: tanto più la decisione era presa rapidamente, tanto più le teorie del complotto venivano etichettate in maniera erronea.
Nel secondo studio, Prims ha replicato i risultati del primo utilizzando, al posto delle notizie, delle brevi affermazioni scritte intenzionalmente per contenere o meno teorie complottiste. Questa volta, però, ha introdotto una variante: prima del test, ha fornito a metà dei soggetti una definizione di teoria del complotto a cui attenersi, basata su tre elementi: (1) un gruppo di persone potenti sta lavorando insieme per raggiungere un obiettivo, (2) mentre tenta di mantenere segreta la propria attività e (3) agisce a spese degli altri. Tutti i soggetti dovevano decidere se questi tre elementi erano presenti nelle affermazioni lette; ma quelli a cui era stato detto precedentemente che quella era la definizione di “teoria del complotto”, tendevano a identificare le cospirazioni come tali, mentre quelli a cui non era stato detto avevano una maggior probabilità di sbagliarsi.
Questi risultati sembrano quindi suggerire che una maggior informazione su cos’è una teoria del complotto può aiutare a ridurre la conspiracy blindness, rendendoci tutti più consapevoli di quanto siano comuni credenze di questo tipo. Ma attenzione: identificare in maniera corretta una teoria del complotto non significa diminuire l’adesione a quella determinata teoria. In altre parole, riconoscere le proprie convinzioni come “cospirazioniste” non riduce affatto la fiducia in quelle credenze.