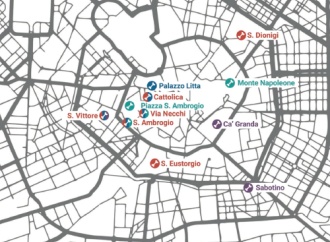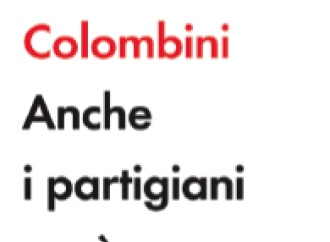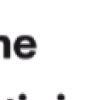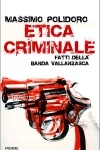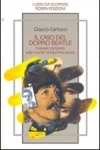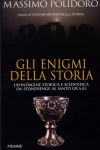La definirei usando le parole di grandi storici che hanno affrontato questo tema. Per esempio, Carlo Ginzburg, in un suo saggio — intitolato non a caso Rapporti di forza. Storia, retorica, prova [Quodlibet, 2022] — attribuisce alla verità storica tre caratteristiche fondamentali, che chiama appunto storia, retorica e prova. La storia è l’evento che vuoi raccontare, la retorica è la capacità di convincere con cui lo racconti e infine c’è la prova, cioè la prova documentale. Il problema è che in questa sequenza, secondo Ginzburg, il termine attualmente meno ovvio è l’ultimo, la prova. Per citare testualmente, «la contiguità largamente accettata tra storia e retorica ha spinto ai margini quella tra storia e prova», vale a dire che «l’idea che gli storici debbano o possano provare alcunché sembra a molti antiquata se non addirittura ridicola». In altre parole, elementi esterni alla verità storica oggi pesano a tal punto che a volte la prova è un elemento ingombrante della ricerca.
Una definizione molto importante arriva poi da un grande storico del passato, Leopold von Ranke, che è fondamentale per gli storici che fanno ricerca seguendo i criteri appena elencati, e mi ci includo anche io e tutta la componente che fa riferimento a Renzo De Felice. Nel primo ventennio dell’Ottocento, Von Ranke affermò che la storia è una disciplina autonoma dalla politica. Fu il primo ad affrontare la ricerca della verità storica mettendo da parte quelle che invece fino ad allora erano state altre esigenze, per cui si considerava la storia come un’ancella della politica, che se ne serviva per i suoi fini. Von Ranke è il fondatore della moderna ricerca storica, è a partire da lui che la storia acquista quell’autonomia che la rende una disciplina a sé, una disciplina scientifica in senso moderno. In questa prospettiva, la verità storica è ciò che si propone alla fine di un percorso di ricerca.
Come si procede in questo percorso?
Come fa qualunque scienziato che affronta un problema. Si comincia dai “perché”; ci sono problemi irrisolti, lo storico li analizza e ci costruisce attorno un proprio percorso di ricerca. è un percorso che parte anche da ipotesi, ma sono ipotesi che vanno verificate, e il punto fondamentale è che vanno verificate attraverso la ricerca delle prove. È quella che Ginzburg chiama la prova fondamentale, che viene sempre più accantonata a vantaggio della retorica, cioè a vantaggio della capacità di convincere attraverso l’efficienza e l’efficacia della narrazione.
Qual è il ruolo delle fonti in questo percorso di verifica?
Le fonti sono fondamentali. Se escludi le fonti puoi raccontare qualsiasi cosa. Un esempio importante e drammatico è quello di via Rasella. Malgrado la prova inequivocabile - il manifesto affisso su tutti i muri di Roma - che l’ordine delle esecuzioni era già stato eseguito, partì immediatamente una narrazione, a cui molti continuano a credere, secondo cui l’eccidio delle Fosse Ardeatine sarebbe stato evitato se i responsabili dell’attentato si fossero consegnati. In questo genere di casi, l’esigenza sociale, di gruppi o settori dell’opinione pubblica, è tale che anche se si viene messi di fronte a prove evidenti è preferibile accettare l’altra verità. C’è una verità per così dire “sociale”, che risponde ad altre esigenze, che nulla hanno a che vedere con la verità storica.
In un periodo in cui è sempre più difficile riconoscere il falso, come si determina la validità delle fonti storiche?
Anzitutto, bisogna fare una distinzione tra i vari rami della storia. La storia antica ha un suo tipo di fonti, io parlo invece della storia contemporanea che, paradossalmente, esubera di fonti. Ce ne sono persino troppe, e talvolta contraddittorie, per cui il percorso di uno storico contemporaneista comporta immergersi in un oceano di documenti dove è possibile trovare un po’ di tutto e il contrario di tutto. Se questi documenti, queste carte, vengono estrapolati dal contesto, possono essere spesso interpretati in una maniera che nulla ha a che vedere con la ricerca storica: ci sono storici che trovano una “carta”, la tolgono dal contesto in cui è stata prodotta e ci costruiscono sopra delle verità talvolta molto lontane da quella storica.
I documenti quindi ti portano negli archivi, che sono l’ambiente naturale di lavoro dello storico, potremmo dire il suo habitat. Poi ci sono anche le carte private, i fondi privati, che però hanno le loro insidie, perché il personaggio che muore e lascia le carte è raro che non ne abbia fatto prima una bella scrematura. Faccio l’esempio di Ignazio Silone, che ha cominciato a fare la spia per la polizia politica, sia pure a modo suo, nel 1920, nel periodo prefascista e poi con il fascismo, smettendo una decina di anni dopo: stranamente, le carte che ha lasciato partono dal 1930. Su questo c’è stata una polemica accesa perché chi sostiene la “purezza” di Silone non va a cercare negli archivi le carte prodotte da chi lo dirigeva, ma si limita a quelle lasciate da lui.
Non è un caso unico, vale per molti personaggi di cui conosciamo la storia, anche controversa e piena di ombre. Un altro caso tipico è l’archivio personale lasciato da Andreotti all’Istituto Luigi Sturzo. Sono carte importanti, senz’altro, ma si capisce che c’è stata una mano che ha deciso cosa mettere e cosa no. Personalmente, capisco l’esclusione delle carte che riguardano la sfera più privata, ma anche qui bisogna fare attenzione: che cos’è pubblico e che cos’è privato quando si tratta di un personaggio pubblico?
Come si difende lo storico in questi casi?
Si difende integrando quei documenti con quelli che trova in altri archivi. Ho citato il caso di Andreotti, ma ce ne sono molti altri. E non voglio affatto minimizzare l’importanza delle carte di Andreotti o di altri fondi analoghi perché comunque costituiscono una base su cui costruire una riflessione e un percorso di ricerca.
Quali sono le attenzioni che deve usare uno storico nell’esaminare un documento?
Siamo tutti consapevoli che un documento può essere interpretato, a volte anche in malafede. Una cosa che mi diceva De Felice quando cominciavo a fare ricerche in archivio era che un documento, alla fine, è un pezzo di carta: ti parla se gli sai fare le domande giuste. Se gli fai quelle sbagliate, il documento è muto oppure non capisci cosa ti sta dicendo. Quello che conta, quindi, è come arrivi al documento, con quale capacità di formulare le domande giuste. Il documento è importante, ma da solo dice poco.
Per esempio, nel breve periodo dell’epurazione, subito dopo la guerra, vari dirigenti dell’OVRA si scagionarono grazie alla testimonianza di alcuni ebrei amici che avevano aiutato a nascondersi. Erano fatti veri, ma in effetti durante le leggi razziali e l’occupazione nazista si erano resi responsabili di persecuzioni contro gli ebrei ben più gravi. Le faccio un altro esempio abbastanza clamoroso. Tra i martiri delle Fosse Ardeatine, ce n'è uno che fece la spia per parecchi anni, mandando in galera diversi compagni. Negli ultimi tempi fu agganciato dai servizi segreti americani, e si mise al loro servizio; poi cadde in mano ai tedeschi e fu ucciso insieme agli altri. In un caso simile, che facciamo? Vogliamo dire la verità, oppure prendiamo solo l’ultima fase della sua vita? Per carità, vera anche quella, ma non è la storia completa.

Di fronte a situazioni di questo genere, come deve comportarsi lo storico?
Non bisogna confondere la verità con il giudizio, il compito dello storico non è giudicare. Sempre De Felice, diceva che in fondo lo storico non deve rispondere a tante domande, ma a due soltanto: la prima è che cosa è successo, cioè descrivere come sono andate le cose — il che già non è facile — e l’altra è perché sono andate così.
Lei sta descrivendo un percorso complesso, ricco di insidie e di pressioni esterne. Crede che sia possibile arrivare a una verità storica che abbia la stessa solidità a cui si arriva, per esempio, in una disciplina scientifica come la fisica?
Qualcuno ha paragonato la ricerca storica a un carciofo, di cui togli via via le foglie per arrivare al cuore. La ricerca storica è così: si avvicina alla verità per approssimazione progressiva. Può accadere che i primi studi siano solo un’approssimazione, un avvicinamento alla verità, però costituiscono la base per ulteriori ricerche. Come nella scienza, magari si parte da un’intuizione iniziale, che però indirizza la ricerca, fa capire che si può andare in quella direzione, e con la forza di quella intuizione altri storici poi vanno avanti.
Quindi si tratta di un percorso che prosegue nel tempo, le cui conclusioni possono cambiare?
Possono sicuramente cambiare. Prendiamo la monumentale storia di Mussolini di De Felice, che poi è la storia del fascismo. Quando è uscita ha fatto molto clamore [NdR: il primo libro dell’opera fu pubblicato nel 1965], ci furono enormi polemiche e attacchi feroci. All’epoca, De Felice fu accusato addirittura di essere un fascista, ma adesso non si può prescindere dai suoi lavori. Oggi, se ti avvicini al fascismo e non tieni conto del lavoro di De Felice, la storia del fascismo torna a essere una storia vaga, molto generica, fatta di episodi: priva di quella consistenza unitaria che ti fornisce l’opera di De Felice con i suoi otto volumi della storia di Mussolini dagli esordi fino alla fine. A tutti gli storici è chiaro che bisogna partire da lì. Poi, con le ricerche successive, si possono cogliere anche le inesattezze, le interpretazioni errate di aspetti del fascismo. Io stesso ho scritto un lungo saggio su revisionismo e fascismo in cui, benché De Felice sia il mio maestro, coglievo delle carenze nel suo lavoro: carenze che senza dubbio c’erano, ma che la ricerca successiva ha affrontato e sta affrontando. Questo fa sì che oggi abbiamo una visione del fascismo che non voglio definire “scientificamente” esatta, ma certamente solida.
Ancora a proposito di fonti. Abbiamo parlato di documenti, ma che valore ha il testimone, la persona che “c’era e ha visto”, nella ricerca storica?
Il testimone può essere testimone della propria piccola esperienza, di quello che gli è capitato. Per capire la Shoah, per esempio, quello che ci racconta Liliana Segre è utilissimo. È la sua esperienza personale. Sappiamo che c’è stata, sappiamo che si è mossa secondo certe modalità, e la sua esperienza ci dà tutta una serie di riferimenti che sono di carattere più ampio. Poi però per capire il fenomeno della Shoah anche dal punto di vista di come si è sviluppato agli occhi dei nazisti, che pure è importante, devi andare negli archivi tedeschi e in quelli italiani della Repubblica Sociale. Devi ampliare l’orizzonte, perché altrimenti quella testimonianza, di per sé, può essere smentita in malafede e contrastata personalmente cercando di diffamare la fonte. Quella testimonianza, quella fonte, deve essere inserita in un’architettura più ampia.
Un’ultima domanda, legata ad alcune recenti polemiche sull’insegnamento della storia e sull’infiltrazione di propaganda putiniana in alcuni libri di testo. Che cosa si può consigliare ai docenti che devono scegliere un libro di storia per le loro classi?
Oggi è senz’altro un compito difficile. Questa non è la sede per parlarne in modo approfondito, ma una cosa che non abbiamo detto è che attualmente esiste una crisi della ricerca storiografica. Sono venuti a mancare i grandi guru, grandi storici come Romeo, Scoppola, lo stesso De Felice, o anche Paolo Spriano, che rappresentavano dei punti di riferimento di grande onestà intellettuale per chi voleva fare ricerca storica. A questo va aggiunta la crisi dell’editoria, che ci riporta al discorso che abbiamo fatto all’inizio sul primato della retorica, della narrativa: la caccia alle vendite premia chi sa raccontare meglio, chi è più avvincente, al di là della verità storica. Intendiamoci, i libri seri, dal punto di vista della serietà storica, ci sono. Ma sono i docenti che devono costruire un proprio percorso di studio che li renda capaci anzitutto di evitare negazionismi vari e poi di arrivare a comprendere quali sono i nodi storici e chi ha tentato di risolverli seriamente. È a loro che spetta in primo luogo la responsabilità di studiare la storia, con tutte le sue controversie e i suoi nodi.
Insomma, spetta agli insegnanti, non al ministero?
Per carità, agli insegnanti! Al ministero mai! Se no, torniamo al Minculpop, ritorniamo al fascismo, con il ministero che diceva questo sì questo no, questo non lo pubblicherai perché non ci piace, ma pubblicherai quest’altro che ci piace molto.