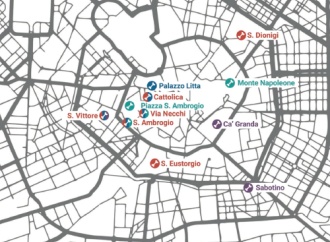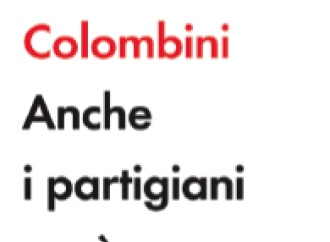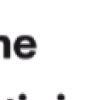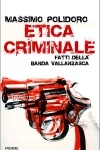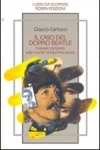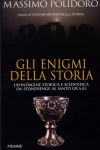I giornali del passato sono ricchi di racconti come questo e di altre “notizie e storie strane”: aneddoti, leggende contemporanee (dell’epoca), rielaborazioni di motivi folklorici da parte di scrittori, storie di fantasmi e resoconti di altri fenomeni insoliti, vere e proprie bufale giornalistiche (le fake news, se proprio le vogliamo chiamare così, non sono nate oggi). Non sempre è possibile distinguere l’una dall’altra: il giornalista che per primo raccontò la storia di Cekcyn, si era inventato tutto, ricamando su un motivo folklorico, oppure aveva solo raccolto una voce che stava circolando autonomamente? Rispetto ad un tempo, però, oggi è più semplice indagare il retroterra di questo genere di testi, grazie ai progetti di digitalizzazione di questo tipo di fonti, che si stanno sempre più diffondendo.
È improbabile che chi ha realizzato Retronews.fr, The British Newspaper Archive (i motori di ricerca a pagamento rispettivamente realizzati in collaborazione con la Bibliothèque nationale de France e la British Library), e i tanti altri servizi simili che sono sorti negli ultimi quindici anni, abbia pensato ai tanti folkloristi e studiosi di storia dell’anomalistica che li avrebbero utilizzati[3].
Odkrywka (lett. “affioramento”), il sistema presentato nell’articolo che gli autori stanno sviluppando presso l’Università Adam Mickiewicz di Poznań, in Polonia, è in questo diverso. In effetti, Discovermat, questo il nome in inglese, è più un meta-progetto: raccoglie infatti le scansioni di oltre tre milioni di pubblicazioni polacche (principalmente numeri di quotidiani e riviste) del XIX e XX secolo, realizzate da una serie di istituzioni pubbliche e private. Un motore di ricerca permette ricerche full-text all’interno dei quasi cento miliardi di caratteri del corpus: “[l]o scopo principale delle analisi condotte attraverso [il suo] utilizzo [...] è quello di cronologizzare, e dove necessario, retrodatare [...] unità di linguaggio [...]. Discovermat non è solo uno strumento utile per analisi linguistiche, ma anche per analizzare la storia, la cultura e la società polacca”[4]. Graliński si interessa di leggende contemporanee fin da quando era uno studente universitario e nel 2012 ha anche pubblicato un libro sull’argomento: l’articolo è quindi l’occasione per evidenziare, attraverso una serie di esempi relativi al periodo fra le due guerre mondiali alla maniera di quello citato all’inizio, come Odkrywka e sistemi simili possano essere utili per ricercatori interessati a storie insolite.
Proviamo a farlo anche noi, ricordando qualche caso in cui negli ultimi anni strumenti del genere hanno, ad esempio, permesso di indagare l’origine di una serie di storie ambientate nella Francia della seconda metà dell’Ottocento.
La prima è “The vanishing lady”: la storia di una donna scomparsa da un hotel parigino nel quale tutti negano di averla mai vista. A testimoniarne la diffusione, il fatto che fra i folkloristi ha un vero e proprio numero di motivo, Z552*(a). Secondo le ricerche di Bonnie Taylor-Blake e “Garson O’Toole” sarebbe apparsa per la prima volta nel novembre del 1897 in un pezzo di una giovanissima Nancy V. McClelland (1877-1959) pubblicato su diversi quotidiani statunitensi, spesso con una prefazione “editoriale” che ne specificava l’autenticità...[5]
La seconda ha a che fare con il sottoscritto. Mentre stavo leggendo in anticipo un saggio di Simon Young[6], poi dato alle stampe anch’esso sull’ultimo numero di Contemporary Legend (e di cui forse torneremo a parlare), mi sono accorto che una storia relativa ad “un’autentica apparizione di Satana” comparsa in diversi quotidiani britannici dell’ottobre 1888 era la ripresa di un racconto di “X.L.” (lo scrittore statunitense Julian Osgood Field, 1852-1925) pubblicato poco prima sul Blackwood’s Edinburgh Magazine: anzi, già nel 1877 una versione anonima era stata stampata sul newyorkese The Galaxy.
Infine, più di recente, sul sito del Centro per la Raccolta delle Voci e Leggende Contemporanee (CeRaVoLC), Sofia Lincos e Giuseppe Stilo hanno identificato la probabile fonte di un’altra narrazione che ebbe un certo successo sui media internazionali alla fine dell’Ottocento, quella della “dama della chiave”: un articolo di “Paul Gravier” (il librettista di origini napoletane Achille de Lauzières, 1818-1894) pubblicato sul quotidiano conservatore di Parigi La Patrie nel marzo 1870...[7]
Interessanti scoperte, che hanno a che fare con la circostanza che sui quotidiani dell’epoca spesso si riprendevano notizie provenienti dall’estero, anche a mesi e anni di distanza dalla prima pubblicazione, con o senza rielaborazioni e, a volte, con la perdita dei riferimenti originali.
Ma tornando all’articolo dei ricercatori polacchi, uno degli altri esempi che presentano sembra essere l’esatto contrario di quanto abbiamo appena esposto. Nel maggio del 1925, alcuni quotidiani riportano della scoperta di una “piccola straordinaria creatura, metà uomo, metà animale” in una miniera di Coleford, in Inghilterra. Tre di questi dicono anche di aver tratto la notizia da un giornale estero, il parigino Le Matin («con il desiderio di renderla vera»). Un racconto incredibile, frutto di folklore o di una bufala giornalistica, che si può ipotizzare essere giunta in Polonia dalla Francia e indirettamente dall’Inghilterra. Quando però Graliński e collaboratori hanno voluto verificare la cosa sui giornali esteri, hanno scoperto che non sembra essercene traccia al di fuori di quei quotidiani polacchi. Fu una storia inventata lì in cui i riferimenti “internazionali” dovevano servire a rinforzarla e a ostacolare verifiche? Possibile. Ma non possiamo averne la certezza.
Le nostre potenzialità di ricerca sono, infatti, molto superiori rispetto a vent’anni fa ma, come gli autori sottolineano nelle conclusioni, per avere più risultati e più accurati è necessario che i processi di digitalizzazione vadano avanti, in modo da archiviare sempre più materiale. In Polonia, e altrove: «i motivi folklorici sono spesso non limitati a una particolare nazione o area, perché la folkloristica computazionale si possa sviluppare nella direzione desiderata [...] sforzi di digitalizzazione analoghi necessitano di essere portati avanti su una più ampia scala dai singoli Stati, per aumentare lo standard dei risultati in termini sia qualitativi che quantitativi». Se sarà così, in futuro si potrà pensare alla creazione «di uno strumento che permetta ricerche su molte lingue contemporaneamente, espandendo sostanzialmente i metodi di ricerca tradizionale».
Nel medio periodo, aggiungiamo qui su Query, potrebbe essere utile che accanto agli interessantissimi studi di casi di cui abbiamo visto alcuni esempi (approccio “micro” o qualitativo), siano sviluppabili anche “macroanalisi” (quantitative) attraverso algoritmi informatici. Queste potrebbero, ad esempio, riguardare il vaglio di tutte le notizie e storie “strane” di un determinato periodo, per individuarne le caratteristiche costanti e le differenze dovute ai singoli autori, alla tipologia o al luogo di pubblicazione[8]. Sono ricerche che, nel campo delle digital humanities, già oggi vengono effettuate su altri tipi di testi, e probabilmente fornirebbero risultati interessanti anche per noi.
Si desidera ringraziare Marco Ciardi e Alessia Donzelli per aver riletto precedenti versioni di questo pezzo.